Globalizzazione è un termine alla moda, anche impegnativo, ma molto elastico, dai mille usi, soprattutto dalle mille interpretazioni possibili. Per cominciare, conviene leggere la definizione che, in termini ufficiali, ne dà l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE):
«Un processo attraverso il quale mercati e produzione nei diversi paesi diventano sempre più interdipendenti, in virtù dello scambio di beni e servizi e del movimento di capitale e tecnologia».
Dizionari recenti che riportano il termine nell’accezione economica aggiungono che tale processo è dovuto anche allo sviluppo delle reti informatiche e della comunicazione[1]. Ovviamente non ci si può fermare alla definizione se si vuole sapere come e perché produzione e mercati diventano sempre più interdipendenti; come e perché beni, servizi, tecnologia e capitali, scambiandosi più di un tempo oltre i confini dei singoli paesi, spingono a forgiare un concetto nuovo, questa fantasmatica globalizzazione, definita da un vocabolo che suggerisce un sopraggiunto cambiamento qualitativo.
A parte la definizione, il termine in sé è corretto anche secondo la nostra analisi in quanto il Capitale tende effettivamente ad avere effetti globali su tutta la società umana da quando si è presentato sulla scena storica in quanto tale. Ma nel mondo borghese la definizione prende il sopravvento e tutti quanti trattano il termine coerentemente ad una visione volgare della stessa società borghese, che viene trattata più come una fiera generalizzata, che come laboratorio sociale. Per esempio, l’accademica di Harvard, Rosabeth Moss Kanter rafforza il concetto dell’OCSE riducendolo ai minimi termini: il pianeta si sarebbe oramai trasformato in un unico, vastissimo supermarket, dove ciascun capitalista può trovare, con poca spesa, tutto ciò di cui abbisogna. Anche l’editorialista Peter Martin, in un dibattito con «Le Monde Diplomatique» (giugno 1998), non riesce ad evitare l’apologia del libero mercato capitalistico, paludandolo da nuovo umanitarismo, con toni che non possiamo rinunciare a gustare insieme con il lettore:
«La globalizzazione costituisce un’autentica collaborazione delle società e delle culture, contrariamente alle collaborazioni fittizie dei dialoghi Nord-Sud e delle élite burocratiche. Le sue virtù sono straordinarie: ha provocato un enorme miglioramento del benessere umano nelle società che hanno saputo cogliere le occasioni che offre. Sotto il suo impulso, il potere si sposterà irresistibilmente dai paesi sviluppati al resto del mondo. L’economia liberista di mercato è per natura globale. Rappresenta ciò che vi è per natura globale. Rappresenta ciò che vi è di più compiuto nell’avventura umana».
È vero, nell’ambito del capitalismo le merci abbattono più muraglie cinesi di tutte le artiglierie del mondo, ma occorre indagare sul significato di quel benessere disponibile per i paesi che abbiano saputo cogliere l’occasione. Come se i paesi, anche i più importanti, potessero fare quel che vogliono. Brutalmente e più sinceramente, il presidente del colosso multinazionale ABB e propugnatore dell’AMI (Accordo Multilaterale sugli Investimenti) afferma con marcato volontarismo:
«Vogliamo investire dove vogliamo, il tempo che vogliamo, per produrre cosa vogliamo, approvvigionandoci e vendendo dove vogliamo e sopportando il minor numero possibile di obblighi (sociali, fiscali, ecologici)».
Ecco come possiamo tradurre: il Capitale ha sempre di fronte un ventaglio di possibilità, e i suoi funzionari, in base ad esse, possono farsi i conti e decidere dove e come intervenire; ma i frutti della globalizzazione sono raccolti da quei paesi che hanno potuto, più che saputo o voluto, nella concorrenza spietata, attrarre capitali sul loro territorio con condizioni favorevoli. Sappiamo cosa questo comporta, senza che il soprannominato presidente multinazionale entri nei dettagli: governanti e sindacalisti non fanno che ripetere agli operai di starsene buoni affinché non sia minata la fiducia dei mercati nel paese in cui lavorano. Il fatto è che con la globalizzazione il salario medio in un determinato paese si confronta immediatamente con quello di altri paesi e la tendenza al livellamento si fa più forte.
È solo dopo aver fatto queste considerazioni che possiamo scendere nei particolari e aggiungere l’ovvio: un paese come gli Stati Uniti avrà certamente più possibilità di intervenire nelle regole del gioco che non, ad esempio, la Romania. Rovesciando la questione entreremmo nel campo dell’antimperialismo di maniera e, attribuendo volontà agli uomini di stato più che al Capitale autonomizzatosi, potremmo scendere in piazza al grido di yankee go home. Non saremmo così tanto diversi dagli Yankee, che hanno avuto come nemico il Tedesco e il Nipponico, l’Impero del Male e il Grande Satana, il Terrorista e l’Integralista: mai l’avversario economico, sempre quello morale.
Sono un buon esempio i moralisti socialisteggianti che gravitano intorno a «Le Monde Diplomatique». Essi vivono nella lagna perpetua e sostengono che il risultato pratico della globalizzazione è una Géopolitique du Chaos dove diventa più agevole lo spadroneggiamento dell’America e del Fondo Monetario Internazionale, che intervengono a modo loro, per esempio tramite la NATO come nei Balcani, per controllare la situazione. Ovviamente in questo modo hanno sempre ragione, perché è vero che l’America spadroneggia, che il caos incombe e che la NATO interviene. Ma registrando semplicemente un dato di fatto visibile non si procede granché nella comprensione dei fenomeni. Questo lo sa fare anche il superspeculatore George Soros, quando mette in guardia nientemeno che l’umanità intera contro il capitalismo globale selvaggio. Detto per inciso, almeno Soros basa la sua morale su solidi fatti economici: essendo un «operatore» che si libra ad altezze stratosferiche rispetto al parco buoi delle Borse, egli sa bene che la grande speculazione dà grandi risultati quando ha come obiettivo i sistemi rigidi di controllo statali o internazionali dell’economia (e quando riesce a vincere, naturalmente)[2].
Abbiamo assegnato al termine globalizzazione l’epiteto «fantasmatico» in quanto, al livello cui normalmente è trattata, non vi sono novità qualitative rispetto al capitalismo del tempo di Marx e il termine andrebbe collocato fra altri fantasmi del lessico dominante. In realtà, la parola di questi aedi e ideologi borghesi rappresenta il riflesso di un fenomeno profondo, anche se essi la trasformano in un feticcio metafisico, cui sono sacrificate le esistenze reali di milioni di proletari. Del resto persino il presidente degli Stati Uniti Clinton, proprio a causa degli effetti della globalizzazione, deve tradire le sue stesse premesse elettorali populiste; dopo aver ammesso che
«[…] una transizione economica dolorosa, intrapresa senza una adeguata rete di protezione sociale, rischia di portare al sacrificio di vite umane in nome di una teoria economica»[3]
deve approvare misure per limitare l’assistenza agli indigenti, agli ammalati e ai disoccupati. La transizione è quella incominciata all’epoca di Reagan e interpretata da riviste di successo come «Wired», che vuol dire cablato, connesso, reso comunicante. La trasformazione della comunicazione da analogica in digitale, le autostrade informatiche, la trasformazione degli «atomi in bit», come si disse con una immagine efficace, tutto ciò avrebbe comportato uno sconquasso sociale se fosse mancato il supporto governativo al cambiamento in attesa del ritorno economico delle tecnologie. Mai un programma politico fu sconfitto in maniera così totale obbligando la coppia presidenziale, con le buone o le cattive, a scendere a più miti consigli con l’immenso apparato assicurativo e assistenziale privato americano[4]. Nello stesso tempo, il vantaggio acquisito dagli Stati Uniti in tutti i campi, permetteva di indirizzare verso il proprio territorio una quota sempre più alta del plusvalore mondiale, riducendo il paese a quello che era l’Inghilterra dopo la Prima Guerra Mondiale, uno Stato rentier.
Ma le implicazioni oggi sono più gravi. Non solo perché non esiste nessuno che possa prendere il posto degli Stati Uniti nella successione storica degli imperialismi, ma soprattutto perché la rendita di cui godono gli americani non deriva dalla sopraffazione coloniale o dalla massiccia esportazione di merci verso paesi che non le producono bensì dalla pura e semplice potenza finanziaria e militare. Oggi gli Stati Uniti, in deficit commerciale cronico, rappresentano per gli altri paesi capitalisti un mercato più appetibile di quanto questi paesi non siano appetibili per le merci americane. Per questo ogni fesso può gridare in piazza, dall’opposizione, «yankee go home», ma non appena gli capiti di andare al governo deve mettersi al servizio degli Stati Uniti, come ci hanno mostrato i vari D’Alema, Schröder e persino Jospin, rappresentante di una borghesia che un tempo, almeno a parole, ci teneva all’autonomia nazionale. D’altronde, se questa è una grande forza di ricatto degli Stati Uniti nei confronti del mondo, è anche una loro grande debolezza, perché è proprio chi sfrutta di più gli altri ad averne più bisogno: perciò sono costretti a fare di tutto affinché questa situazione stia in equilibrio e non si inneschino processi caotici, come paventano ormai in molti.
Questa integrazione obbligata e un po’ paranoica tra acerrimi concorrenti fa parte della globalizzazione e spiega in parte anche paradossi come quelli delle ultime guerre (Iraq e Serbia) alle quali gli europei hanno «partecipato» dandosi poderose zappate sui piedi. Tutto il resto del mondo gravita attorno al precario equilibrio esistente fra i paesi più avanzati, riflettendone le contraddizioni. Si tratta di determinazioni che nessuno Stato e tantomeno governante può aggirare. La legge del valore, che in epoca borghese impone lo scambio fra merci di valore eguale, ha il suo riflesso politico nell’uguaglianza degli uomini che uguali non sono affatto, nel radicamento della democrazia come principio (non è strano, per esempio, che fascisti del calibro di un Bottai sostenessero che il fascismo era la realizzazione autentica della democrazia). La politica globale, come quella interna degli Stati, si svolge dunque all’insegna della democrazia di mercato, ma anche nella difesa militare della democrazia in senso politico. Ed è del tutto conseguente il ruolo della massima democrazia del mondo, gli Stati Uniti, che sono chiamati a mantenere l’attuale equilibrio e ad imporre all’occorrenza la democrazia con le bombe. Tutto ciò non può non riflettersi nelle strane guerre recenti e nell’annullamento di ogni residua funzione autonoma degli organismi internazionali, a partire dall’ONU, dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale.
Tuttavia rimarremmo ancora nel campo delle definizioni se ci accontentassimo di battere il solo terreno economico e politico con i suoi risvolti militari. Proveremo invece a restituire alla globalizzazione il suo vero significato, in quanto fenomeno moderno che non modifica affatto, ma certamente esaspera, la tendenza permanente del capitale a rompere i limiti imposti dalle frontiere, dalle regole e dalla politica degli Stati. Vedremo però che non si tratta solo di questo. Il fenomeno fu previsto da Marx e sarebbe sciocco trattarlo con sufficienza, perché non è vero che «tanto è sempre tutto capitalismo». Proprio Marx ce lo insegna individuando la dinamica storica dei modi di produzione che, in quanto tale, va verso uno sbocco previsto anche nei punti intermedi e produce fenomeni irreversibili. Lenin scrive uno dei suoi libri più letti e meno capiti, «L’imperialismo», per dimostrare l’infondatezza di tale indifferentismo: una volta giunti all’ultima pagina non si dovrebbero più aver dubbi su come vada affrontato il problema dell’integrazione economica mondiale, su che cosa significhi parlare di questioni nazionali in quest'epoca, su che cosa significhi lottare contro l’imperialismo, e anche su cosa siano i sindacati oggi e quali determinazioni subiscano i proletari dei paesi «ricchi».
Del resto per ogni comunista non si tratta d’altro che di un lavoro di approssimazione verso una conoscenza più profonda dello stadio attuale del capitalismo, un tentativo di portare a compimento ulteriore argomenti che nella struttura del patrimonio della Sinistra esistono già, attinti, a loro volta, nel patrimonio comunista precedente, il quale, a sua volta ecc. ecc., in una concatenazione senza fine. Questo è il concetto autentico di continuità, il quale, contrariamente a quanto molti credono ancora, non ha nulla a che fare con la ripetizione pappagallesca di formulette. Esse diventano ben presto insignificanti luoghi comuni e perdono ogni utilità pratica nel lavoro dei militanti[5].
Cercheremo perciò di riprendere il concetto di globalizzazione partendo dal processo reale dello sviluppo capitalistico: tuttavia ne analizzeremo le leggi con la necessaria astrazione affinché, come dice Marx, si possa risalire dal semplice al complesso, perché la legge non descrive il movimento della realtà nella sua molteplice forma, bensì ne fissa la necessità (o determinazione) oltre le forme della percezione immediata.
Il fenomeno della globalizzazione (lo chiameremo dunque così anche noi) è importante perché riflette il passaggio dalla sottomissione formale alla sottomissione reale della società al capitale. Tale passaggio è affrontato specificamente da Marx nel «VI Capitolo Inedito» ed è basato sulla produzione di plusvalore non più assoluto ma relativo; la ricerca spasmodica dell’estorsione di plusvalore assoluto si riduce ad un corollario indispensabile solo come controtendenza alla legge della caduta del saggio di profitto e, per di più, si può applicare solo transitoriamente, in quanto i settori a bassa composizione organica del capitale si modernizzano anch’essi in cicli sempre più brevi. Con questo passaggio il Capitale non inizia nuove strade ma conclude un processo iniziato in Occidente cinque secoli fa[6].
In questo ultimo stadio del capitalismo si concretizza compiutamente lo sviluppo della produzione in contrapposizione ai produttori; si stabilizza storicamente in tutte le aree la riduzione a una proporzione esigua del lavoro morto rispetto al lavoro vivo, mentre la produzione in sé stessa diventa il fine unico del Capitale, che realizza di fatto il suo dominio totale sull’intera società. Il passaggio è estremamente importante per noi, perché il Capitale, nella sua fase suprema, imperialistica, lavora inesorabilmente alla sua propria dissoluzione.
Prima di continuare andiamo a piantare solidamente le radici nel terreno fertile della nostra storia passata.
Dunque, la tendenza alla creazione di un mercato mondiale, il superamento dei confini nazionali, la stretta interdipendenza tra capitalisti e finanzieri è sempre esistita, ma non è questo che ci interessa, dato che per i marxisti è risaputo. Occorre indagare se, allo stato attuale delle cose, questi fenomeni assumono una valenza quantitativa tale da comportare effetti qualitativi interessanti dal punto di vista della società futura e della rivoluzione che la prepara[7].
Lenin polemizza con coloro che vedono nel capitalismo moderno soltanto un superamento dei confini e dell’antico isolamento dei territori e un «intreccio» di interessi.
«Che cosa significa la parola ‹intreccio›? Essa indica soltanto il carattere più appariscente di un processo che si va compiendo sotto i nostri occhi. Essa dimostra semplicemente che l’osservatore vede i singoli alberi ma non si accorge del bosco. […] Ma il substrato di questo intreccio, ciò che ne costituisce la base, sono i rapporti sociali di produzione che si vanno modificando»[8].
Lenin non esita ad affermare che l’epoca dell’imperialismo rappresenta una vera e propria modificazione dei rapporti di produzione. In questo è fedele a Marx, perché la sussunzione reale del lavoro al Capitale è una effettiva modificazione sociale rispetto alla sussunzione formale. Il capitalismo, diventando finalmente davvero sé stesso, incomincia ad autonegarsi come specifico modo di produzione[9].
«Quando una grande azienda assume dimensioni gigantesche e diventa rigorosamente sistematizzata e, sulla base di un’esatta valutazione di dati innumerevoli, organizza metodicamente la fornitura della materia prima originaria nella proporzione di due terzi o di tre quarti dell’intero fabbisogno di una popolazione di più decine di milioni; quando è organizzato sistematicamente il trasporto di questa materia prima nei più opportuni centri di produzione, talora separati l’uno dall’altro da centinaia e migliaia di chilometri; quando un unico centro dirige tutti i successivi stadi di elaborazione della materia prima, fino alla produzione dei più svariati manufatti; quando la ripartizione di tali prodotti, tra le centinaia di milioni di consumatori avviene secondo un preciso piano, allora diventa chiaro che si è in presenza di una socializzazione della produzione e non già di un semplice ‹intreccio›»[10].
Le famigerate multinazionali, bestia nera dell’opportunismo stalinista di un tempo, dei liberal anglosassoni e dell’opportunismo immediatista odierno, non sono altro che il perfezionamento dell’azienda citata da Lenin. Solo che oggi anche la più piccola industria di qualsiasi paese, oltre alle grandi aziende che fecero l’imperialismo, è parte integrante del «sistema» globale cui si fa cenno nella citazione. Mentre al tempo di Lenin il «sistema» era costituito dalla grande azienda con interessi mondiali, oggi è costituito da tutte le aziende, non importa di quale grandezza. È evidente che l’aspetto sottolineato da Lenin, generalizzandosi, si trasforma in importante dato qualitativo con effetti altrettanto generalizzati sull’intero assetto sociale internazionale. Come molte osservazioni di Marx, dedotte dalla dinamica del capitalismo ottocentesco ma proiettate in un futuro prevedibile come un fenomeno fisico, anche le osservazioni di Lenin sono materia comune al giorno d’oggi, nel momento in cui viviamo e verifichiamo quel futuro previsto:
«I rapporti di economia e di proprietà privata formano un involucro non più corrispondente al contenuto, involucro che deve andare inevitabilmente in putrefazione qualora ne venga ostacolata artificialmente l’eliminazione. Lo stato di putrefazione potrà magari durare per un tempo relativamente lungo ma infine sarà fatalmente eliminato»[11].
Nello stesso paragrafo Lenin, in incisi potenti, attribuisce la sopravvivenza del Capitale all’azione nefasta dell’opportunismo che impedisce al proletariato di confondersi, per mezzo del suo partito, al movimento reale del comunismo; nello stesso tempo nega che questa azione possa eliminare le determinanti che portano il capitalismo alla sua contraddizione estrema, all’esplosione sociale che rende possibile l’emergere della società nuova. È solo una questione di tempo.
Il processo moderno di globalizzazione, già presente come si vede all’inizio del secolo, va dunque di pari passo con il processo di concentrazione e soprattutto di centralizzazione del capitale. Mentre con la concentrazione del capitale si ha il massimo ricorso all’estrazione di plusvalore relativo con la conseguente massima espressione della forza produttiva sociale dovuta alla fusione tra la scienza e la produzione, con la centralizzazione si ha la massima socializzazione della produzione. Infatti il processo produttivo sottoposto alla razionalità scientifica passa dall’interno della singola fabbrica a proprietà e ciclo produttivo ben individuati, al sistema di fabbriche a proprietà diffusa e ciclo produttivo diversificato. Siamo già, all’interno di questa stessa società, all’avanzata eliminazione della proprietà capitalistica, sostituita da un controllo, da parte di funzionari stipendiati, che può benissimo essere assunto dalla dittatura del proletariato nella fase transitoria del potere. Stabilita la non esistenza potenziale del capitalista che risulta sostituito da una massa di azionisti e funzionari stipendiati, è anche stabilita la generalizzazione della condizione proletaria, che si fonde con l’insieme sociale.
Ciò non significa affatto che, dal punto di vista di classe, il funzionario stipendiato sia individualmente un proletario, o, viceversa, che la condizione proletaria generalizzata alla società possa giustificare teorie sulla fine del proletariato e l’avvento di una universalità che lega gli uomini al di sopra delle «vecchie» classi. Il dato da tener presente è molto banale e nello stesso tempo di importanza suprema per la futura forma statale transitoria: mentre le rivoluzioni precedenti, compresa quella della Russia sovietica, anzi, questa più di tutte, hanno dovuto impiantare nuovi e potenti strumenti di dominazione di classe, la prossima rivoluzione avrà a disposizione strumenti già pronti e validi per la negazione delle categorie capitalistiche. Invece dello sforzo immane per dare forma alla volontà della rivoluzione, vi sarà il dispiegamento della volontà rivoluzionaria per liberare tutte le energie già presenti e sviluppate.
Tutto ciò è perfettamente in linea con il marxismo, che prevede appunto la liberazione delle forze produttive con l’eliminazione dalla scena storica del vecchio modo di produzione. Anche Lenin, a questo proposito, riteneva che nel caso della Russia fosse relativamente facile prendere il potere ed estremamente difficile mantenerlo, mentre nel caso della Germania capitalisticamente sviluppata sarebbe stato il contrario, cioè sarebbe stato difficile imboccare la strada della presa del potere ma semplice in seguito svolgere le funzioni e utilizzare gli strumenti adatti per mantenerlo.
Allora, se le questioni legate al problema della globalizzazione stanno in questo modo, se cioè i capitalisti sono null’altro che inutili comparse, relegati alla loro nullità da un Capitale che li ha sostituiti con anonimi funzionari stipendiati; se inoltre oggi più che mai tutte le funzioni del Capitale sono tese ad accrescere sé stesso tramite la produzione per la produzione e non a soddisfare i bisogni dei capitalisti, allora possiamo, con la Sinistra, assumere il «tremendo» passo di Marx sulla non esistenza potenziale del capitalismo:
«Questa proposizione è ugualmente la proposizione della non esistenza della produzione capitalistica, e perciò della non esistenza dello stesso capitalismo industriale. Infatti il capitalismo è già fondamentalmente soppresso dalla proposizione che il godimento e non l’arricchimento sia il motivo determinante».
Se il motivo determinante non è più l’arricchimento del capitalista (anche se le briciole dell’immensa quantità di lavoro passato si depositano ancora in patrimoni e conti bancari privati) occorre solo trasformare lo sciupio sociale, che dilapida la quasi totalità del valore prodotto, in godimento sociale. Glossa Bordiga:
«Resta dimostrata la necessità della morte del capitalismo, e quindi la sua scientifica ‹non esistenza› potenziale dichiarata da Marx, il che può fare solo una scienza ‹non più dottrinaria ma divenuta rivoluzionaria›»[12].
Lenin definisce questa fase come «capitalismo di transizione, o più esattamente come capitalismo morente». Sono passati ottantatré anni e il morente è ancora vivo, anzi, sembra più potente che mai. I marxisti hanno forse sbagliato qualcosa? No, tutto è a posto: i capitalisti possono gioire di soddisfazione nel celebrare la morte del «comunismo reale», ma noi non siamo responsabili delle bestialità che dicono o a cui credono. Il comunismo è un’altra cosa, è un movimento che distrugge costantemente le basi della società borghese anche se essa sfoggia sicurezza e tracotanza. Sarebbe veramente un ingenuo immediatista chi pensasse che la rivoluzione si è fermata solo perché non si vede, chi pensasse che i trionfi della borghesia sul suo nemico storico siano più importanti delle paure che qualche borghese incomincia a manifestare sulla base di dati oggettivi e catastrofici. Siamo stati sconfitti sul campo, questo è certo, non nel 1989 con il crollo dell’Est, ma alla fine degli anni '20, quando l’opportunismo si alleò con la borghesia mondiale nella gestione congiunta della controrivoluzione. Ma il comunismo è il movimento generale dell’intera società umana in tutta la sua storia verso un risultato già inscritto nel movimento stesso, quindi è insopprimibile: qualunque cosa facciano i borghesi per salvare la loro fetida società, essi non possono fare a meno di lavorare per noi.
Il ciclo storico del comunismo si apre con l’assenza della proprietà e terminerà con la sua soppressione positiva. Non si tratta, nell’accezione di Marx, di eliminarla con l’emanazione di un decreto, che sarebbe concezione sciocca d’attivista, bensì di superarla nei fatti. Le prime comunità chiuse non producevano e, finché non produssero (un manufatto, un’eccedenza nella raccolta, un minerale strappato alla terra), la proprietà non fu neppure concepibile. Allo stesso modo non fu concepibile lo scambio, che è permesso dalla produzione di un’eccedenza reciproca di oggetti differenti, la quale, per il semplice fatto di esistere, provoca una differenza economica con altre comunità. Marx attribuisce giustamente alla differenza il primo motore dello scambio e la nascita dei primi embrionali sistemi economici.
La rottura della condizione locale in cui vivevano i primi gruppi umani fu l’inizio della marcia verso una condizione globale dell’umanità, marcia che durò millenni e che dura tuttora. La prossima forma sociale romperà gli ultimi vincoli e realizzerà l’unione dell’uomo con la natura, dopo il necessario intervallo che vide la separazione e la contraddizione, cioè l’auto-alienazione dalla natura e l’utilizzo becero e distruttivo (ma nello stesso tempo rivoluzionario) delle «risorse»; fenomeni che sono registrati dai movimenti borghesi in modo del tutto inadeguato (locale) rispetto alla loro portata universale (o globale). L’immenso problema dell’ecologia, per esempio, non si può risolvere cercando soluzioni di rattoppo all’interno del sistema, bisogna uscirne. Ma questo fa parte del processo storico che porterà l’uomo a mettersi in armonia con tutto l’arco millenario passato fino a concepire il proprio futuro, cioè a progettarlo (rovesciamento della prassi).
Anche la storia della conoscenza passata ha registrato questo processo: l’uomo, in un primo tempo inserito del tutto nella natura (cioè globalmente), ha dovuto sviluppare un linguaggio sulla base di una catalogazione delle cose secondo un nome loro assegnato. Dapprima fu una suddivisione grossolana e le relazioni fra le cose furono semplici; poi, tramite l’affinamento del linguaggio stesso per mezzo del lavoro, essa divenne via via più sofisticata grazie alla possibilità non solo di mettere in relazione gli oggetti tra loro con le parole, ma di costruire sistemi di parole e di oggetti tramite relazioni completamente nuove, che divennero memoria consolidata, teoria, cioè motore per la riproduzione sistematica di atti utili e soprattutto per lo sviluppo di una conoscenza ulteriore. Questo processo ha portato l’uomo a conoscere la natura nei suoi più segreti recessi (locali) e, una volta raggiunto questo risultato, sta ritornando ad una visione d’insieme (globale) della complessità del mondo. Questa nuova conoscenza è ovviamente mediata da quella nel frattempo accumulata, perciò non è solo quantitativamente superiore ma qualitativamente arricchita da sempre nuove relazioni operate sull’esistente.
Il marxismo, come concezione unitaria non soltanto dell’economia capitalistica e del suo sbocco comunista ma di tutto l’universo in cui la storia dell’uomo si svolge, è nello stesso tempo un prodotto e un interprete anticipatore di quest'esigenza – chiamiamola di globalizzazione – dell’umanità.
Dunque, la parte «capitalistica» del fenomeno storico su cui stiamo indagando non è neppure la più importante, dato che si tratta di una dinamica che coinvolge tutta la storia umana e che avrà sbocco in ben altra concezione unitaria del mondo. Senza andare troppo lontano, nel primo capitolo del «Manifesto» Marx tratteggia un’apologia della rivoluzione borghese in quanto liberatrice di forze produttive che tendono a generalizzarsi e che invece sono incatenate dalla vecchia forma sociale. La tendenza alla globalizzazione è quindi insita nel movimento dell’umanità lungo il percorso dal regno della necessità a quello della libertà. Per questo, di fronte alla borghesia vittoriosa che libera, con le forze produttive, uomini e cose dai vincoli feudali, oggi possiamo affermare, con Marx, che
«Sotto i nostri occhi si sta compiendo un processo analogo. Le condizioni borghesi di produzione e di scambio, i rapporti borghesi di proprietà, la moderna società borghese che ha evocato come per incanto così potenti mezzi di produzione e di scambio, rassomiglia allo stregone che non può più dominare le potenze sotterranee da lui evocate»[13].
Un processo analogo a quello della liberazione dal medioevo feudale, ma più radicale e profondo. Mentre nel mondo sussistono ancora per miliardi di uomini forme arcaiche di sussistenza, nessuno è più al di fuori del ciclo capitalistico totale, perché il più sperduto contadino o pastore vede la sua sopravvivenza dipendere totalmente dal mercato e dalla finanza mondiale, che sono la sostanza su cui si basa la globalizzazione.
La generalizzazione del mercato cui si riferiscono gli osservatori borghesi non è, dunque, che un aspetto, e neppure il più importante, della globalizzazione. Questa società, incapace di afferrare i più importanti fenomeni sociali e di andare oltre la semplice superficie delle cose, non meriterebbe di essere ulteriormente analizzata, dopo Marx, se quest'ultimo non ci avesse insegnato, come abbiamo visto, che è proprio nelle pieghe del tessuto capitalistico maturo che si nascondono le potenzialità della società futura. Dobbiamo quindi verificare se per caso agli occhi degli interessati capitalisti e degli orbi pseudomarxisti non si presenti un fenomeno che essi non capiscono e che invece è importante per il futuro sociale. I capitalisti ritengono che la globalizzazione sia un fenomeno di ordinaria amministrazione, nient’altro che una ulteriore, mirabile manifestazione del potenziale della loro società e, come abbiamo visto, una giustificazione ulteriore alla loro azione, se non alla loro sopravvivenza come classe. Gli opportunisti seguono a ruota introducendo alcune varianti, specialmente riguardo ai rattoppi che sarebbero utili per umanizzare il capitalismo; le introducono un po’ per non sputtanarsi troppo, un po’ perché hanno mutuato dall’ideologia dominante un concetto moralistico dell’azione sociale, ma, di fatto, non sono varianti che dimostrino una concezione diversa da quella borghese. Noi, al contrario, dobbiamo chiederci se davvero sia tutto lì, o se ciò che va sotto il nome di globalizzazione non sia invece qualcosa che ci dà la misura di quanto l’agonia del capitalismo sia in fase avanzata. Che poi è un altro modo per capire quanto la misconosciuta vecchia talpa del comunismo abbia lavorato bene, scavando nel profondo.
Il termine globalizzazione quindi non può essere utilizzato solo per definire una condizione di internazionalizzazione dello scambio di merci e di capitali, un’accresciuta interdipendenza dei paesi o una facilità di elaborazione e comunicazione tramite i computer, i satelliti, le reti informatiche, ecc. La globalizzazione è certamente anche tutto ciò, ma è soprattutto molto di più: l’intero complesso del lavoro mondiale, socializzato ad un punto più alto di quanto potesse scorgere Lenin al suo tempo, rappresenta il punto cui è giunta la naturale tendenza dell’organizzazione umana a superare gli ostacoli che frenano il divenire di specie, cioè a trapassare dall’insieme di organizzazioni parziali che mettono in conflitto gli uomini tra loro, e questi con la natura, al sistema organico globale, che mette in armonia uomini e natura. Se vogliamo usare l’espressione di Marx, è un riflesso del comunismo in quanto movimento reale che distrugge lo stato di cose presente.
Il fatto che il modo di produzione attuale traduca questi enormi risultati in crisi, conflitti economici, guerra e sofferenza umana non deve occultare l’enorme passo che l’umanità compie verso la sua propria emancipazione. La circolazione sempre più forsennata di capitali finanziari (che in valore monetario rappresenta il 95 % delle transazioni mondiali mentre le merci, i servizi e i capitali commerciali rappresentano solo il 5 %) dimostra che il capitalismo, maturato con la produzione sociale, si sta autosopprimendo, come previde Marx, per l’enorme divario fra la potenza virtualmente infinita di questa e l’impotenza del Capitale ad usarla per la sua propria valorizzazione. Come diaframma tra la società futura, liberata dalla proprietà, e l’attuale modo di produzione, si erge soltanto più la potenza politica della borghesia, cui dovrà contrapporsi una potenza politica più grande ancora, il partito della rivoluzione.
L’antagonismo fra il manager e l’azionista, già rilevata da Marx e da Lenin come contraddizione del capitalismo maturo, è l’antagonismo fra la produzione e la finanza: il primo, che dispone della forza materiale di impianti, operai, energia, materie prime e organizzazione, pianifica la produzione trattando materia, mentre il secondo vede solo il risultato delle sue cedole trattando cifre virtuali. Ciononostante è solo il secondo, cioè l’intero capitale finanziario, che si muove in giro per il mondo a cercare dove la produzione gli possa garantire il dividendo più alto, ed è così facendo che decide dove e come si produce, intessendo una rete mondiale di interessi. Ma decide anche dove non si produce, dove si coltiva soltanto ciò che gli serve o dove si estraggono soltanto minerali.
Osservando il formarsi di nuove e più totalitarie regole di divisione internazionale del lavoro, ritorniamo all’essenza del moto verso la globalizzazione, cioè la differenza: essa è stata il motore sia dello scambio primigenio che del capitalismo nel suo pieno splendore, quando il vulcano della produzione cercava e creava nuovi mercati. Così facendo eliminava la differenza. Ora il capitalismo la deve nuovamente generare rovesciando i termini della questione: sono i mercati già trovati e creati a permettere la produzione, di qui la corsa alla concorrenza spietata, al monopolio, all’eliminazione dell’avversario. Non è una novità, è il capitalismo stesso che espropria i capitalisti. Interi paesi assumono le caratteristiche specifiche dettate dal Capitale più che dai governi, che sono al suo servizio; così la Corea produrrà acciaio rinunciando ad una propria agricoltura[14], l’Argentina carne, la Finlandia legname, l’Olanda servizi e l’Africa materie prime.
Nelle sue ricerche Marx dava importanza enorme a questi aspetti contraddittori. Il capitalismo nasce dalla differenza, genera l’uguaglianza e sopravvive rigenerando la differenza; ma è proprio così facendo che porta l’uguaglianza agli estremi tramite la concorrenza, facendo del mondo un unico sistema produttivo sociale integrato. Difficile? Può darsi. Ma non è la differenza di reddito fra il contadino più povero e l’americano più ricco a darci elementi scientifici di riscontro.
I produttori isolati si contrappongono sul mercato come portatori di valore d’uso e questo si scambia soltanto se sussiste una differenza: non ha senso scambiare noci con noci, oro con oro, ed è persino difficile immaginare che l’umanità si potesse muovere verso lo scambio generalizzato barattando caciotte con scamorze, prima che la produzione sociale trasformasse i bisogni e affinasse il senso della differenza. I produttori associati di oggi, a differenza dei loro antenati, si contrappongono sul mercato con prodotti estremamente diversi ma che hanno uguale valore, vale a dire che realizzano l’uguaglianza potendo confrontare quantitativamente (misurare) valori d’uso qualitativamente differenti.
Nella società classica antica, dove il valore di scambio non era alla base della produzione, la libertà, l’eguaglianza e la fraternità avevano valore opposto rispetto all’epoca in cui viviamo: allora tali categorie erano realizzate solo come valore morale e locale, all’interno di un gruppo umano limitato e contro l’esterno. Fuori erano tutti barbari. Oggi lo scambio di valore universalizzato tende alla realizzazione sostanziale di tali categorie dal punto di vista economico globale, anche se rimangono e rimarranno categorie politiche insoddisfatte, mere speranze. La democrazia come la immaginano gli uomini non esiste e non è mai esistita, come già osservava Rousseau. Ma l’idea di democrazia si rafforza sulla base sociale dell’eguaglianza dei valori, soprattutto nell’epoca in cui la democrazia politica viene accantonata e diventa un’attività meramente formale intorno ai parlamenti. Paradossalmente, la democrazia, che nelle forme arcaiche non si manifestava affatto con un’ideologia dell’uguaglianza pur mettendo a confronto individui socialmente abbastanza eguali (gli schiavi erano ovviamente esclusi), si realizza col capitalismo tramite un’ideologia dell’eguaglianza tra individui che socialmente ed economicamente sono a distanze immense. Si realizza perciò attraverso l’eguaglianza dei valori, per cui uomini e cose sono misurabili sul mercato tramite un equivalente universale di valore, il denaro: questa è la democrazia, altrimenti impossibile. Essa non può essere migliorata, può solo essere superata da altri e contrapposti meccanismi sociali. Marx, nei «Grundrisse», osserva che,
«volendo, il soggetto può avere anche la coscienza esaltante che la realizzazione dell’interesse singolo superato, dell’interesse generale sia invece proprio il soddisfacimento del suo brutale interesse singolo»[15].
E questo perché nel processo di scambio capitalistico ognuno è libero e ogni transazione è assolutamente volontaria, dato che nessuna parte ricorre alla violenza; e in effetti ognuno diventa mezzo per l’altro anche se il fine di ogni azione è per ognuno del tutto egoistico. L’universalizzazione degli interessi egoistici produce la coscienza universale che proprio ciò sia l’interesse generale o comune. La particolarità individuale del soggetto che scambia non entra nel processo, ma la diversità materiale del prodotto scambiato sì, è essa che lo rende possibile. La grandezza del capitalismo consiste nel fatto che sia il soggetto che il suo prodotto sono resi possibili dalla differenza tra soggetti e tra prodotti; essi sono separati da tale differenza, perché il produttore si separa dal suo lavoro vendendolo e dal suo prodotto perché è un bisogno altrui; ma nello stesso tempo sono uniti nell’uguaglianza tramite il valore. Infatti il valore di scambio, essendo tempo di lavoro sociale medio universale, è sempre della stessa natura indifferenziata, indipendentemente dalle differenze proprie di chi lo produce, e si cristallizza sempre nei prodotti con questa stessa natura, indipendentemente dalle qualità differenziate di tali prodotti-merce.
Se è così, dice Marx, ci troviamo di fronte non soltanto ad un capitale globalizzato, un unico capitale che è passato definitivamente dalla dominazione formale sul lavoro a quella reale, ma anche ad un’unica massa globale di merci, trattabile come una merce sola. Infatti, il prodotto totale del capitale non è più, in questo caso, rappresentabile come mera somma delle merci discrete, in quanto ora si realizza effettivamente il fatto che la somma dei prezzi corrisponde al valore. Ciò non era possibile finché esistevano ancora settori del globo a produzione non completamente capitalistica e l’immagine del blocco di merci come valore unico era un’utile astrazione, mentre ora è la realtà[16].
Ciò ha conseguenze formidabili rispetto al comportamento del Capitale e dei suoi organismi esecutivi, classi, governi, Stati. Siccome a questo modo la società è oggettivamente sempre meno capitalistica, occorre che soggettivamente, cioè politicamente e militarmente sia sempre più difeso il capitalismo. Contro sé stesso e contro l’unica classe che può farlo saltare per sempre. Ecco perché non ci stanchiamo di insistere sul fatto che, se c’è controrivoluzione, dev’essere possibile indicare in che cosa consiste la rivoluzione in atto contro cui essa si scaglia.
L’unità degli opposti nel capitalismo si fa dunque micidiale. Se la diversità naturale dei produttori e delle merci è il fondamento della loro uguaglianza sociale, non potrebbe neppure sussistere una relazione capitalistica quando nella massa di merci dovesse rimanere il valore e scomparire il prezzo differenziato. Per di più questa particolare relazione di valore, scaturita per la prima volta nella storia dell’umanità con il capitalismo sviluppato, è la sola che può fare da fondamento alla società futura. Per questo ci interessa sommamente. Infatti la generalizzazione dello scambio inteso alla Lenin, cioè della socializzazione massima del lavoro, è nello stesso tempo, come egli afferma, capitalismo di transizione, capitalismo morente. Il militante comunista non si turba affatto se i tempi reali della rivoluzione e del suo sbocco non corrispondono a quelli delle sue speranze: la transizione è irreversibile e la catastrofe (scontro finale, dittatura) inevitabile.
Neologismo cacofonico e orrendo, ma rende l’idea del passaggio storico, avvenuto in tre tempi: 1) a partire dal XII secolo la finanza originaria serve a rendere possibile il mercato in un mondo che conosce solo monete locali inconvertibili; 2) fino al termine della rivoluzione industriale la finanza diventa un valido supporto al mondo della produzione permettendo consistenti anticipi di capitale; 3) dopo la Prima Guerra Mondiale la produzione diventa sempre più un’appendice del mondo finanziario che si rende man mano autonomo. Mentre in passato l’anticipo di capitale a chi non ne possedeva a sufficienza rendeva possibile il proseguimento della produzione, oggi occorre trovare a tutti i costi una produzione che renda possibile un sufficiente plusvalore per garantire la sopravvivenza di un capitale esistente. La prima determinazione formale del denaro è per Marx la misura universale dei valori delle merci, mentre ad un diverso grado di astrazione, più inerente al capitalismo maturo, prende forma una seconda determinazione: il denaro smaterializzato è sussunto all’interno della struttura creditizia per cui si impone la differenza fra accumulazione reale e accumulazione monetaria. Col sopravvento di quest'ultima, il legame con la produzione, pur sempre indispensabile, diventa lontano e invisibile, tanto che si giunge, alla fine, ad una situazione di indifferenza fra saggio di profitto e saggio d’interesse, con predominanza di quest'ultimo. La finanziarizzazione è un fatto reale, necessario e previsto, nella struttura della critica marxista al capitalismo, ed è premessa indispensabile per la fine del capitalismo stesso. Questa osservazione è di estrema importanza. Quando il profitto, dice Marx,
«assume semplicemente la forma di interesse, tali imprese [le grandi società per azioni] sono possibili anche se fruttano solo l’interesse, ed è questa una delle cause che ritardano la caduta del saggio generale di profitto, perché queste imprese, il cui capitale costante sta in proporzioni così enormi rispetto al capitale variabile, non entrano necessariamente nel livellamento del saggio generale del profitto. È questa la soppressione del modo di produzione capitalistico entro i confini del modo di produzione capitalistico»[17].
Qui Engels aggiunge un passo in cui osserva che nel frattempo si erano sviluppate enormemente tali nuove forme di gestione industriale e che la socializzazione del lavoro stava raggiungendo livelli altissimi, per cui
«si prepara così, con nostra grande soddisfazione, la futura espropriazione da parte della società intera»[18].
Va notato che allora il saggio medio di profitto era molto più alto dell’interesse mentre oggi, proprio a causa del fenomeno citato, non c’è praticamente differenza. Non si deve confondere tutto ciò con il vertiginoso aumento dei profitti di singole aziende, specialmente dopo le ondate di fusioni che, ricordiamolo, rappresentano il processo di centralizzazione espropriatore di capitalisti; la media del saggio di profitto è rivelata solo dall’indice di crescita della produzione industriale[19].
Il neologismo finanziarizzazione, nell’originale inglese è securitization e suona un po’ diverso in quanto significa «titolarizzazione», ovvero tendenza a trasformare tutto in titoli (su attività, su altri titoli, su minerali, su ipotesi future ecc.) trattabili sul mercato. Non solo transazioni su merce, su denaro e su impegni in denaro, ma anche su ciò che queste cose potrebbero essere in futuro. È l’esplosione atomica dell’esuberanza del Capitale contro l’impenetrabile muro d’acciaio di un modo di produzione che gli impedisce di valorizzarsi, quindi di avere un futuro nella storia dell’uomo.
La compravendita di danaro a mezzo di titoli di credito ha origini assai lontane e persino «globali». Dal Duecento al Seicento, le piazze di Firenze, Lucca, Genova Besançon, Bruges, Parigi, Amsterdam, riuscivano a superare il caos delle monete locali tramite lettere di credito e banchi di cambio efficienti. Turbinavano nel Cinquecento «cambi con ricorsa» e «cambi con ricambio», cambiali rinnovabili a tre mesi, spiccate dal mercante a favore di sé stesso e messe in circolazione in paesi diversi come titoli di credito dal valore, ovviamente, fittizio. Bisognò aspettare il Settecento affinché il titolo girabile diventasse titolo di credito vero e proprio, scontabile dalle banche, abilitate ad emettere biglietti al portatore o a vista e funzionanti come moneta circolante. Nel suo «Confusiòn de confusiones» (1688), il portoghese Joseph de la Vega ben denunciava l’imbroglio, diffusissimo sin da allora, di vendere grano non ancora raccolto o pesce non ancora pescato. Oggi al mercato mondiale delle materie prime si tratta soprattutto merce che non esiste ancora o che addirittura non esisterà mai.
Gli ultimi anni del XIX secolo e i primi del XX conobbero un’intensa attività speculativa, quella stessa di cui il testo di Lenin sull’imperialismo diede, nel 1916, debita nota. Nessun raffronto è tuttavia possibile con la mole di transazioni rilevabile attualmente, testimonianza inequivocabile d’una ormai ardua valorizzazione. Infatti, a norma di dottrina, è stolto scambiare la causa con l’effetto: l’eccesso d’affarismo speculativo è un prodotto dell’impossibilità di trarre un adeguato profitto dall’investimento industriale, non certo un suo fattore, come affermano i cultori di un ritorno all’età dell’oro capitalistica.
Il valore delle obbligazioni e dei titoli negoziati quotidianamente sul mercato mobiliare raggiunge i 220 miliardi di dollari, vale a dire un quinto del prodotto interno lordo italiano. L’ammontare complessivo dei depositi in valuta estera, il cui utilizzo è specificamente previsto per le transazioni finanziarie internazionali, è di 8000 miliardi di dollari, pari cioè all’intero PIL statunitense e una volta e mezzo il valore dell’export mondiale. Nel 1991, i prestiti bancari internazionali equivalevano già al 44 % dell’intero prodotto lordo dei paesi OCSE sommati. E il commercio di denaro rende: ciascuno dei cinque maggiori istituti finanziari al mondo (in base alla classifica del 1993) realizza annualmente introiti superiori al prodotto lordo dell’intero continente africano (434 miliardi di dollari). Insomma, la massa finanziaria è imponente.
La concentrazione della produzione, la conseguente formazione dei monopoli, la centralizzazione dei capitali, la fusione e simbiosi della banca con l’industria, stanno alla base della formazione del capitale finanziario. Se la produzione e l’esportazione di merci per accumulare capitale erano la caratteristica principale del vecchio capitalismo, al culmine della storia capitalistica il processo si inverte: per il capitalismo recente è divenuta caratteristica l’esportazione di capitali accumulati affinché possa continuare la produzione e l’esportazione di merci. Va da sé che non c’è eccedenza di capitali senza eccedenza di merci: bisogna solo stabilire, a questo punto, dove vengono prodotte l’una e l’altra eccedenza, e soprattutto dove il lavoro passato si è cristallizzato in manufatti che ricoprono la Terra e in capitale liquido in cerca di ulteriore valorizzazione.
È opportuno tener fermo che tutte le crisi del capitale, piccole e grandi, hanno uguale origine e natura, che è sempre scarsezza di valore finale scaturito dal ciclo complessivo dell’economia. Perciò sono sempre crisi di accumulazione (o di redditività) e si esprimono nella pletora di merci e di capitali, ovvero nel contrasto fra l’aumento dell’offerta, vertiginoso e senza limiti teorici nella produzione, e il calo drastico della domanda, dovuto alle dimensioni reali del mercato.
Nonostante questa base comune, ciascuna crisi si differenzia dalle altre per durata, intensità, conseguenze sugli Stati e sulle popolazioni. In altri termini, la periodica sovraccumulazione rivela il limite del modo capitalistico di produzione ed è particolarmente significativo che le crisi dell’epoca imperialistica siano di necessità crisi mondiali. Ogni crisi è generata da una caduta di valore, ed ogni superamento delle crisi non può che avvenire tramite l’accumulo di fattori che generano una futura e ulteriore caduta di valore. Infatti il saggio di profitto scende storicamente con l’aumentare della forza produttiva del lavoro, e questa diminuzione crea continue barriere allo sviluppo della forza produttiva sociale in un circolo vizioso infernale rotto ogni tanto dalle crisi; per cui, nell’immediato, il Capitale riesce a mantenere un tasso di sviluppo soltanto per mezzo di una reiterata distruzione di una parte di sé stesso.
Questo dato storico si può esprimere attraverso la «parabola del plusvalore», uno schema che prendiamo da una nostra più dettagliata trattazione e che spesso utilizziamo per visualizzare la dinamica del capitalismo[20]. In esso è mostrato l’andamento del plusvalore da uno zero dovuto ad una società che fosse fatta di operai e che consumasse immediatamente tutto ciò che produce (a destra nello schema), ad un altro zero dovuto ad una società che non impiegasse più operai da cui estorcere plusvalore (a sinistra).
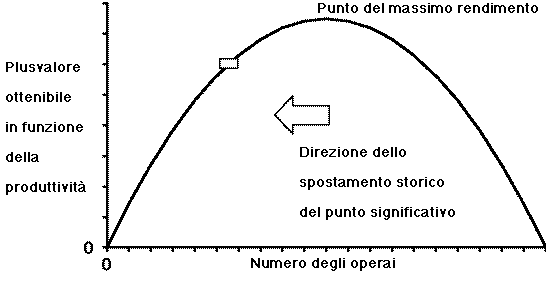
In quanto funzione diretta del tempo di lavoro e del lavoro vivo, la forza produttiva del capitale (rapporto fra plusvalore e salario) urta immediatamente contro la forza produttiva del lavoro (rapporto fra unità prodotte e tempo di lavoro) la quale tende a ridurre sia il tempo di lavoro, sia l’impiego di lavoro vivo.
Ciononostante, la forza produttiva del capitale appare vincolata al risparmio della forza-lavoro, per almeno due ragioni: prima di tutto perché la massa di lavoro che può essere messa in moto dal Capitale dipende non dal valore di quest'ultimo, ma dalla massa dei valori d’uso di cui esso è composto (macchinari, materie prime, mezzi di sussistenza ecc.) e da cui derivano l’aumento del lavoro vivo impiegato e del sopralavoro; in secondo luogo, perché, a un dato momento, se diminuisce la possibilità di estorsione di plusvalore, non solo diminuisce il profitto del capitale addizionale, ma qualsivoglia profitto si rende impossibile e l’accumulazione s’arresta. Del resto è inevitabile che con l’aumento della forza produttiva sociale, che non diminuisce mai, diminuisca invece l’estorsione di plusvalore: oltre precisi limiti fisiologici e temporali, pur spremendo un operaio come un agrume, non si può estrarre da esso tanto plusvalore quanto se ne può estrarre da cento operai.
Le due tendenze, al calo del saggio del profitto e al calo della massa del profitto, attestano, per l’appunto, che con l’aumento del numero di unità prodotte aumenta anche la difficoltà a valorizzare il tempo di lavoro in esse contenuto, e che, con minimo impiego di forza-lavoro, lo sviluppo della forza produttiva del lavoro può e deve ripercuotersi negativamente sulla forza produttiva del capitale[21].
L’aumentata massa dei mezzi di produzione destinati a essere trasformati in capitale ha sempre a sua disposizione, per sfruttarla, una popolazione operaia accresciuta in proporzione e perfino eccessiva. Nell’evoluzione del processo di produzione e accumulazione dovrebbe esservi, dunque, un aumento della massa del pluslavoro acquisito e suscettibile di esserlo, e quindi della massa assoluta del profitto acquisito dal capitale sociale. Ma le stesse leggi della produzione e della accumulazione aumentano, insieme alla massa, il valore del capitale costante più rapidamente di quanto avviene nella parte variabile del capitale convertita in lavoro vivo[22].
Le stesse leggi producono quindi, per il capitale sociale, un aumento della massa assoluta del profitto e una diminuzione del saggio del profitto[23], per cui il capitalista è costretto a muovere più capitale per lo stesso profitto ovvero a considerare nei suoi bilanci annuali la massa invece del saggio.
Il saggio di profitto, ossia l’incremento proporzionale del capitale, è la forza motrice della produzione capitalistica. Condizione e stimolo al tempo stesso dell’accumulazione, esso vive la contraddizione di trovare il suo limite nello sviluppo stesso della produzione. L’estensione della produzione non avviene, tuttavia, in base al rapporto fra la produzione e i bisogni sociali, ma esclusivamente in base all’appropriazione di plusvalore in rapporto al lavoro oggettivato o, per dirla in altri termini, in base al rapporto tra profitto e capitale impiegato nel ciclo produttivo. La produzione si arresta, allora, quando la realizzazione del profitto è messa in forse.
La ragione d’essere del Capitale è, dunque, lo sviluppo delle forze produttive e del lavoro sociale, ma è proprio attraverso tale sviluppo che esso pone le condizioni materiali per la sua soppressione e per l’avvento di una forma più elevata di produzione.
La caduta del saggio di profitto induce il Capitale a negarsi come processo produttivo e a costituirsi come capitale finanziario nell’apparente processo di valorizzazione che porta direttamente una certa quantità di denaro a trasformarsi come per miracolo in più denaro. E questo senza passare attraverso la produzione; il che è evidentemente assurdo, come riconoscono anche alcuni borghesi. Nella misura in cui le transazioni tra capitali nel tempo vengono a prescindere dalla produzione di plusvalore, ecco che allora il capitale investito diventa mero capitale fittizio e la stessa economia politica borghese diventa mediocre attività di gestione basata sulla speranza di ottenere, invece di un profitto industriale, un certo interesse.
Va da sé che, per quanto riguarda i titoli, ogni aumento di prezzo basato sulla sola speranza di ottenere interesse invece di plusvalore, quindi senza passare attraverso il processo produttivo, è passibile di azzeramento. Perciò i crolli borsistici o monetari non distruggono effettivamente capitale, ma solo segni arbitrari di valore precedentemente stabiliti. Questo almeno fino a quando non venga intaccato proprio il valore originario rappresentato dal titolo stesso. Dove stia, nel complesso dei titoli quotati, il confine fra valore fittizio e reale è ovviamente difficile da stabilire, ma è anche chiaro che chi ha impiegato in Borsa capitale «vero», cioè lavoro passato, nel caso di una crisi prolungata se lo vede decurtare. Chi invece ha venduto quando i prezzi erano alti rispetto all’epoca dell’acquisto intasca la vincita.
Se è vero però che nel mercato d’azzardo il risultato è sempre a somma zero, è anche vero che chi vende a prezzo alto e fittizio ha ora in mano un capitale che, proprio perché c’è la crisi, avrà vita difficile per valorizzarsi e rischierà grandemente di essere decurtato anch’esso. Nelle grandi crisi c’è sempre distruzione effettiva di capitale. Per il capitalista avere liquidità in tempi di crisi è un incubo che può essere affrontato soltanto elevandolo a potenza, cioè escogitando sempre più sofisticati mezzi d’investimento. Quando la crisi è cronica, cioè quando il saggio di profitto langue al ritmo di una crescita asfittica, ciò si traduce in una sempre più spinta securitization nel tentativo di trovare un impiego decente per capitali disoccupati. Ma l’indice vero di crescita di un’economia non è certo il movimento di capitale fittizio: è l’incremento della produzione e dei servizi vendibili un anno sull’altro.
La finanziarizzazione dell’economia si manifesta anche attraverso le campagne di cosiddetta privatizzazione. Nei paesi maturi lo Stato ha ben altri mezzi per controllare l’economia che non la detenzione diretta di impianti produttivi e servizi a pagamento. Quindi, se da una parte l’indice di statalizzazione di un’economia non si ricava dall’ampiezza del settore pubblico ma dall’intervento politico dello Stato per disciplinare l’economia intera (come negli Stati Uniti), dall’altra si va sul sicuro affermando che le campagne di privatizzazione rappresentano un vero e proprio intervento dispotico dello Stato nell’economia, con buona pace di Berlusconi, D’Alema e soci. È del tutto ininfluente il fatto che lo Stato mantenga o no la golden share, cioè la maggioranza di controllo. Ciò che importa è che la proprietà viene diffusa fra una miriade di piccoli azionisti che non conteranno niente e che saranno fregati al momento opportuno, mentre ristretti nuclei di sindacato azionario avranno via libera per accumulare secondo le regole stabilite dalla politica economica dello Stato.
Di fatto, gli undicimila miliardi di dollari detenuti dai fondi d’investimento contano più di tutti i capitalisti privati del mondo, e nessun governo, neppure quello degli Stati Uniti, può fare a meno di praticare una politica totalitaria per disciplinare questo potenziale esplosivo. Aziende come la IBM diffondono le loro azioni fra singoli sparsi nel mondo e i potentissimi fondi la «possiedono» controllando appena il 4 per cento del capitale.
La finanziarizzazione è dunque un fenomeno di capitalismo maturo, mentre la statalizzazione diretta è un fenomeno di capitalismo giovane. Infatti tutte le economie dei paesi poveri (o ricchi solo in materie prime) hanno un alto indice di intervento diretto dello Stato. Il tempo di rotazione del capitale nei processi di produzione e di circolazione influenza la produzione di plusvalore, quindi è ovvio che, negli stadi meno sviluppati della produzione capitalistica, le opere su larga scala richiedenti un lungo periodo di lavoro, e quindi una notevole anticipazione di capitale, vengano intraprese direttamente dallo Stato. Qualche volta con impiego di manodopera comandata a corvée, in certi casi ricorrendo addirittura a lavoro forzato, come in Russia e in Cina. In situazioni particolari, la sete di plusvalore fa estendere questo fenomeno anche ai paesi ultrasviluppati, come nel caso della Germania nazista o, recentemente, nel caso del sistema carcerario statunitense privato.
La forma iniziale di capitalismo di stato, in origine legata al mercantilismo delle Repubbliche Marinare, poi via via estesa alla rete mercantile che si consolidò con Venezia, con la finanza tedesca, con l’imperialismo olandese ecc.[24], oggi può apparire come concentrazione diretta, nelle mani dello Stato, di proprietà, finanza e dominio del mercato, ma in realtà costituisce per i capitali in cerca di remunerazione una riserva di energie indispensabile per intraprese aziendali e speculazioni finanziarie private. Il processo attuale di privatizzazione, quindi, indotto dalla ricerca incessante di plusvalore da parte del Capitale determinata dalla caduta del saggio di profitto, è funzionale a raccogliere capillarmente molti piccoli capitali privati per concentrarli alla fine nelle mani di pochi capitalisti o fondi d’investimento. Questa ulteriore fonte della finanziarizzazione dell’economia è indispensabile, perché il singolo possessore di capitale non potrà mai avere i mezzi per conoscere l’andamento dei mercati globali e indirizzare somme sufficienti a valorizzarsi. Ovviamente questo risultato non è garantito neppure a chi ha tali mezzi, ma rimane il fatto che il piccolo capitalista sarà remunerato con criteri interni e il fondo d’investimento o il grande capitalista potranno invece cercare remunerazione «globale». La finanziarizzazione è quindi funzionale al consolidamento di una massa impotente di piccoli investitori presso cui effettuare la raccolta e di una oligarchia finanziaria in grado di indirizzare i capitali raccolti là dove la redditività sia prevista più alta che altrove. È questa oligarchia, per esempio, che gravita intorno al debito estero mondiale e che interviene ogni qual volta la Banca Mondiale debba organizzare una catena di raccolta per un prestito:
«Nessun affare all’interno del paese – scrive la rivista «Die Bank» – arreca neppure approssimativamente i benefici dati dalla mediazione nell’emissione di un prestito estero».
L’esplosione del mercato dei titoli ha avuto come conseguenza anche la sua automatizzazione. Siccome la stragrande maggioranza di essi è trattabile secondo schemi fissi nella routine quotidiana degli scambi, i grandi operatori finanziari raggruppano le operazioni secondo criteri immessi nei programmi dei computer. Ne risulta che la maggior parte della routine non è più seguita dagli uomini ma è lasciata in mano alle macchine, le quali sono anche in grado di avvertire quando i mercati varcano certe soglie di sicurezza e perciò di bloccarsi chiamando gli umani a prendere in mano la situazione.
Il cammino verso l’autonomizzazione del valore nella sua forma finanziaria attuale è stato lungo, ma è irreversibile. Il vincolo monetario, determinato dalla necessità di avere un equivalente generale per tutte le merci, appare caratteristico d’ogni produzione mercantile, in quanto la moneta, ancor prima che strumento di dominio classista è, di fatto, un indispensabile mezzo di scambio. Una volta instauratosi alla scala sociale, il capitalismo reca, tuttavia, decisive novità rispetto alle epoche precedenti: la crescita impetuosa del credito si trasforma nell’illusione di un più facile e veloce rendimento finanziario rispetto ai cicli produttivi, scatenando in breve, di là dal controllo statale (Banca centrale), una erratica circolazione di denaro cui seguono ogni sorta di titoli. La sussunzione dell’industria alla finanza globale è completa.
Nonostante ciò, al vincolo monetario interno restano sottoposte le varie strutture economiche nazionali. Per cui, data l’universale circolazione di merci e capitali, ciascuna moneta nazionale deve, com'è ovvio, poter essere scambiata sul mercato mondiale. Dalla mancanza di una specifica fiducia verso una specifica moneta nazionale discende l’obbligo di una moneta internazionale su cui riversare la fiducia, cui riferire di volta in volta le diverse valute locali.
Con la fine del metallismo e la progressiva smaterializzazione della moneta (soppressione del gold standard) s’afferma, in ambito borghese, l’illusorio convincimento che l’autorità centrale, o uno dei suoi organi, basti a vigilare la massa dei mezzi di pagamento e il volume degli stock valutari. Secondo il criterio imperante, il nuovo sistema valutario si configura, insomma, come un insieme di istituzioni regolatrici della quantità di moneta e statalmente centralizzate. Tuttavia non sono gli Stati che riescono a dominare il Capitale, bensì il contrario, perché proprio lo Stato moderno si trasforma in servizio generale per le esigenze del Capitale.
Nel XIX secolo, ciascuna Banca centrale gestiva moneta con base aurea, ovvero banconote liberamente convertibili in oro. Esisteva, perciò, una moneta-merce, l’oro, che rappresentava l’unità di misura universale. Quando le riserve presero a costituirsi in forma di divise nazionali non più convertibili in oro (ciò che avvenne per la sterlina nel 1931 e per il dollaro nel 1971), sorse l’esigenza di stabilire un’altra unità di misura, che permettesse, finalmente, la serie delle equivalenze monetarie.
Ora, la moneta di credito ha duplice natura: è mezzo di pagamento (proprio come i biglietti di banca) ed è mezzo di finanziamento (massime per prestiti a lungo termine). Da una parte consente lo scambio delle merci; dall’altra, causa il cumulo inarrestabile di debiti/crediti, scaturigine di una circolazione finanziaria con caratteri suoi propri, distinta dalla circolazione mercantile semplice.
Attraverso prestiti e acquisti di titoli e azioni, viene scambiato denaro contro crediti o diritti (merci sui generis, per dirla con Marx); si determina, allora, una circolazione finanziaria che, a differenza di quanto avviene per la circolazione semplice, non subisce direttamente la legge del valore; e più si mondializza questa circolazione, più gli oggetti della circolazione sembrano staccarsi dalla necessaria radice da cui il Capitale prende corpo, cioè la produzione di plusvalore. La frenetica ricerca di guadagno attraverso la circolazione deve fare i conti lo stesso, beninteso, con la produzione e lo scambio di merci e servizi vendibili, ma assume inevitabilmente una crescente autonomia. Se potesse slegarsi del tutto dal capitale industriale, come pretende, essa negherebbe le stesse relazioni di credito, sino a inficiare la validità della moneta creditizia sulla quale è nata la variegata e numerosissima schiera di strumenti finanziari. Ma non può farlo, perché separarsi completamente dalla circolazione delle merci e dei capitali o dalla moneta come equivalente generale, significherebbe per essa diventare meramente speculativa e, alla fine, distruggersi da sola.
La smaterializzazione della moneta trasforma in semplice segno monetario la moneta-merce, ma conserva tuttavia, necessariamente, la relazione col valore delle altre merci. Definiti come segni di valore, i differenti tipi di moneta riproducono l’equivalente generale e sono fra loro convertibili, a condizione che ciascuno di essi verifichi, in ultima analisi, la legge del valore. La sottomissione della moneta nazionale alla legge del valore viene provata dalla convertibilità in altre monete nazionali. Una possibile regolamentazione è data dal continuo aggiustamento della moneta nazionale nei confronti di altre valute (svalutazione o rivalutazione) per mezzo di un’unità di misura universale.
Se la moneta-merce fosse ancora l’oro, la verifica della legge del valore non presenterebbe nessuna difficoltà. Ma di fatto l’oro non è più, per ragioni storiche, l’unica moneta universale e perciò l’autonomizzazione finanziaria, creandosi persino un lessico specifico, si impone alla percezione degli uomini in modo prepotente, specie ora che la mondializzazione degli scambi è un fatto naturale.
La moneta oggi dominante, il dollaro, fatte proprie alcune caratteristiche della moneta mondiale (strumento di circolazione, mezzo di riserva, mezzo di pagamento universale) rappresenta solo nominalmente una moneta-merce, cioè un’unità di misura universale come un tempo era l’oro, per cui non può verificare la legge del valore per ciascuna delle monete nazionali. Occorre tener presente che anche il dollaro è, prima di tutto, moneta nazionale e che perciò, date le caratteristiche degli Stati Uniti, il mondo del dollaro è regolato in base a criteri originati dalla fiducia che il mondo ripone nella superpotenza americana più che dai rapporti effettivi di valore. Il segno di valore rappresentato dal dollaro (che è moneta non più convertibile in oro e neppure coperta da garanzie materiali se non, appunto, il potere economico e militare) è dunque il risultato del rapporto di forza fra monete nazionali e moneta dominante. È ovvio che anche le antiche lettere di credito erano basate sulla fiducia nella potenza dei mercanti-banchieri benché la somma dei valori di cui erano portatrici sorpassasse di gran lunga quello delle riserve metalliche e delle merci fisicamente presenti nei magazzini; ma quello che ci interessa è sottolineare la globalizzazione di questo aspetto, per cui oggi esiste un solo grande titolare di «fiducia» per tutto il mondo.
In queste condizioni il denaro può fisicamente scomparire e diventare un mero segno compensatorio fra transazioni. Già vano fantasma sub specie di moneta scritturale, il danaro viene trasformandosi in entità del tutto impalpabile, resa da cifrette telematiche e fuori d’ogni possibile controllo. Le transazioni in moneta elettronica, sia tramite smart chip card o in Rete, assommano ormai a settemila miliardi di dollari all’anno, pari all’87 % dell’intero prodotto lordo americano[25].
Ovunque, finita l’era delle grida fra broker scalmanati, le borse titoli e materie prime si scambiano tramite i circuiti di un’immensa rete di computer dove tutte le corbeille del pianeta sono in connessione diretta e simultanea lavorando incessantemente 24 ore su 24. A sequele interminabili di bit si ridurrà persino l’istituto bancario ad uso del semplice correntista, che si collegherà da casa sua facendo alla fine scomparire gli sportelli e forse anche le filiali:
«Sulla strada di un futuro senza sportelli, alcune banche hanno sperimentato forme che consentono di ridurre al minimo gli spostamenti e le perdite di tempo. Banque direct della Compagnie Bancaire (Paribas), First direct della Midland Bank, Banco directo della spagnola Argentario sono alcune esperienze, in campo europeo, di gestione a distanza del rapporto col cliente»[26].
Tra le teorie sulla morte del comunismo vi è quella dell’invecchiamento delle osservazioni di Marx, il quale avrebbe analizzato un capitalismo ottocentesco in cui vigeva la libera concorrenza, il capitale finanziario era poco sviluppato e non erano conosciuti fenomeni monopolistici e imperialistici della portata di quelli odierni.
Marx si dedicò alla ricerca delle leggi dinamiche del capitalismo e quindi del divenire di una società completamente diversa, come risultato della serie storica dei modi di produzione. Il suo lavoro va quindi giudicato in base a questa ricerca e alle sue premesse, non in base a considerazioni empiriche senza fondamento scientifico che appartengono soltanto ad un contesto di lotta di classe; d’altronde esse non richiederebbero neppure un commento, se non avessero presa anche su molti che si pretendono militanti comunisti senza essere in grado di capire ciò che scrisse Marx a proposito della dinamica dello sviluppo. Questa si individua per esempio nella maturità delle categorie capitalistiche presenti, non nel loro peso statistico; e si individua nel legame con l’imperialismo mondiale, non nella condizione particolare in cui versa la popolazione o simili. Marx per primo, proprio perché si occupò di una dinamica, evidenziò le differenze non solo fra i diversi periodi della sua epoca, ma soprattutto fra i diversi paesi, differenze che corrispondevano a tempi e addirittura a epoche, anche se osservate alla stessa data.
La teoria del comunismo, che si basa sulla possibilità di tradurre in termini quantitativi le grandezze di valore e sulla formalizzazione della dinamica cui soggiace la ripartizione di quest'ultimo, non ha mai preso sul serio la teoria borghese della libera concorrenza, smascherandola e dimostrandone l’infondatezza. Il carattere di monopolio di classe sui mezzi di produzione si ripercuote sull’economia e all’interno stesso della classe borghese.
Proprio il capitalismo recente dimostra che, nella ripartizione sociale del plusvalore, questioni di forza economica e politica creano situazioni di monopolio, per cui può esserci differenziale di profitto non solo a causa di innovazione e di capacità generale nella lotta per la concorrenza, ma a causa di posizioni di rendita. In «Mai la merce sfamerà l’uomo» si dice che la teoria della rendita non fu applicata soltanto all’agricoltura,
«ma a tutte le forze naturali; valgono quindi anche per la economia della macchina a carbone o benzina; di quella idroelettrica e della futura motrice nucleare, tutte attuali e prossime basi di sovrapprofitti e monopoli e di parassitismi redditieri, che aggravano la scompensazione della forma sociale capitalistica»[27].
In «Vulcano della produzione», si precisa che, data l’origine della rendita in una ripartizione sociale di una parte del plusvalore a favore dei proprietari del suolo, ogni ripartizione forzata dovuta a monopolio si può rapportare alla rendita e trattare con gli stessi criteri teorici.
«La teoria quantitativa della questione agraria e della rendita è quindi la completa ed esauriente teoria di ogni monopolio e di ogni sovrapprofitto da monopolio, per ogni fenomeno che stabilisca i prezzi correnti al di sopra del valore sociale»[28].
Mentre la valutazione corrente del fenomeno monopolio, anche da parte «marxista», si colora di connotati moralistici tutto sommato legati alla negata libertà (di concorrenza), dal punto di vista scientifico è tutt’altra cosa e comporta la visione storica di ciò che il capitalismo diviene. Questo particolare modo di produzione abbassa storicamente l’indice del lavoro sociale necessario a produrre una data quantità di prodotto industriale. Ciò è altamente rivoluzionario, in quanto induce un abbassamento irreversibile della quantità di lavoro necessario all’intera società per riprodursi e vivere secondo le sue esigenze, vale a dire che induce una liberazione massiccia di tempo di lavoro.
Ma fin dagli albori del capitalismo, malgrado la diminuzione del saggio di profitto medio, è sempre necessario un sovrapprofitto da devolvere al monopolio del suolo, degli edifici, delle materie prime, di molte condizioni naturali e artificiali. Diminuisce la quantità di lavoro medio per produrre materie prime e alimentari, ma cresce la quantità di lavoro medio per acquistarli. Siccome queste caratteristiche della proprietà di classe non solo generano il monopolio, ma lo riproducono in tutta la vita sociale, ecco che la possibilità di liberare la specie umana dal tempo di lavoro viene paralizzata, come viene paralizzato lo sviluppo delle forze produttive.
È stato perciò inevitabile che le determinanti materiali del capitalismo di transizione individuate da Lenin nell’Imperialismo avessero il loro sbocco naturale anche nelle forme sovrastrutturali di monopolio. La Sinistra non ebbe nessuna remora a chiamarle nuove forme sociali e politiche, dato che, a differenza degli innovatori opportunisti, nei suoi elaborati ne trattava sul filo di riconosciuti invarianti valevoli per tutto l’arco storico della durata del capitalismo. Queste nuove forme di capitalismo controllato, di collegamento dall’alto fra settori economici, di pianificazione come soluzione dei problemi infrastrutturali del capitalismo, di varo e gestione del monopolio di interi settori (che si accompagna, in altri settori, alla lotta al monopolio espropriatore scaturito dalla libera concorrenza), di manipolazione monetaria e di deficit spending in previsione di effetti moltiplicativi, si concretizzarono per la prima volta in Italia con il fascismo ed ebbero diffusione mondiale, coinvolgendo ancor più la Germania, la Russia staliniana, il Giappone e persino gli Stati Uniti.
In questo processo la borghesia, da classe che deteneva il solo monopolio dei mezzi di produzione e dell’ideologia, diventa una classe che detiene anche il monopolio delle infrastrutture sociali, precedentemente cavallo di battaglia del movimento operaio (società di mutuo soccorso, cooperative, centri di vita sociale). La borghesia, da classe politicamente intesa come classe che agisce esclusivamente per la sua propria conservazione, diviene anche classe che si preoccupa della conservazione del suo antagonista, il proletariato, di cui ha assolutamente bisogno per la sua propria sopravvivenza. Oltre al monopolio dell’ideologia, quindi della «politica», la borghesia assume anche il monopolio della società, comprese le istanze riformatrici del suo avversario politico. E si incarica di organizzare essa stessa il proletariato, fondando sindacati operai e organismi industriali come elementi complementari di un’unica politica statale corporativa. Questo modello è da allora irreversibile e inserisce il proletariato sia nei piani statali di produzione e di concorrenza con gli altri Stati sia in quelli di conservazione capitalistica, cioè nella «politica»[29].
Mentre nella corrente attività parolaia dei rappresentanti borghesi vengono mantenute le antiche parole d’ordine sulla libertà , l’uguaglianza e la fraternità , le stesse che rappresentarono i fattori esplosivi di una classe rivoluzionaria nella sua ascesa, la prassi diviene come non mai quella della libertà conculcata (non nel senso del diritto ma nel senso di intelligenza venduta all’ammasso), della differenza economica come bene ideale, per di più ottenuto per mezzo della stessa fratellanza che può esserci tra le belve che abitano la giungla.
In tale contesto, concorrenza e monopolio non sono più elementi contrapposti delle alterne vicende conosciute dalla società capitalistica, e non sono più neppure nozioni antagonistiche, ma divengono elementi complementari, così come lo sono le classi stesse nello Stato corporativo. Se nella storia del capitalismo la dinamica locale vede uno svolgersi naturale dalla forma concorrenziale verso il monopolio, la dinamica globale vede non solo un movimento ciclico monopolio – concorrenza – monopolio – concorrenza ecc. ma una perfetta simbiosi dei due, per cui uno non può esistere senza l’altro. Per questo è una pura idiozia il gran lamento sulla demolizione del cosiddetto stato sociale: il meccanismo intrinseco del fascismo è di per sé stesso «stato sociale», e ogni nuovo provvedimento escogitato dai politici non può che riguardare una redistribuzione del plusvalore nella società per mantenerlo in efficienza, come tra l’altro insegnano proprio gli Stati Uniti, che nessuno sospetta di mancato liberismo capitalistico.
Il budget americano per il 1997 è stato di 1600 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali assorbiti dalle spese sociali che sono state così distribuite: 22 % per le pensioni statali; 11 % per le cure ospedaliere; 6 % per l’assistenza medica; 6 % per il sussidio alle famiglie povere; 6 % per le pensioni federali e il sussidio ai contadini poveri. Il totale rappresenta il 51 % del budget, vale a dire più di 800 miliardi di dollari. In Italia la spesa per la protezione sociale nel 1998 è stata di 482 000 miliardi di lire, pari al 52 % della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche (paragonabile al budget americano). Come si vede, in proporzione non c’è gran differenza[30].
Il monopolio della protezione sociale diventa la regola, mentre intorno ad esso è lasciata proliferare in modo più o meno controllato l’industria dell’assistenza privata, quest'ultima fornitrice funzionale del primo di merci e servizi strapagati. E anche in questo caso l’aggettivo «privata» non è dei più appropriati, dato che l’intero mondo della produzione, specie nel campo della salute e dell’assistenza, è regolato dall’alto tramite un sistema permanente di leggi, incentivi e manovre economiche. Negli Stati Uniti è per esempio in corso il boom della polizia e della carcerazione privata con tutti gli annessi e connessi (dai bounty killer alla refezione carceraria, dall’elettronica per lo spionaggio alla sartoria specializzata in casacche e divise), per cui il crimine, oggi più che mai, è una reale fonte di valore che accresce i parametri ufficiali dell’intera economia.
Il monopolio, che si manifesti direttamente attraverso lo Stato oppure attraverso una liberalizzazione pianificata dallo Stato, non cambia di natura, ma solo di forma: nel primo caso si ha una ripartizione sociale diretta del plusvalore proveniente dai settori produttivi; nel secondo caso si ha l’appalto, la concessione o la regolamentazione legislativa, cioè la formazione di settori cui è lasciata la gestione di determinati servizi e produzioni che assorbono plusvalore attraverso lo Stato o se lo creano in quanto strutture aziendali che vendono servizi o altra merce corrispondente ai bisogni sociali[31].
In ogni caso siamo di fronte al fenomeno grandeggiante e irreversibile del controllo economico dall’alto, sempre funzionale alla creazione di valore, dato che il servizio pubblico gratuito è settore improduttivo e deprime l’andamento del PIL. Le attività sociali, strappate ormai da tempo alle prime organizzazioni operaie e al riformismo, coinvolgono pienamente le organizzazioni sindacali, che diventano così delle mere appendici dello Stato, strumenti affidabili in primo luogo di concertazione tra le classi, ma anche di stabilità del monopolio complessivo del sistema sociale da parte di una determinata classe, quella borghese.
La situazione appena descritta è il prodotto (e sta al vertice) di una dinamica storica il cui schema è ben descritto da Marx come ricorrente. Ma non si tratta di una ricorrenza che potrebbe essere semplificata con un cerchio, percorso il quale ci si ritrova al punto di partenza, bensì come una spirale che, oltre le due dimensioni, ha anche uno svolgimento in verticale, verso un punto limite. Il capitalismo nasce statale monopolista e imperialista grosso modo con le repubbliche marinare di mille anni fa, si fa potente con le flotte di Portogallo, Spagna, Olanda e Inghilterra, con le varie Compagnie delle Indie e con l’esplosione dei mercati e della «libera concorrenza»; diventa modo di produzione industriale e introduce le macchine, per cui tende a cadere il saggio di profitto; conosce i cicli di crisi; ristruttura, aumenta ulteriormente la composizione organica del capitale, centralizza ed espropria capitalisti; rientra in crisi ad un livello parossistico accentuando la concorrenza; infine ritorna statalistico, imperialistico, nascono i trust, il capitale si centralizza, internazionalizza, e spinge la concorrenza interna fuori dei confini statali, fino a coinvolgere l’intero globo nella ripartizione mondiale del plusvalore. A questo punto, cioè all’analisi del mercato mondiale e a quella del gioco fra le classi, doveva giungere il lavoro di Marx, che morì prima di portarlo a termine; un lavoro che avrebbe dimostrato, forse più chiaramente di quanto già non si intraveda, la dinamica a spirale, questa circolarità che porta ad un accumulo di forze e di contraddizioni ad un livello sempre più alto e che egli a più riprese definisce come forza dirompente della società futura.
Dunque l’espansione planetaria dello scambio mercantile e delle alterne vicende fra monopolio (statale o meno) e libera concorrenza è fatto ben anteriore all’epoca nostra (e a quella di Marx medesimo). Alla morte di Marx, nel 1883, il mercato era già pienamente «globalizzato»: consumava merci, contro moneta convertibile, il 90 % della popolazione mondiale; il Reich di allora dipendeva dal capitale internazionale almeno quanto, oggi, la Repubblica Federale Tedesca[32].
Assumendo con Marx che il paese industrialmente più avanzato non fa che mostrare a quello meno sviluppato l’immagine del suo avvenire, ricorderemo che il primo paese a divenire capitalista fu l’Inghilterra, che alla metà del XIX secolo, con l’introduzione del libero commercio e l’esercizio della funzione di «opificio» di tutto il mondo, determinò il primo monopolio globale, cioè delle merci e della moneta, in seguito minato dall’estendersi di dazi protettivi nei paesi capitalistici. Ma se il monopolio è una tendenza naturale dello sviluppo capitalistico, esso non poteva rimanere isolato: agli albori del XX secolo si formò un sistema di monopoli, che determinarono nei maggiori paesi capitalistici gigantesche eccedenze di capitale.
«La concorrenza ha consumato sé stessa» – scrive Bucharin. «A misura che essa si accentuava, progrediva la centralizzazione, poiché i capitalisti più deboli andavano più presto in rovina. In ultimo la concentrazione del capitale, provocata dalla concorrenza, uccise la concorrenza stessa. Al posto della libera concorrenza subentrò il dominio delle associazioni monopolistiche dei sindacati e dei trust»[33].
E afferma che nell’industria tessile americana, intorno al 1920, più del 50 per cento delle fabbriche era controllata dai trust, in quella del vetro il 54 per cento; in quella della carta il 60 per cento; in quella metallurgica l’84 per cento; in quella siderurgica l’84 per cento; in quella chimica l’81 per cento, e così via, giungendo alla conclusione che
«l’intera produzione dell’America è ora concentrata nelle mani di due trust»,
quello del petrolio e quello dell’acciaio (dai quali, tra l’altro, dipendevano tutti gli altri). Nel 1913 in Germania il 92,6 per cento della produzione del carbone nel bacino renano-vestfalico era nelle mani di un solo trust, mentre il trust siderurgico produceva quasi la metà dell’acciaio e quello dello zucchero il 70 per cento per il mercato interno e l’80 per cento dell’esportazione, ecc. Con il fascismo e le politiche democratiche successive alla Seconda Guerra Mondiale, la siderurgia, l’energia, le comunicazioni, la chimica, i trasporti ecc. divennero in Europa monopolio totale degli Stati, per cui risorse essenziali furono messe a disposizione del Capitale e dell’accumulazione generale, a dimostrazione che la borghesia non correva soltanto verso forme di monopolio industriale, cioè dei mezzi di produzione, ma anche verso forme di monopolio sociale.
Era dunque impossibile che il fenomeno del monopolismo, di per sé per nulla recente nel processo del modo di produzione capitalistico, rimanesse isolato in certi periodi storici: esso doveva assumere forme sociali permanenti, magari nascoste da una «liberalizzazione» sottomessa al controllo delle cosiddette parti sociali e, soprattutto, a quello delle leve legislative ed economiche che servono a trattare ogni variabile come parte di un unico sistema dinamico. Tuttavia, il successo borghese nel controllo di alcuni parametri macroeconomici non ha nulla a che fare con un superamento dell’anarchia insita nel modo di produzione capitalistico. Essendo il capitalismo di per sé monopolio di classe, tutto il capitale si accumula sempre più come dotazione non di persone o ditte, ma di una classe dominante. E questa classe non può fare a meno, ne sia cosciente o no, di rispondere alle sollecitazioni che vengono da un mondo che si apre alla concorrenza globale, in cui non è più permesso non fare ciò che fanno tutte le altre borghesie, a cominciare dalle più forti e agguerrite. La concorrenza rimane concorrenza anche se esplode fra Stati oltre che fra aziende, anzi, diventa guerra spietata, che provoca l’eliminazione dei meno adatti, appunto come nella giungla, e induce nei più adatti organi di difesa e di offesa sempre più robusti. Il monopolio, privato o pubblico che sia, è la conseguenza inevitabile. Globalizzazione significa perciò anche evoluzione dell’assetto mondiale verso il monopolio del paese di gran lunga più forte, situazione che la Sinistra ha più volte analizzato per un quarto di secolo dal 1945 in poi.
Questo punto di arrivo, che Lenin vedeva nel condominio di un pugno di paesi con a capo l’Inghilterra, è ulteriormente semplificato dalla vittoria americana del 1945, che spazza via gli altri imperialismi, trasformandoli da protagonisti che contavano qualcosa sulla scena storica in comparse a volte un po’ patetiche. Da allora tutti i paesi hanno più bisogno del mercato americano di quanto gli americani abbiano bisogno di tutti i loro mercati messi assieme; da allora gli Stati Uniti non hanno successori nella sequenza storica dei paesi imperialistici tratteggiata da Marx (repubbliche marinare, Venezia, Portogallo, Spagna, Olanda, Inghilterra) ed è impossibile che una coalizione di paesi concorrenti fra di loro possa rappresentare una forza unitaria in grado di ereditare il trono americano.
La sequenza è stata esattamente quella prevista da Marx ed è stata inesorabile: morto e sepolto il laissez-faire (mai esistito al di fuori dell’ideologia: la sola potenza sociale in grado di servire sul serio il Capitale era ed è lo Stato)[34], dimostratasi inoperante la legge della mano nascosta che aggiusta ogni stortura, col keynesismo in tutte le sue varianti si demanda a forze sociali il controllo del fatto economico generale. Non poteva questo fatto non ripercuotersi a livello mondiale: il controllo del fatto economico in ambito internazionale è affidato a potenti organismi appositi, i quali non possono che dipendere dalle leggi del capitalismo e quindi dal capitalismo più forte. È infatti un’assurdità «incolpare» il Fondo Monetario Internazionale o la Banca Mondiale di fare gli interessi americani, quando da tali interessi dipendono tutte le altre economie.
Come il borghese viene disertando la produzione materiale per farsi rentier, cedolista, trafficante in titoli di credito – per divenire, insomma, figura non più necessaria al meccanismo economico, decisamente soppiantata dall’anonimo capitale delle grandi società per azioni – così lo Stato più forte in ambito mondiale assume la missione globale di rentier, ricavandone anche forza esuberante da indirizzare verso compiti di polizia. Quando i democratici antifascisti dicevano (al tempo delle manifestazioni al grido di «Yankee go home», oggi alquanto passate di moda) che la politica americana è una politica fascista, lo dicevano nel fetentissimo senso partigianesco russofilo (dopo essere stati culo e camicia con il Yankee addirittura in guerra mondiale), ma paradossalmente avevano ragione. Non perché gli americani fossero ideologicamente fascisti, ché anzi, sono sempre stati i campioni della democrazia, dei diritti dell’uomo e via dicendo, ma perché il fascismo è progressivo rispetto alla democrazia, dato che nella storia viene cronologicamente dopo e nella maturità del Capitale anche. Ecco che allora il gendarme del mondo, assumendosi il problema del controllo economico tramite gli organismi internazionali, non può fare a meno di assumersi anche il controllo politico globale, realizzando fino in fondo la dottrina enunciata da Monroe, che stabilì la non ingerenza americana negli affari europei in cambio della non ingerenza europea negli affari americani («l’America agli americani»). Ma quale può essere la natura della dottrina politica di una non-nazione che già dalle sue premesse storiche si pone come distruttrice delle nazioni? Perché l’America è stata l’affossatrice del colonialismo? Il capolavoro del monopolio politico americano ha la sua origine nel negare il territorio che serve come spazio vitale agli altri nel momento in cui l’America non ha più bisogno di spazio vitale in quanto territorio. Perché lo spazio vitale dell’America fa il giro del globo e non c’è truppa che possa «conquistarlo».
Ci sono armi più micidiali che non le truppe, e non è un caso che merci di natura particolare abbiano contrassegnato la nascita dell’imperialismo americano invertendo il flusso del commercio con l’Europa. In mezzo secolo l’America sfornò le invenzioni in grado di completare la rivoluzione industriale nata in Europa: il telegrafo, la macchina per cucire, la mietitrice, la macchina per scrivere, la lampadina, il telefono, il fonografo, l’aeroplano e… la Coca-Cola. Nello stesso periodo, nonostante i 600 000 morti e il blocco demografico dovuto alla guerra civile, la popolazione saliva da 30 milioni di abitanti a 90 milioni, la maggior parte composta di uomini disperati accorsi dall’Europa a fornire forza-lavoro.
Il centro americano di potere e di controllo è il prodotto necessario della maturità capitalistica, è il depositario delle funzioni che il Capitale demandava agli Stati delle borghesie nazionali e che ora non può far altro che demandare ad uno Stato che abbia il monopolio della forza, sia in senso potenziale (economia politica) che in senso attuale (guerra). Se Marx diceva:
«Trasformazione del capitalista realmente operante in semplice dirigente, amministratore di capitale altrui, e dei proprietari di capitali in puri e semplici proprietari, puri e semplici capitalisti monetari. Anche quando i dividendi che essi ricevono comprendono l’interesse e il guadagno d’imprenditore (…) questo profitto totale è intascato unicamente a titolo d’interesse, ossia un semplice indennizzo della proprietà del capitale, proprietà che ora è, nel reale processo di riproduzione, cosi separata dalla funzione del capitale come, nella persona del dirigente, questa funzione è separata dalla proprietà del capitale (…). Questo significa la soppressione del modo capitalistico di produzione, nell’ambito dello stesso modo di produzione, quindi è una contraddizione che si distrugge da se stessa, che prima facie si presenta come semplice momento di transizione verso una nuova forma di produzione»[35],
come dobbiamo interpretare l’ulteriore maturità del capitalismo (ulteriore massimo sviluppo della produzione sociale) che mette il paese più forte del mondo nelle condizioni del singolo capitalista rentier diventato inutile? A che punto è giunta la soppressione del capitalismo entro lo stesso modo capitalistico di produzione? Oggi a porsi domande à la Marx c’è da passare per matti, ma occorre insistere per non cadere al livello di coloro che sacrificano i frutti futuri per un effimero successo immediato.
Nel suo processo di valorizzazione il capitale tende a trascendere le barriere e i pregiudizi nazionali, distruggendo qualsivoglia ostacolo allo sviluppo delle forze produttive, all’espansione dei bisogni, allo sfruttamento dell’uomo e della natura.
Nella citata definizione dell’OCSE, sulla globalizzazione come processo di progressiva interdipendenza ed integrazione tra i diversi paesi, troviamo implicita l’allusione a un novus ordo, cornucopia dispensatrice di «Ordine e Progresso», come recita il motto iscritto nel globo della bandiera del Brasile (a dire il vero un po’ beffardo, stando alla crescita caotica e terribile di quel paese).
La Sinistra Comunista paragonò il nuovo ordine mondiale a quello vecchio, ma sottolineò una differenza essenziale, che è la stessa di cui Marx avverte più volte il lettore: attenti che «il capitalismo non è una ‹cosa› ma un movimento» e quindi è sempre arbitrario parlarne in modo statico.
Il vecchio imperialismo si espandeva in terre quasi spopolate e vergini, su cui abitavano popolazioni che non avevano raggiunto lo stadio della produzione scientifica e quindi non avevano titoli per sfruttare le risorse del territorio. Minerali e vegetali erano di chi li poteva immettere nel ciclo capitalistico ed erano acquisiti (comprati o rapinati) secondo il diritto della produzione. Sfruttando le materie prime, i colonizzati e anche gli stessi coloni civilizzatori, il vecchio imperialismo esaltò i profitti del capitale in madrepatria e le diatribe fra vecchi imperialismi scoppiarono per la ripartizione del territorio fisico.
Il nuovo imperialismo ha lo stesso obiettivo di accumulare e di valorizzare il capitale in madrepatria, ma non agisce più in un mondo vergine e spopolato, bensì in quello attuale già acquisito ai meccanismi capitalistici più moderni e per di più straboccante di umanità oppressa e affamata. Esso non pianifica più occupazione di territori e non vi impianta più la sua stabile guardia armata, ma agisce attraverso il monopolio globale della massa finanziaria e della forza fisica tecnologicamente senza pari per ottenere lo steso scopo:
«altissimi profitti nel paese imperiale e relativo alto tenore di consumo e di vita in esso, in modo che sia assicurata la riproduzione incessante di 'risparmio’ da investire»[36].
Per «risparmio» si intende ovviamente non quello dello Stato o delle famiglie, che in America non esiste (è il paese con il debito totale più alto che ci sia) ma il differenziale fra capitale investito e plusvalore di ritorno.
Ora, siccome tutti i paesi imperialistici, maggiori e minori, si trovano nelle stesse condizioni seppur subalterni rispetto agli Stati Uniti, ecco che la lotta per il controllo delle colonie, cioè dei territori, viene sostituita dalla lotta per la ripartizione del plusvalore prodotto nel mondo. Le cannoniere vengono sostituite da meno grossolani strumenti, e i proiettili non esplodono più direttamente sui corpi dei colonizzati, ma non per questo i danni alle popolazioni privilegiate dalle attenzioni del Capitale sono più lievi, mentre i nuovi colonizzatori non rischiano un fantaccino, demandando alle borghesie locali e ai loro eserciti i compiti di polizia ordinaria. Dei compiti di polizia straordinaria abbiamo più volte parlato[37].
Riguardo alla internazionalizzazione o globalizzazione del capitale, che sarebbe foriera di pace tra i popoli, sarà opportuno ricordare che anche oggi, come ai tempi di Lenin, si tratta di una vera e propria spartizione del mondo. Anche se non si tratta più della lotta per il territorio fisico ma di quella per il territorio economico, i capitalisti vi aderiscono volenti o nolenti con mezzi proporzionati alla potenza dei loro Stati. Non lo fanno per una qualche particolare malvagità, come sembrano credere gli anti-imperialisti di maniera, ma per la imprescindibile necessità del Capitale che deve impadronirsi di tutti gli aspetti della produzione nel mondo globalizzato, far diminuire di prezzo gli elementi del capitale costante e far fronte, così, alla caduta tendenziale del saggio di profitto. Solo che il processo non avviene più attraverso la conquista diretta della forza-lavoro e delle materie prime a basso prezzo, ma attraverso l’azione del capitale finanziario che, come s’è visto nell’ultima crisi asiatica, si impegna a fondo per azzerare i parametri economici (valore della forza-lavoro e valore degli elementi costitutivi del capitale costante) che lo sviluppo economico tende a far salire al livello dei vecchi paesi industrializzati.
Per questo diciamo che il monopolio finanziario e militare del nuovo imperialismo non permetterà ai paesi cosiddetti emergenti di emergere sul serio: l’America Latina, l’Asia, l’ex URSS, l’Africa, sono tutte aree destinate a svolgere un ruolo subordinato nei confronti del Capitale mondiale (quindi non solo americano) teso a valorizzarsi attraverso la conservazione del suo strumento più potente. In questa prospettiva non saranno certo i salari dei paesi emergenti a salire verso quelli delle metropoli imperialistiche, ma, al contrario, saranno i salari delle metropoli a confrontarsi sempre più spietatamente con quelli dei paesi emergenti. Gli imperialismi minori, che non hanno la potenza necessaria per svolgere in proprio questa funzione di salvaguardia del loro saggio di profitto, non sono per nulla alleati agli Stati Uniti, sono legati.
Ecco come si spiega la potenza economica e politica dell’America che, nonostante il continuo decadimento della produzione industriale, indice sensibile della caduta del saggio di profitto, sembra non conoscere limiti ad un ulteriore sviluppo, ad un ulteriore accumulo di potenza. Ma la forza apparente è nello stesso tempo una debolezza di enorme portata: non è più il mondo che dipende dalla «locomotiva» americana ma è l’America che dipende dal mondo. Il capitale finanziario è mero capitale fittizio quando non sia garantito dalla sicurezza di una immediata o futura estorsione di plusvalore, e non è detto che questa estorsione sia garantita dagli attuali meccanismi di controllo economico globale. Il Capitale stesso è diventato un’entità globale, come era nelle sue premesse storiche, e nessuna forza al mondo può controllarne l’anima distruttiva nei confronti della sua propria base.
Il compito storico del capitalismo – e questo è un assioma comunista – è quello di sviluppare le forze produttive; ma sappiamo che al tempo stesso, in conseguenza dei rapporti sociali che gli corrispondono, così facendo, il capitalismo stesso pone le premesse per il suo superamento. La produzione altamente socializzata e l’abbassamento del valore unitario delle merci prodotte nel mondo è la conseguenza dell’aumentata forza produttiva, ed è anche l’unica base possibile per la società futura, che Marx individuava come «passaggio dal regno della necessità a quello della libertà ».
Questo passaggio è inscritto nelle caratteristiche del paese più evoluto e potente del mondo. Nonostante il suo inarrivabile potere di controllo, esso perde continuamente terreno su tutti i fronti. Proprio perché vive di rendita, esso è destinato a conservare questo privilegio con le unghie e con i denti, finché l’immensa quantità di capitale che rappresenta non diventerà effettivamente fittizio, cioè non sarà più garantito da plusvalore estorto in qualche parte del mondo. Il ciclo attuale non può essere infinito, è finito, e le cifre lo dimostrano.
Dal 1950 il prodotto mondiale è cresciuto, annualmente, del 4 % circa; nello stesso tempo lo scambio di merci è aumentato di oltre il 6 %. Ciò significa che, fatto 100 l’indice per entrambi al 1950, oggi il prodotto mondiale è a 683 e lo scambio di merci a 1738, vale a dire che è variato in volume due volte e mezza di più. Ma la quota di mercato detenuta dagli Stati Uniti non ha fatto che scendere dalla Seconda Guerra mondiale in poi, da più della metà a meno di un quarto. Ciò che però caratterizza negativamente il futuro capitalistico è l’immenso divario fra la circolazione di capitale in cerca di valorizzazione e quella di capitale che si muove per investirsi in luoghi già individuati. Nel 1995, quindi in un intero anno, l’export di capitale produttivo ammontava a 317,8 miliardi di dollari contro, secondo stime ufficiali, 1500 miliardi di dollari che circolano ogni giorno, entro la rete computerizzata del mercato finanziario mondiale. E questa cifra, tanto per avere dei riferimenti, rappresenta il doppio rispetto al totale delle riserve valutarie OCSE, il quadruplo rispetto al costo del greggio estratto in un anno, oppure sessanta volte l’insieme degli scambi mercantili mondiali[38]. Tale cifra sale a non meno di 3000 miliardi di dollari se si includono i giganteschi traffici della cosiddetta economia informale, i cui profitti, sia detto per inciso, superano abbondantemente i 1000 miliardi di dollari l’anno, segno che per ora il flusso di plusvalore è in qualche modo garantito anche fuori dai flussi ufficiali. Ma è l’immensità delle cifre che non ha più rapporto con un’economia «normale» e più d’un economista borghese, sulla base di modelli più o meno realistici, già da anni mette in guardia contro questa situazione: Wall Street non può salire del 36 % all’anno quando l’economia reale, cioè il valore prodotto ex novo in un anno cresce del 3 %. Se la crescita borsistica attrae lo stesso capitali per alimentarsi, ciò significa che sono in atto meccanismi drogati in grado di esplodere in overdose.
A questo punto è facile immaginare, anche senza sofisticati modelli, gli effetti devastanti che avrebbe una perdita di controllo sul sistema, dato che la maggior parte degli Stati nazionali del mondo sono ridotti, obiettivamente, alla imbelle condizione di «albergatori» per il Capitale che, come dice Marx, «si libera in un determinato paese», e non hanno la minima possibilità di intervento autonomo per salvaguardare le proprie economie[39]. Ciò è tanto evidente che, visti i recenti sconquassi in America Latina, Sud Est dell’Asia ed Europa orientale, molti fra gli stessi «speculatori» come i Soros o i Vender, invocano da un po’ di tempo un più stretto controllo mondiale su economia e finanza da parte di governi e grandi organismi internazionali.
Persino i soci del Long Term Capital Management, importante fondo di investimento americano che finì sull’orlo della bancarotta facendo fare una figura meschina ai suoi economisti appena insigniti del premio Nobel, invocano regole, dopo essersi arricchiti grazie alla loro mancanza. Si richiedono, in altri termini, le migliori condizioni per la realizzazione dello scambio, attraverso l’abbreviazione del tempo di circolazione, che è quello in cui il capitale non si valorizza. Scrive il «Financial Times»:
«L’FMI e la Banca mondiale devono cominciare a interrogarsi sulla spiacevole possibilità che, in certi casi e nel caso di specifiche applicazioni, il controllo dei capitali può certamente essere la meno cattiva delle opzioni».
Ma quale forza al mondo è in grado di controllare le mosse del grande monopolio economico, finanziario, politico e militare americano? La meno cattiva delle opzioni sarà ancora il controllo americano sui capitali altrui.
Abbiamo visto con Marx che il Capitale, in quanto valore che si valorizza, non va mai inteso come un oggetto nelle mani di una qualche persona ma come una dinamica propria di una specifica società, un’energia sociale che abbisogna del potere di una classe precisa e che ha bisogno dello Stato come servizio. Marx precisa che non bisogna far confusione sulle astrazioni, perché esse rendono conto della realtà meglio dell’osservazione empirica:
«Coloro che considerano questo autonomizzarsi del valore come pura e semplice astrazione, dimenticano che il movimento del capitale industriale è questa astrazione in actu. Il valore percorre qui forme differenti, differenti movimenti, nei quali si conserva e contemporaneamente si valorizza, si ingrandisce […]. I movimenti del capitale appaiono come azioni del singolo capitalista industriale, di guisa che questi opera come compratore di merci e di lavoro, come venditore di merci e come capitalista produttivo, dunque con la sua attività fa da mediatore del ciclo»[40].
Quando si attribuisce al capitalista la responsabilità delle pene proletarie o al proletario la condizione penosa dello sfruttato in senso morale, si dimentica che le persone fanno da mediazione ai cicli economici e che ciò che conta non sono i loro «sentimenti» da sfruttatori o da sfruttati ma i loro rapporti in quanto appartenenti a classi sociali precise. Così quando si attribuisce ad una nazione la responsabilità del suo essere imperialista, monopolista del potere e dell’economia, non si fa altro che riflettere su di essa la concezione antropomorfica che si ha dell’individuo capitalista o proletario. Le partigianerie tra partiti e Stati somigliano molto a quelle tra persone: tutti possono essere amici o nemici degli individui, ma i comunisti saranno solo e sempre nemici del capitalismo, chiunque lo rappresenti, individui, partiti o Stati.
Quando il Capitale, inteso come forza sociale, subisce una «rivoluzione di valore», cioè induce nuove forme di valorizzazione e nello stesso tempo ne subisce le conseguenze, il capitalista singolo o la nazione capitalista possono soccombere in quanto tali; il capitalista potrà essere espropriato o assorbito da uno più forte, la nazione potrà entrare in crisi o addirittura essere assorbita o smembrata.
«Quanto più acute e frequenti diventano le rivoluzioni di valore, tanto più il movimento del valore autonomizzato, automatico, operante con la violenza di un processo elementare di natura, si fa valere contro la previsione e il calcolo del singolo capitalista, tanto più il corso della produzione normale viene ad assoggettarsi alla speculazione anormale e più grande diviene il pericolo per l’esistenza dei capitali singoli »[41].
È in pericolo l’esistenza dei singoli più deboli, siano essi individui o nazioni. Di qui l’esigenza delle coalizioni, cioè di quel proliferare di accordi regionali e locali sotto le cui sigle (EU, CSI, ASEAN, MERCOSUR, ecc.) si tenta di esorcizzare la propria debolezza nei confronti dei più agguerriti concorrenti. E non serve a nulla darsi da fare per dimostrare che le azioni dei governi o i movimenti dei popoli possono indirizzare i movimenti del Capitale, dacché succede proprio il contrario:
«Queste periodiche rivoluzioni di valore confermano, dunque, proprio ciò che, a quanto si dice, dovrebbero confutare: l’autonomizzazione che il valore in quanto Capitale consegue e che mediante il movimento mantiene e consolida»[42].
Queste rivoluzioni di valore sono i fattori delle diverse forme attraverso cui il Capitale raggiunge i suoi scopi. Vi saranno così periodi nella storia in cui sono opportune politiche liberiste, mentre in altri saranno adatte politiche dirigiste; a volte si assisterà alla proliferazione di piccole industrie in particolari distretti, a volte alla concentrazione e centralizzazione più feroci, come in questi anni. E ogni periodo avrà il suo profeta in economia. Qualunque sia la fase attraversata, però, il risultato permanente sarà la massima centralizzazione dell’industria e delle attività capitalistiche, intorno alla quale graviteranno le varianti opportune. Ciò ha prodotto una rete inestricabile e irreversibile di interessi mondiali che non dipende certamente dalla semplice volontà dei singoli, dei governi o dei popoli. Questa rete è fatta di nodi che rappresentano la potenza produttiva raggiunta dal lavoro sociale unendo l’industria propriamente detta con ogni sorta di traffici: le cosiddette imprese multinazionali o transnazionali. Diciamo subito che le multinazionali, secondo il significato del termine, non esistono e che con questo nome vengono identificate imprese a capitale privato con interessi internazionali ma che mantengono un indissolubile legame con il territorio d’origine. Queste imprese, come ogni altra merce, possono essere vendute, cioè alienate, e allora, pur mantenendo gli impianti su di un determinato territorio, dipenderanno da capitalisti di altri paesi. Il capitale si autonomizza al di sopra delle frontiere ma l’impresa rimane un’espressione della proprietà capitalistica, dunque del modo di essere della società borghese, dunque rappresentata da una classe, la borghesia, che è classe nazionale. Per di più in concorrenza con altre classi nazionali. Questa è una delle più esplosive contraddizioni del capitalismo, non è neutralizzabile e spiega in parte perché gli Stati Uniti devono essere il protagonista principale della globalizzazione; mentre la concentrazione capitalistica può procedere per molti capitalisti in parallelo, la centralizzazione avviene per alcuni capitalisti a scapito di altri; ciò ha ripercussioni sui paesi d’origine dei capitali centralizzati: anch’essi devono prima o poi sopravvivere a scapito di altri, centralizzando, cioè assumendo sempre più controllo.
Il fenomeno su cui si forma lo stato rentier moderno non è più assimilabile a quello del vecchio imperialismo coloniale: la maturità del capitalismo e la sua aggressività «nazionale» non si misura più nella riunione giuridica di grandi valori nelle mani di un privato o di uno Stato (non importa se si fa giurisprudenza con le leggi o con le cannoniere), ma piuttosto nella riunione tecnica di mezzi produttivi, di infrastrutture, di comunicazioni, di conoscenza, di organizzazione sotto il controllo di entità anonime e impersonali. Neppure lo Stato ha più il pieno controllo della proprietà giuridica sul Capitale, il quale può fare a meno di tanti vecchi orpelli, mentre la borghesia come classe non può assolutamente fare a meno della sua sovrastruttura di potere per il controllo tecnico: essa non possiede le portaerei, i bombardieri, i marines, ma li utilizza tramite il suo Stato.
L’impresa internazionalizzata è funzionale alla marcia del Capitale verso una sempre maggiore autonomia, ma non è di per sé stessa autonoma rispetto allo Stato della borghesia nazionale.
Normalmente per multinazionale o transnazionale si intende un’impresa che, pur soggetta ad un unico centro di comando, non soffre particolari vincoli nazionali. In pratica sono multinazionali tutte le società operanti, sul mercato mondiale, attraverso filiali e investimenti esteri.
Il fenomeno è grandeggiante. Dall’inizio degli anni '80, le prime 200 imprese multinazionali hanno conosciuto una espansione ininterrotta, grazie alla quale esercitano un dominio pressoché totalitario sulle transazioni internazionali. La concentrazione delle imprese costituisce una costante del capitalismo, ma ciò che caratterizza l’impresa di cui ci stiamo occupando è la centralizzazione. Infatti i suoi investimenti esteri si focalizzano su di un settore, ma tendono in seguito ad un controllo di attività diversificate, per cui non ha più importanza il prodotto ma la rete di interessi posti sotto tutela centrale (e spesso questa rete coinvolge anche gli apparati statali dei paesi interessati).
Dalla metà degli anni '70 l’accumulazione si realizza essenzialmente attraverso fusioni, riscatti, annessioni di imprese. Combinata con la colossale espansione dei flussi finanziari, speculativi e non, essa richiama investimenti. Tutto questo non ha prodotto, però, l’auspicata ripresa economica, verificando l’assunto di Marx sulla centralizzazione e smentendo le previsioni espresse, per esempio, nel «Bulletin du FMI» del 21 ottobre 1998:
«Supponendo che i paesi non cambino politica, la crescita mondiale, secondo le proiezioni dei servizi del FMI, passerà al 4,5 % in media all’anno nel corso del periodo 1998–2001».
Il trend di crescita globale è attualmente intorno al 2 % e lo scarto di due punti e mezzo rappresenta più della metà sulla previsione. Non male come precisione dei modelli borghesi. Del resto, proprio la centralizzazione ha aggravato lo stato dell’occupazione e la percentuale di utilizzo degli impianti. Nelle fusioni vengono in genere licenziati quei lavoratori le cui funzioni si sovrappongono, mentre economie di scala e razionalizzazioni provocano la concentrazione della produzione sugli impianti più moderni e l’abbandono di quelli obsoleti, che spesso vengono tenuti in funzione solo per ragioni sociali. In Italia molti stabilimenti Fiat, Olivetti, Pirelli, ecc. sono praticamente inattivi, per quanto nuovi, ma fanno media perché adibiti a lavorazioni fantasma, un po’ per accordi sindacali, un po’ per evitare il degrado degli immobili. Ne consegue che le industrie manifatturiere dell’area OCSE lavorano attualmente al 70–75 % della loro capacità e il numero dei disoccupati supera i 41 milioni. Il debito industriale complessivo ha superato i 33 100 miliardi di dollari, pari al 130 % del PIL mondiale, e progredisce a un tasso del 6–8 % l’anno, vale a dire il quadruplo della crescita del PIL mondiale.
Alcuni dati di fonte Fortune, sulle realizzazioni delle 500 maggiori imprese globali, ci provano ulteriormente quanto stia marciando la centralizzazione:
«Esse hanno travolto le frontiere, per impossessarsi di nuovi mercati ed inghiottire i concorrenti locali. Più sono i paesi, più aumentano i profitti. I guadagni delle 500 maggiori imprese sono cresciuti del 15 %, mentre l’aumento dei loro redditi ha raggiunto l’11 %. All’inizio degli anni '90, circa 37 000 compagnie transnazionali, con le loro 170 000 filiali, stringevano nei loro tentacoli l’economia internazionale».
Il concetto che il borghese ha di «reddito d’impresa» (o «utile», risultato netto annuale) è diverso dal nostro di «plusvalore», dato che anche le imposte tolte per avere il netto sono plusvalore; allora c’è da chiedersi come mai, se il valore totale (profitto più salario, ma i salari sono addirittura diminuiti) prodotto in un anno nel mondo sale del 2 %, quello delle imprese che fanno l’economia mondiale sale dell’11 %. La risposta si può trovare solo nel fenomeno individuato da Marx: le maggiori 500 imprese del mondo non intascano soltanto plusvalore prodotto in proprio come succedeva ai tempi della concentrazione, ma riescono, centralizzando il controllo su produzione e mercati, a ripartire a loro favore una parte di tutto il plusvalore prodotto nella società[43]. I piccoli e medi capitalisti di tutto il mondo pagano un tributo ai mostri industriali supercentralizzati. Non c’è altro modo per spiegare il differenziale di crescita del plusvalore, perché nel capitalismo ultrasviluppato i differenziali di forza produttiva locale sono rapidamente abbattuti: i tempi di reazione della concorrenza alle recenti tecnologie, ai metodi organizzativi e alla mobilità internazionale sono rapidissimi e non è possibile per un’industria non stare al passo con i tempi senza chiudere.
Da una parte tutto ciò dimostra quanto sia ingannevole il punto di vista del capitalista singolo che porta i suoi dollari a Wall Street: egli vede l’aumento dell’11 % e non si chiede il perché del 2 %, tanto nelle grandi borse mondiali le società che contano sono quelle censite da Fortune, mica le altre; e investe, e il Dow Jones va a 11 000, forse a 12 000, 20 000, non c’è limite finché il mondo intero vivrà solo per alimentarlo.
Ma dall’altra parte dimostra anche quanto sia ingannevole il punto di vista di quei pretesi anticapitalisti che, comportandosi esattamente nello stesso modo, vedono nelle autoglorificanti cifre borghesi una forza che il capitalismo non ha, vedono che il cadavere ancora cammina, ma non si accorgono che sta in piedi non tanto per forza propria quanto perché gli dà forza l’abbraccio mostruoso tra il proletariato e chi pretende di insegnare qualcosa a quest'ultimo dall’interno delle categorie borghesi. È davvero forte quest'America in grado di imporre ai suoi avversari, anche politici, non solo i prodotti di Bill Gates e di Madonna, ma pure la riverenza per il suo potere e per la sua capacità di mantenerlo in eterno.
Il capitalismo è la base materiale della società futura, l’aumento della forza produttiva sociale che distrugge i rapporti capitalisti all’interno del capitalismo stesso è comunismo, quindi è anche forza nostra, se siamo rivoluzionari comunisti (lavorano per noi! gridarono di fronte ai sordi i nostri solidi maestri). Ed è forza che cresce, e la dobbiamo leggere non col piagnisteo di chi se la fa sotto di fronte al nemico (e si adegua), ma con la fermezza di chi si deve armare conseguentemente.
La maggior parte delle 500 imprese analizzate da Fortune sono transnazionali e la vera potenza della forza produttiva sociale si concentra nelle prime 200 di esse. La quota del capitale transnazionale nel PIL mondiale è passato dal 17 % della metà degli anni '70 al 24 % del 1982 e ad oltre il 30 % del 1995. Dal 1986 al 1996, le fusioni di imprese si sono intensificate al ritmo del 15 % l’anno; seguendo la tendenza, nel 2000 il costo cumulato di queste transazioni raggiungerà i 10 000 miliardi di dollari (il PIL degli Stati Uniti nel 1997 è stato di 8100 miliardi di dollari). Evidentemente, in questo stadio del modo di produzione capitalistico le società transnazionali non hanno altro mezzo per promuovere la propria espansione che quello di assorbire le loro concorrenti, per conquistare nuovi mercati e di conseguenza realizzare economie di scala sul mercato mondiale.
Una volta ampliata e diversificata la propria attività, in forza di fusioni e acquisizioni, le maggiori società transnazionali si sono date struttura organizzativa sempre più articolata: la società madre istituisce uno o più quartieri generali, col compito di sovrintendere a un certo numero di filiali oppure coordinare, su base regionale o interregionale, una determinata produzione (come nel caso di un’automobile le cui parti vengano fabbricate in vari paesi). A ciò s’accompagna, di frequente, un sistema di proprietà «multistrato»: nel primo, stanno i quartieri generali e le filiali appartenenti alla società madre; nel secondo, le filiali appartenenti alle filiali del primo strato; nel terzo, le filiali appartenenti alle filiali del secondo strato ecc. Il controllo della società madre sulle filiali del primo strato (e, pertanto, su quelle dei successivi) si esercita tramite quote sindacate di maggioranza azionaria, ovvero attraverso la gestione monopolistica dell’amministrazione, delle comunicazioni, del marketing, delle risorse tecnologiche, dei marchi di fabbrica ecc. Questo sistema di partecipazioni non serve soltanto ad accrescere la potenza finanziaria dei monopolisti, ma la loro stessa influenza sulle «sovrastrutture di forza» di carattere ideologico-politico (nell’ambito di ciò che va sotto il nome generico di «cultura d’impresa» è contemplata la formazione di un carattere specifico nella mentalità dei dirigenti e dei dipendenti).
Anche se specializzate come marchio in particolari settori dell’industria, dell’agricoltura e dei servizi, le imprese transnazionali estendono quasi sempre la loro attività in campi diversificati: così società agro-alimentari possiedono, oltre a terre e stabilimenti specifici, anche catene di ristoranti, alberghi, miniere, acciaierie, raffinerie, agenzie di pubblicità, agenzie turistiche ecc. Oppure società tipicamente manifatturiere esprimono nel bilancio consolidato una prioritaria attività nei servizi.
La «rilocazione produttiva» non è una novità, ha anzi origini assai lontane[44], ma solo nel dopoguerra è diventata un fenomeno generalizzato, e solo negli ultimi vent’anni, a causa della riduzione (relativa e assoluta) del 60 % sui salari nelle aree periferiche, ha avuto un ulteriore impulso. A partire dalla seconda metà degli anni '80, l’export lordo di capitale propriamente d’industria s’è, perciò, di molto accresciuto, sino a raggiungere, nel 1995, i 317,8 miliardi di dollari (222,5 nel 1990)[45], provenienti, per più dei due terzi, dalle maggiori transazionali statunitensi, giapponesi, tedesche, francesi, inglesi.
Il fatturato consolidato annuo di molte transnazionali è maggiore di quello di alcuni medi paesi (la General Motors fattura 168,8 miliardi di dollari, più del prodotto complessivo della Danimarca) e il giro d’affari delle Global 500, secondo la classifica di Fortune del 1998, è 11 453,5 miliardi di dollari, ovvero pari a circa la metà del prodotto mondiale. Comunque, a dimostrazione della centralizzazione operante, i colossi sono relativamente pochi rispetto al numero delle aziende che sentono il bisogno di rompere i limiti nazionali. Agli inizi degli anni '90 vi erano in tutto 37 530 società attive in campo internazionale su scala planetaria che agivano attraverso 206 961 filiali estere. E il computo non comprende le alleanze strategiche (nell’ordine delle migliaia) e i contratti di franchising o technology transfer (nell’ordine delle centinaia di migliaia). Di tutte queste società i paesi industrializzati ne possedevano 34 280 con 87 831 filiali e solo 3250 erano dei paesi in via di sviluppo, cioè meno di un decimo. Ma queste ultime avevano 119 130 filiali estere (36,6 a testa in media contro 2,5 dei paesi sviluppati)[46].
Poche case-madre e di potenza infinitamente inferiore e un alto numero di filiali rivelano uno squilibrio molto significativo. Mentre le filiali dei grandi complessi dell’imperialismo maturo sono vere e proprie emanazioni locali della forza economica del paese d’origine, quelle delle società dei «paesi in via di sviluppo» sono spesso semplici uffici o negozi, che possono essere moltiplicati senza eccessivo impegno economico (le aziende cinesi, per esempio, hanno ben 45 000 filiali estere). Ciò dimostra soprattutto che le attività imperialistiche non si svolgono tanto tramite le sedi di rappresentanza o di produzione ufficiali quanto, principalmente, tramite le reti di partecipate delle holding, cioè dei pacchetti azionari acquisiti con investimenti esteri, quindi con un controllo su attività produttive e commerciali di altri paesi. Ufficialmente le aziende partecipate figurano come ditte nazionali a sé o come consociate e non come filiali di aziende multinazionali[47], delle quali oltre la metà ha sede nelle cinque maggiori metropoli imperialistiche evidenziate: Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia e Gran Bretagna. E comunque in questo caso l’indagine sulla potenza di quelle maggiori amplia, raddoppiandola, la percentuale di quelle con sede in area di vecchio capitalismo; infatti, se prendiamo le società madri delle prime 200 transnazionali non finanziarie sulle 37 530 del totale, vediamo che il 93,5 % di esse sono lì dislocate: 62 in Giappone, 53 negli Stati Uniti, 23 in Germania, 19 in Francia, 12 in Gran Bretagna, 8 in Svizzera, 5 in Italia, 5 nei Paesi Bassi[48].
In ciascun paese, la maggior parte delle attività estere e degli investimenti esteri è appannaggio, peraltro, di poche holding: in Germania, 50 società (corrispondenti allo 0,7 % delle transnazionali tedesche) controllano il 69 % delle attività estere e il 58 % degli investimenti oltremare; negli Stati Uniti, l’1 % delle società madri controlla il 45 % delle attività estere complessive (il 25 % – 546 imprese – ne controlla il 96 %). Fra le 100 maggiori imprese transnazionali, le prime 10 controllano il 31 % delle attività totali e il 33,5 % di quelle estere; le prime 25, il 50 % e il 54,4 %; le prime 50, il 70,9 % e il 76,3 %[49].
Capaci di formidabili ritmi d’accumulazione, molte imprese transnazionali non fanno quasi più ricorso al capitale azionario e bancario per la loro espansione, raggiungendo, di fatto, l’autofinanziamento tramite risorse interne ottenute con le attività internazionali. Ciò è importante perché dimostra il grado di finanziarizzazione dell’industria, che diventa essa stessa banca (in Italia ogni grande industria si appoggia ad una finanziaria interna, «di famiglia» o meno, anzi, ne è posseduta) e opera direttamente sul mercato finanziario. Queste le cifre relative alle 62 grandi aziende americane prese in esame nel rapporto Mediobanca International Financial Aggregates, per il periodo compreso fra il 1990 e il 1993: azioni emesse, 81 miliardi di dollari; azioni acquisite, 83 miliardi; utili distribuiti, 270 miliardi; investimenti realizzati, 320 miliardi.
In sintesi: crediti verso l’azionariato per 81 miliardi di dollari; valore erogato per 673 miliardi di dollari. Stando a quanto appurato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, le società transnazionali controllano oltre i ¾ dello import-export in area OCSE (negli Stati Uniti, i ⅘) e pressoché tutti i canali del commercio mondiale. Per esempio, Chiquita, Dole e Del Monte soddisfano, da sole, il 75 % del consumo globale di banane. Gli investimenti esteri diretti delle transnazionali, che, abbiamo visto, erano pari a 317,8 miliardi di dollari nel 1995, hanno avuto, approssimativamente, la seguente destinazione: in Nord America, Europa occidentale e Giappone, 205 miliardi; Nei PVS, compreso l’ex Comecon, 112,8 miliardi, per un totale di 317,8 miliardi.
Larga parte di tale denaro è valso ad acquisire aziende pubbliche in corso di privatizzazione, specie nei settori del trasporto aereo e delle telecomunicazioni (in quest'ultimo settore, il valore delle acquisizioni aveva già nel 1990 raggiunto i 16,5 miliardi di dollari, contro i 400 milioni del 1985). Ciò è determinato dalla necessità del capitale di far fronte ai suoi processi di sviluppo in relazione sempre più stretta con la socializzazione della produzione, che necessita di reti di impianti, strade, ferrovie ecc. Queste reti infrastrutturali immobilizzano grandi quote di capitale per lungo tempo e per di più vanno rinnovate con il ritmo delle nuove tecnologie, per cui occorre dislocare masse sempre maggiori di capitale ogni volta che sia necessario riavviare il processo di valorizzazione. Ogni innovazione tecnologica epocale equivale alle antiche crisi che spazzano dalla scena chi non è in grado di evolversi, e ad ogni ciclo la spina dorsale del capitalismo è costituita sempre più da aggregazioni di capitali capaci di far fronte ad ogni evenienza anche in senso di disponibilità monetaria immediata, mentre intorno a questa struttura si muovono cellule capitalistiche che nascono e muoiono senza avere nessuna possibilità di intervenire o anche solo di adeguarsi:
«Quanto maggiori sono le perturbazioni, tanto maggiore capitale monetario deve possedere il capitalista per essere in grado di attendere la compensazione; e poiché con il procedere della produzione capitalistica si allarga la scala di ogni processo individuale di produzione e con essa la grandezza minima di capitale da anticipare, quella circostanza si aggiunge alle altre che sempre più trasformano la funzione del capitalista industriale in un monopolio di grandi capitalisti monetari, isolati o associati»[50].
Al fine di accrescere la produttività e così battere la concorrenza, molte società diventano dunque transnazionali, dislocando le proprie attività in paesi di giovane industrialismo, ove minore è il costo del lavoro (a parità di qualificazione), le strutture sono moderne e consistente è il risparmio fiscale. In presenza di agitazioni operaie o sommovimenti sociali, il capitale transnazionale può trasferire con facilità in altri paesi siti produttivi propri o in appalto a strutture locali. L’esistenza di «paesi di riserva», con abbondante offerta di manodopera a basso prezzo, rappresenta un ricatto potente per scoraggiare possibili aumenti salariali nelle più dinamiche aree di sviluppo (Sud Est asiatico, Messico, Cina, Europa orientale); e quando tale ricatto non sia avanzato direttamente dalle società ci pensano i governi e i sindacati locali a farsene carico.
In questa situazione, fuori da ogni possibile controllo degli Stati, il Capitale precisa la sua funzione matura e, dall’integrazione globale semplice, dovuta a rapporti produttivi tradizionali meramente internazionalizzati, passa ad una integrazione globale complessa, dove i sistemi produttivi, commerciali, contabili e finanziari, si «diffondono» fino a quando l’azienda può essere definita, non in modo metaforico ma con rigore teorico, virtuale: essa può non avere più stabilimenti di produzione, uffici contabili, magazzini, filiali, centri direzionali e demandare tutto ciò a strutture appositamente nate per svolgere i compiti più svariati.
Nel caso dell’integrazione globale semplice, la società madre commissionava a una filiale o a un subcontrattista estero una certa produzione (per la quale forniva capitale, tecnologia, materiali) e poi commercializzava, ovunque nel mondo, il prodotto finito. Larga parte delle transazioni si riduceva, in effetti, a scambio infrasocietario, come nel caso delle maquiladoras, industrie situate in territorio messicano, appartenenti in maggioranza a industrie statunitensi. Superate da tempo le 2000 unità, le maquilas importano dagli Stati Uniti, senza pagare dazio, il 99 % dei materiali necessari alla produzione, ed esportano negli Stati Uniti, pagando dazi minimi, quasi tutto il prodotto (costituito un tempo da tessuti, pellami e giocattoli, e oggi da attrezzature elettroniche, parti di autoveicoli e composti chimici). Così, per esempio, la Ford può affidare a fabbriche di là dal Rio Grande, come fossero sue filiali, particolari lavorazioni ovvero assemblaggi, ricavandone, con poca spesa, merce finita e pronta alla commercializzazione. Il vantaggio è grande, perché il salario messicano rappresenta mediamente, a pari produttività, la decima parte di quello statunitense. È ovvio che considerare questo banale passaggio di frontiera come attività di mercato non è giustificato se non dall’attività statistica nazionale, per cui anche le cifre riguardanti l’economia dei singoli paesi vanno prese con dovuta cautela.
La società madre, affidando la produzione a filiali e subcontrattisti in diversi paesi, sfrutta razionalmente a proprio vantaggio le differenze fra leggi e condizioni locali per l’investimento, la produzione, i servizi, ecc. La statunitense Nike Co. ha, per esempio, subcontrattisti in oltre 40 paesi (soprattutto asiatici). Stabilito il design di una nuova scarpa da ginnastica o di un nuovo capo di abbigliamento sportivo, la casa madre ne trasmette i dati, per via informatica, a una società subcontrattista con sede a Taiwan, la quale, valendosi di progettazione computerizzata, provvede a fabbricare il prototipo. Questo è inviato alla società madre, che decide di avviarne la produzione ovvero apportarvi modifiche. Una volta scelto il design definitivo e stabilita l’ingegnerizzazione di produzione, i dati vengono trasmessi alle fabbriche subcontrattiste, nelle quali il controllo qualità è svolto da tecnici della casa madre. Il prodotto è infine inserito nel complesso marketing di quest'ultima e distribuito nel mondo. E così sono strutturati i maggiori fabbricanti di prodotti di grande consumo.
Abbiamo chiamato «integrazione semplice» una struttura produttiva ormai in via di superamento a causa del successo di un’altra struttura, poco visibile ma operante da molti anni. Possiamo definire strategia di «integrazione complessa» quella di una holding che abbia superato lo stadio descritto, e in cui le filiali, le consociate, le partecipate, i consorzi e tutte le forme di collegamento che possono essere escogitate, non si limitano alla produzione su ordine centrale, ma svolgono qualsivoglia servizio loro richiesto dalla casa madre. Alcune grandi case automobilistiche giapponesi hanno affidato, per esempio, a proprie filiali negli Stati Uniti la progettazione e lo sviluppo di nuovi modelli destinati al mercato mondiale, smistandone la produzione su aziende la cui dislocazione è indifferente e possono anche non far parte del settore automobilistico. La Swissair, compagnia aerea svizzera di bandiera, ha trasferito il proprio sistema di contabilità a Bombay, valendosi di una filiale appositamente costituita, la Airline Financial Support Services India Pvt. Ltd. Dopo la costituzione della Comunità Europea, la Ford Motor Company ha perfezionato il proprio assetto organizzativo nel Vecchio Continente, con la istituzione di un quartier generale regionale, la Ford Of Europe, e la sempre maggiore integrazione del ciclo produttivo: il design della Mondeo si deve a quattro centri di progettazione, in Europa e negli Stati Uniti; componenti e parti meccaniche vengono fabbricate, con materiali di provenienza giapponese, tailandese e messicana, in impianti nordamericani ed europei. Qui siamo ancora nell’ambito di «filiali» o simili, ma per esempio la contabilità di tutto il sistema sanitario privato e pubblico americano sta per essere trasferito in India, presso aziende specializzate, collegate in rete. Tutti i servizi avanzati di traduzione sono ormai completamente slegati dal luogo di origine, avendo traduttori collegati in tutto il mondo. E non si pensi che solo i servizi possano rispondere a criteri di questo genere. La fabbrica virtuale comporta ancora più vantaggi e tutta l’industria si sta orientando verso questo modello avanzato.
Si tratta in fondo della divisione del lavoro un tempo esistente all’interno di una singola impresa e che oggi è proiettata all’esterno. Immaginiamo un bene durevole qualsiasi, per esempio un frigorifero. Immaginiamo, per semplificare, che esso sia composto da cinque parti: un mobile esterno termicamente isolato, un involucro interno di plastica stampata, un motore, un compressore e un termostato. Ora immaginiamo cinque produttori, ognuno specializzato in progettazione e fabbricazione di mobili isolati, di plastiche stampate, di motori, di compressori e di termostati. In più immaginiamo una fabbrica specializzata nell’assemblaggio di parti meccaniche e organizzata in modo da rispondere a diverse tipologie di prodotto, poi uno studio specializzato nella progettazione di frigoriferi, un altro specializzato nel loro marketing e un altro ancora dedito esclusivamente alla contabilità e alla gestione fiscale. Accanto a tutto ciò, immaginiamo una banca specializzata a fornire credito sulla base di dettagliati progetti industriali. È evidente che a questo punto non serve una fabbrica apposita per fare frigoriferi. È sufficiente che qualcuno, anche senza capitali, senza una struttura produttiva materiale e senza un’esperienza specifica nel campo, decida di fabbricarli. Se ha la fiducia di una banca e presenta un progetto attendibile troverà capitali e stabilimenti altrui.
Immaginiamo di rendere più complesso questo modello e avremo una struttura produttiva integrata a rete di cui sarà difficile persino definire i contorni proprietari. Infatti chi fabbrica mobili coibentati potrà fabbricare anche container per gli scienziati in Antartide, chi può fabbricare motori elettrici per frigoriferi lo può fare anche per condizionatori, chi gestisce contabilità lo farà per chiunque, mentre chi fa compressori invece si specializzerà talmente da coprire la richiesta di interi continenti. Tutto ciò in una rete di partecipazioni, di controlli incrociati, di scambi azionari controllati da holding senza nome eclatante né volto visibile, in una dinamica frenetica, al di sopra dei confini nazionali.
Sostanzialmente tali dinamiche globali vanno lette come lotta del capitale contro la caduta tendenziale del saggio di profitto, dato che alcune delle cause antagonistiche sono, per l’appunto, l’aumento del grado di sfruttamento della forza-lavoro, la riduzione del salario al di sotto del valore medio della forza-lavoro[51], la diminuzione del prezzo degli elementi del capitale costante.
Tale lotta sviluppa dappertutto la tendenza al dominio e non di certo alla libertà di traffici, provocando l’acuirsi di contrasti violenti soprattutto laddove più radicalmente sono manifeste le potenzialità dei paesi a nuovo capitalismo. Tali potenzialità sono per quei paesi fattori di alto profitto e perciò di fresco sviluppo, mentre per i vecchi paesi capitalistici, al contrario, sono fattori antagonisti alla loro senile mancanza di sviluppo.
Il vecchio capitalismo d’Occidente si butta avido su queste opportunità, con in testa naturalmente gli Stati Uniti.
Ci siamo più volte occupati della guerra economica che, non dichiarata e forse neppure espressamente pianificata, gli Stati Uniti conducono nei confronti dei loro concorrenti[52]. Il Giappone fu più volte colpito da questa guerra, per esempio con gli «accordi» del Louvre e con quelli dell’Hotel Plaza che sancirono una parità monetaria sfavorevole alle sue esportazioni, con la politica petrolifera americana, a partire dalla Guerra del Kippur, che fece salire enormemente i prezzi dell’energia. Eppure il Giappone, nonostante le batoste, riuscì non solo a superarle, ma a volgerle a proprio vantaggio. Mantenne alte le esportazioni nonostante una sopravvalutazione artificiosa della propria moneta, diversificò le fonti energetiche diventando il primo commercializzatore mondiale di gas, acquisì partecipazioni nelle aziende occidentali e comprò immobili grazie allo Yen troppo forte, portò, inaudito, la Borsa di Tokyo ad un valore doppio di quella di Wall Street. Tutti parlavano del boom giapponese e fu il tempo in cui gli occidentali andavano come pellegrini ad imparare il «metodo Toyota». Oggi il Giappone è in crisi profonda e non si risolleverà facilmente.
Nel 1997, poco prima che la crisi asiatica coinvolgesse la vita di una buona metà degli abitanti del pianeta e turbasse i sonni di milioni di investitori diretti o indiretti (cioè tramite i fondi assicurativi, pensione ecc.), tutti gli osservatori erano concordi nel dire che l’economia dell’Estremo Oriente era un esempio per tutti, da imparare e applicare. Il giornalista Erik Izraelewicz affermava:
«La crescita dell’Asia nell’economia mondiale – e con essa quella di un’altra gran parte dei paesi poveri – è quindi fattore di stabilità politica nel mondo. I paesi industrializzati, invece di inquietarsi, dovrebbero dispiacersi che né l’Africa, così vicina all’Europa, né l’America Latina, la vicina degli Stati Uniti, seguano la via asiatica»[53].
Il giornalista rifletteva un’opinione diffusa ed alimentata dai maggiori istituti economici del mondo. Persino la World Trade Organization, che dovrebbe intendersene di mercati, affermò fin dalla sua nascita, per bocca del suo presidente Ruggiero, che se le «Tigri asiatiche» non ci fossero bisognerebbe inventarle; esse non devono preoccupare per la concorrenza, perché è vero che sono campioni di intraprendenza, che adottano le più moderne tecniche di produzione e di marketing, ma si accaparrano le produzioni che l’Occidente prima o poi abbandonerà spontaneamente, quindi sono un fattore di equilibrio e inducono un benefico stimolo negli scambi mondiali, specie per quanto riguarda il libero mercato. Di tutto ciò il mondo occidentale non potrà che beneficiare.
Questo è vero e nello stesso tempo è una stupidaggine gigantesca dal punto di vista economico globale, proprio il terreno su cui la WTO è nata, per sostituire e superare il GATT, che non era attrezzato abbastanza per cogliere le sfide della globalizzazione. Tranne il Giappone, le Tigri non sono vere e proprie nazioni che hanno sviluppato, tra le altre caratteristiche occorrenti per definire una nazione, una diffusa accumulazione con un conseguente ed esteso mercato unitario interno. Si tratta di territori, compresa la Corea che pur produce e commercia moltissimo, su cui il capitale si è fissato recentemente e senza storia, venendo dal di fuori e toccando punti strategici su cui si è radicato senza investire dello stesso sviluppo le aree circostanti. Si tratta di punti di servizio del capitale internazionale, sfruttati da oligarchie locali più simili alle mafie che alle borghesie, che si arricchiscono creando isole di «benessere» ristrette, che hanno rapporti col territorio solo per utilizzarlo come fonte di materia prima e soprattutto di forza-lavoro schiavizzata.
È dunque vero che si tratta di fenomeni di intraprendenza e di management aggressivo, come è vero che l’Occidente passerà il testimone di molte produzioni di massa; ed è anche vero che attirano capitale disperso per il mondo unificandolo sotto la guida di una conoscenza locale che gli stranieri non hanno, quindi in teoria sono fattori di equilibrio. Ma si tratta dell’equilibrio precario che si genera, per esempio, con l’immenso arbitraggio internazionale, dove si vendono azioni, valute, derivati, opzioni, futures, insomma, di tutto, dove questo tutto costa molto e si compra di tutto dove costa poco. Certo che così si contribuisce, tramite la cosiddetta legge della domanda e dell’offerta, a far scendere i prezzi dove sono alti e a farli salire dove sono bassi, con benefico effetto livellatore. Sennonchè, non appena i movimenti dei capitali, che si muovono nelle quantità immense di cui abbiamo già parlato, si sincronizzano, non ci sono più dighe in grado di arginare i disastri.
Ecco perché la crisi scoppiata in Asia Sud-orientale dimostrò, contrariamente a quanto ci si aspettava il giorno prima, di essere in grado di destabilizzare non solo quei territori ma anche il mondo intero e fu necessario varare frettolosi quanto tradizionalissimi piani d’intervento per il «salvataggio» dei paesi interessati, che costò lì per lì un centinaio di miliardi di dollari, drenati dalle tasche della borghesia internazionale preoccupata.
Ma, se la crisi è stata certamente «asiatica» nelle sue manifestazioni dirompenti, non è però del tutto corretto parlare di salvataggio delle Tigri in crisi. La crisi non scoppiò soltanto a causa loro e non furono esse a mettere in pericolo la stabilità dei paesi occidentali. Furono piuttosto gli immensi capitali vaganti di provenienza occidentale a destabilizzare l’Asia. E non fu «salvataggio» il flusso di dollari, fu investimento per salvaguardare in futuro la sorte degli stessi capitali. Centinaia di milioni di proletari in tutto il mondo vedranno salire il loro sfruttamento per garantire che il capitale mondiale non diventi del tutto fittizio ma si assicuri ancora l’esistenza tramite l’estorsione di plusvalore, specie là dove lo si può estorcere ad alto saggio di profitto. Non è un caso che in simili occasioni si rispolveri sempre il Piano Marshall, che fu il capostipite degli «aiuti» internazionali. Ma non fu l’America ad aiutare l’Europa: fu l’Europa ad aiutare l’America, come disse la nostra corrente allora.
Adesso sarà l’immensa Asia ad aiutare entrambe, se sarà possibile prelevare dalle masse asiatiche plusvalore sufficiente ad alimentare il Capitale globalizzato. Se sarà possibile, perché non è detto. Se ne sta accorgendo il Giappone, che non ha più risorse per garantire ai suoi stessi capitali le performance degli anni passati; se ne sta accorgendo la Cina, che si è dissanguata nel tentativo di mantenere la parità fissa dello Yuan, la sua moneta nazionale; se n’è accorta Hong Kong, che ha dovuto mantenere la parità col dollaro nonostante la sua economia rappresenti un peso specifico piccolissimo nel contesto mondiale e che ha sofferto più di tutti la crisi.
Il futuro di tutta l’area è già disegnato dalla sua stessa storia. Per molti anni i distretti industriali asiatici non solo trovarono nicchie di mercato favorevoli, ma erosero mercati tradizionali dell’industria occidentale, in qualche caso eliminandola quasi del tutto, come la fotografia e l’elettronica di consumo. Per molti anni i tassi di sviluppo complessivi si mantennero su due cifre e, anche se negli ultimi tempi i tassi di sviluppo stavano ovviamente abbassandosi, come succede storicamente a tutti i paesi, vi erano ancora larghi spazi, almeno per consolidare i risultati raggiunti.
Pur fulminea e senza eguali nella seconda metà del secolo, la crescita di Hong Kong, Taiwan, Corea, Singapore e, per ultimo, Thailandia, Indonesia, in parte anche le Filippine, non ha avuto, in verità, natura «miracolosa». Si tratta di un utilizzo concentrato di capitali autoctoni formatisi in simbiosi col capitalismo internazionale, sui quali c’è stata la convergenza di ulteriori ondate di capitali esteri; questi capitali si sono fissati su piccole aree, attrezzate appositamente per attrarli e per produrre alti profitti. Ma le particolarità locali che riguardano il costo della forza-lavoro, la vicinanza con immensi mercati vergini, politiche fiscali attraenti, stabilità sociale, disciplina, leggi arcaiche sulla sicurezza ambientale e così via, non possono durare in eterno: il capitalismo crea e distrugge le particolarità, livella il mondo intero al capitale più avanzato, stabilisce da sé dove impiantare i suoi centri di servizio e dove abbandonarli quando non gli servano più.
Solo in Giappone (e Sud Corea, che ne copiò più tardi il modello di sviluppo), di fatto, l’applicazione di particolari criteri organizzativi (vecchi o nuovi, poco importa) si è tradotta in un consistente incremento di produttività ovvero di efficienza economica globale[54]. In tutti gli altri paesi di giovane industrialismo compresi nell’area del Sud Est asiatico, lo sviluppo è invece derivato da un’imponente mobilitazione di risorse produttive da parte dello Stato, sul modello ben sperimentato, e perciò già classico e anche un po’ antiquato, dei capitalismi italiano, tedesco, americano e russo degli anni '30. Solo che in paesi come questi, il capitalismo drogato raggiunge il parossismo.
A Taiwan, il rapido progresso delle tecniche di coltura innestatosi su una antica tradizione agricola, permise da una parte un’accumulazione agraria e dall’altra rese disponibile in tempi rapidi una gran quantità di forza-lavoro ex contadina a basso costo. Con l’intervento dei cospicui aiuti statunitensi antimaoisti, l’industria nazionale, beneficiando della mano d’opera a basso prezzo, si sviluppò rapidamente verso la fine degli anni '60 a cominciare dal settore della trasformazione alimentare (canna da zucchero, frutta tropicale, semi oleaginosi, pesca), per poi espandersi anche in altri settori, come quello tessile e dei beni di consumo. I settori ad alta intensità di capitali, quello siderurgico, metalmeccanico, cantieristico, petrolchimico, vennero in seguito sviluppati con il sostegno della finanza statale nell’ambito di un programma di sviluppo per le infrastrutture industriali teso ad attirare capitali stranieri e ancora in corso. L’estrema economicità della manodopera e l’offerta di servizi a basso prezzo, richiamò quindi ingenti capitali esteri, per il 30–35 % giapponesi, per il 25–30 % americani, per il 15 % europei. Traendo massimo vantaggio da tali investimenti, cioè trattenendo per quanto possibile il plusvalore sul territorio, l’economia taiwanese è riuscita, fino a questa crisi, ad autofinanziarsi per un buon 90 %. La particolarità della posizione e della storia taiwanese han fatto sì che l’espansione non soffrisse dei confini limitati dell’isola (che è comunque più grande dell’Olanda e del Lussemburgo messi assieme), ma che espandesse i fattori produttivi sul territorio del nemico, la Cina Popolare, dove la forza-lavoro costava ancora meno. Ciò diede una sferzata alla produzione propria più che a quella delle filiali delle aziende straniere, tanto che l’economia orientata alle esportazioni riuscì ad integrarsi nel mercato internazionale con una linea ben individuata di prodotti. Nel 1992, le riserve valutarie di Taiwan ammontavano già a 84 miliardi di dollari, un’enormità per un paese così piccolo (il 7 % delle riserve mondiali, che ammontano a 1200 miliardi di dollari). Nel 1994, gli investimenti ufficiali realizzati in Asia da Taiwan superavano i 10 miliardi di dollari; nel 1993 il tasso di disoccupazione non raggiungeva l’1,4 % e la produzione industriale costituiva il 39,5 % del prodotto interno lordo.
Singapore ha goduto di altrettanti vantaggi, anche se la tipologia del suo territorio è diversa e assomiglia più a Hong Kong. Sorta su un’area di una sessantina di chilometri quadrati in cui si sono concentrati capitali di passaggio, provenienti soprattutto dalle attività portuali (è il quarto porto del mondo) e dai commerci della diaspora cinese, è un’enclave ad alta concentrazione di servizi e di industrie con 3 milioni e mezzo di abitanti sull’estremità Sud della penisola malese, verso la quale (o meglio, verso la cui capitale Kuala Lumpur) ha esportato il suo modello. Del resto il territorio è troppo limitato ed era inevitabile che l’economia di Singapore si allargasse alle aree circostanti. Tra il 1966 e il 1990, il tasso medio annuo di crescita dell’economia è stato dell’8,5 %, tre volte quello degli Stati Uniti; il reddito pro capite è aumentato al ritmo del 6,6 %, raddoppiando ogni dieci anni; La percentuale degli occupati sulla popolazione complessiva è passata dal 27 al 51 %. Infine, dato di estrema importanza, nel 1990, la quota di plusvalore reinvestita era del 40 % (contro l’11 % del 1966). I bassi salari e il territorio organizzato a zone franche hanno attratto un’enorme massa di capitali esteri: americani (per il 42 %), giapponesi (per il 28 %), europei (per il 17 %). Le multinazionali presenti a Singapore sono, oggi, più di 300. In questa situazione le strutture produttive si sono inevitabilmente spostate al di là del confine in Malaysia lasciando il posto alle attività di servizio del capitale globalizzato. Forse è anche per questo che a Singapore, la Svizzera dell’Asia, in modo forse più «professionale» che in altri paesi simili, la borghesia non permette che questo servizio venga disturbato, e l’accumulazione è sovrintesa da un apparato statale formalmente democratico ma sostanzialmente ultra-totalitario, in cui anche le minuzie personali sono regolate dall’autorità dello Stato e le infrazioni punite in modo spropositato.
Anche Hong Kong ha goduto di un’extraterritorialità appetibile per i capitali, ha basato la sua economia sull’attività portuale, sulla finanza e sull’esportazione, si è estesa sul territorio della Repubblica Popolare Cinese (dove la manodopera è a prezzo infimo) molto tempo prima di ricongiungersi ad essa, ha creato moderne infrastrutture per attirare il business mondiale, il tutto attraverso una pianificazione economica «liberista» governata dall’alto (il solo nuovo aeroporto con i ponti, i tunnel, le strutture marittime connesse e i trasporti ha mobilitato direttamente e indirettamente una cinquantina di miliardi di dollari, una cifra che nessun capitale privato poteva raggiungere se non attraverso la mediazione dello Stato).
Dunque, i capitali «globalizzati» trovano i loro punti d’appoggio e li moltiplicano, come è successo con Kuala Lumpur, con i distretti Thailandesi, con quelli indonesiani, birmani e anche quelli, giganteschi e forse già in crisi, della Cina Popolare. Queste strutture di servizi e di distribuzione della produzione (Taiwan, Singapore e Hong Kong ormai non producono quasi più nulla sul proprio territorio) sono funzionali e, se le cose stessero come dice il direttore del WTO, potrebbero vivere di vita propria come hanno fatto Hong Kong e Taiwan per anni, sviluppandosi e diversificandosi. Non sono nazioni né economie vere e proprie, quindi potrebbero ristrutturarsi velocemente secondo le esigenze del Capitale globale, essendo nate proprio per questo. Sono strutture che potevano tranquillamente proseguire per la strada che avevano intrapreso, rimanendo assolutamente indipendenti le une dalle altre, cosa che le aveva garantite dai precedenti segni di crisi provenienti da Ovest. Il mercato asiatico, pur con un interscambio più alto di quello occidentale, è molto meno integrato alla potenza guida regionale, il Giappone, di quanto non sia quello occidentale, che è legato agli Stati Uniti. La ragione è che sia il Giappone che i distretti tigreschi sono a loro volta legati agli Stati Uniti, che importano molto da essi.
Tutto ciò doveva effettivamente, in teoria, rappresentare un intreccio stabile, o almeno sintonizzato sull’apparente euforia del mercato americano. Invece ad un certo punto una crisi di proporzioni storiche ha colpito tutto l’Estremo Oriente con una sincronicità sorprendente. Perché?
Non ci interessano le polemiche sorte col senno di poi fra i personaggi di questo o quel paese, di questo o quell’organismo internazionale, le accuse reciproche per gli errori commessi, le denunce di speculazione e in genere le migliaia di articoli che si sono scritti lungo i due anni di durata della crisi stessa (e non è ancora superata). Ci interessano invece i dati fondamentali su cui poggiava il sistema andato in crisi e le variazioni intervenute su questi dati.
Il primo dato fondamentale è che queste economie stavano passando da un relativo autofinanziamento medio a un indebitamento sostenuto. Il meccanismo è ben individuato, anche se gli istituti internazionali continuano a teorizzare che le ragioni del tracollo siano esclusivamente interne. La domanda interna è quasi ininfluente per le economie rampanti d’Asia: è stata la stagnazione della domanda occidentale e giapponese a provocare un calo delle esportazioni e quindi un calo delle entrate in valuta, per cui si è impennata l’inflazione, con riflessi immediati sul valore delle monete locali rispetto al dollaro.
Tutto ciò, in termini marxisti, si legge in un solo modo: l’estorsione interna di plusvalore nei paesi asiatici non era più all’altezza dell’ulteriore sviluppo, perché stava esplodendo la contraddizione fra l’alto saggio di profitto dovuto all’estrazione estensiva del plusvalore (bassa produttività) e il necessario passaggio all’estrazione intensiva (alta produttività, alta composizione organica, alto saggio di sfruttamento, alta sovrappopolazione relativa in paesi dove la sovrappopolazione è già assoluta). Se è così, e non si vede quale altra spiegazione possa esservi, la crisi asiatica segna un’importante fase dello sviluppo mondiale: la globalizzazione dell’estrazione di plusvalore relativo, ovvero la definitiva, irreversibile e rivoluzionaria affermazione della sussunzione reale del lavoro al Capitale, ovvero la massima negazione del Capitale da parte di sé stesso.
Gli alti tassi di crescita delle Tigri e le facilitazioni per i capitali esteri, hanno effettivamente provocato disponibilità per un’ulteriore crescita, per cui il circolo «virtuoso» ha richiamato capitali ad alta disposizione di rischio, investimenti di portafoglio di breve e brevissimo termine. Da dove venivano se non dall’esuberante e ineguagliata estorsione di plusvalore occidentale? È vero che con questo le Tigri hanno potuto finanziare di tutto, i grattacieli gemelli più alti del mondo, i centri commerciali più grandi del mondo, il ponte più lungo del mondo, l’aeroporto più efficiente del mondo ecc. Ma è anche vero che le loro economie, spinte dall’inerzia dei passati successi a funzionare come al solito, non hanno tenuto conto, esattamente come successe già in Giappone, che il boom economico di 15 anni aveva portato una quantità enorme di plusvalore a fissarsi come lavoro morto, soprattutto nella rendita immobiliare urbana, sui cui prezzi si fissano i prestiti ipotecari e in genere le garanzie sulla circolazione di capitale creditizio. Ma il prezzo immobiliare, che rappresenta il valore passato, non è valore attuale. Infatti il crollo dei prezzi immobiliari ha provocato uno squilibrio fra i prestiti e la loro copertura a garanzia, con relative restrizioni alla finanza facile.
Quando gli analisti degli istituti internazionali sono andati a vedere i conti per capire se si sarebbero potuti stanziare fondi di aiuto con sicurezza, hanno scoperto con sgomento che per molti anni, sempre sull’onda del boom economico, la maggior parte delle imprese si era indebitata senza ricorrere a ricoperture del rischio quando le loro garanzie erano venute meno. Così le banche avevano continuato a fornire prestiti (cioè avevano pompato plusvalore dall’Occidente e dal Giappone verso l’Oriente) fino all’assurdo. Per esempio, la Malaysia, uno dei paesi che più ricorreva agli investimenti interni per sostenere la sua crescita, ha visto crollare il mercato immobiliare e, subito dopo, il mercato azionario. Quest'ultimo ha perso, ancor prima che la crisi esplodesse in tutta la sua virulenza alla fine del '97, 58 miliardi di dollari, più dell’intero suo Prodotto Interno Lordo, mentre le banche denunciavano crediti interni per un ammontare pari al 170 % del PIL. Lo stesso dicasi per le banche indonesiane, i cui conti non è stato possibile verificare neppure dopo la crisi e che si stima abbiano accumulato un debito verso l’estero (per finanziare attività interne) pari a 90 miliardi di dollari, di fronte a riserve centrali dell’Indonesia pari a 21 miliardi. Tutte queste cifre vanno lette con l’attenzione rivolta alla grande massa di capitali dei paesi sviluppati che si era fissata nelle economie asiatiche[55].
Il sistema del credito alimentava ancora l’economia, ma non poteva durare e infatti non è durato. La Corea, in crisi da tempo, per esempio, drogava l’economia e manteneva aperte le fabbriche fallite, col risultato di indebitarsi, per cui il Fondo Monetario Internazionale dovette intervenire con urgenza versando la prima tranche di 16 miliardi di dollari su 57 miliardi in tre anni (per fare un confronto, la crisi messicana richiese un intervento pari a 30 miliardi di dollari). Non appena gli investitori stranieri, specie i fondi assicurativi americani che hanno bisogno di alte performance per garantire l’assistenza ai loro iscritti, si accorsero del potenziale pericolo, incominciarono a rifluire verso Wall Street. I livelli assurdi cui è giunta la borsa americana riscuotono comunque fiducia sia per l’andamento dell’economia interna, sia per l’atteggiamento del governo, il quale lascia capire, per bocca dei suoi rappresentanti più significativi (il ministro del Tesoro è particolarmente attivo) che è in grado di manovrare globalmente per prevenire disastri. Non può essere del tutto vero, ma intanto il Dow Jones schizza verso l’alto stracciando un record alla settimana.
Non può essere del tutto vero perché i disastri del capitalismo non si possono prevenire, ma che gli Stati Uniti siano in grado di manovrare globalmente, questo sì. I soldi che il FMI presta ad un paese in crisi provengono da banche di molti altri paesi e vengono versati sulla banca centrale che li distribuisce secondo politiche concordate. Finora la maggior parte di questi fondi sono sempre finiti nelle tasche dei creditori, quindi sono stati usati per ripianare debiti precedenti, come è effettivamente successo in Messico. Ciò significa, in generale, che gli Stati Uniti, il più grande paese investitore del mondo ma anche il più grande prestatore di denaro tramite le sue banche private (il prestito è anche un buon investimento quando ritornano gli interessi), utilizzano il FMI quando questi prestiti rischiano di non essere onorati; e il Fondo rastrella soldi presso banche di paesi terzi affinché il debitore in difficoltà possa restituirli alle banche degli Stati Uniti (con gli interessi, naturalmente).
Il bello è che gli Stati Uniti, il più grande prestatore privato di denaro tramite le banche, sono nello stesso tempo il più grande debitore pubblico del mondo: il Giappone, per esempio, detiene circa un terzo del debito pubblico americano sotto forma di titoli di stato a lunga scadenza, e il dollaro, il tanto decantato dollaro, è moneta (cioè titolo di credito verso uno Stato) inconvertibile. Che è come dire: chi ha dollari non può restituirli al governo degli Stati Uniti in cambio di qualche altra moneta o di oro, ma può solo darli a privati americani in cambio di merci o servizi.
Occorre spendere alcune parole su questo fatto perché influisce sull’intera economia internazionale. Nel 1971 fu dichiarata l’inconvertibilità con l’oro e nel 1973 fu ritoccato il rapporto interno da 32 a 42 dollari l’oncia. Ora, se si trattasse soltanto dell’inconvertibilità giuridica, non ci sarebbero problemi, perché tutti sanno che il dollaro era già inconvertibile in pratica, come tutte le altre monete (dichiarazione o no, non c’è oro abbastanza nel mondo). Ma il dollaro è moneta di riserva e anche di scambio internazionale, perciò in dollari sono i pagamenti e soprattutto i crediti internazionali. Se per esempio una banca tedesca ha un credito in dollari presso una banca americana, può fare un prestito in dollari a un industriale tedesco, il quale li deposita – poniamo – presso una banca in Italia dove ha un’attività industriale e deve fare investimenti diluiti in un anno. La banca italiana ha ora un deposito in dollari fra altri depositi in dollari e fa un prestito a un industriale italiano che ha interessi in Francia e deposita in una banca francese e così via.
Siccome i depositi sono una scrittura contabile momento per momento, nessuna banca può sapere – quando presta dollari – se e come dall’inizio della catena si sono sovrapposte le operazioni che durano un anno; vi è quindi creazione di dollari, emissione di moneta senza copertura. È vero che ogni banca nazionale emette valuta senza copertura in base alla sola potenza produttiva, ma c’è sempre, nei pagamenti internazionali, una possibilità di compensazione tramite le Clearing Houses fino alla Banca Centrale degli Stati.
Invece, per quanto riguarda il dollaro, moneta speciale, la compensazione non c’è e non può esserci, perché il sistema dello xeno-dollaro è un sistema aperto, che perde depositi e non ha il «prestatore di ultima istanza», cioè la Banca Centrale degli Stati Uniti. Infatti sono contabilizzati dalle Clearing Houses solo i dollari in uscita e in entrata dagli Stati Uniti (come per tutte le altre monete), non i dollari creati con le operazioni contabili all’estero; e la Banca Centrale non può riconoscerli perché non li ha mai emessi. Il risultato pratico è che l’inconvertibilità dichiarata da Nixon nel 1971 giuridicamente è con l’oro, ma è in realtà un’inconvertibilità assoluta.
Non è la prima volta che succede. Dal 1947 al 1955, anche la sterlina risultò parzialmente inconvertibile: si poteva convertire solo quella guadagnata nell’area del dollaro e non quella trasferibile, guadagnata nell’area della sterlina. L’effetto fu che veniva convertita ugualmente in dollari e in altre valute al mercato nero scontando un prezzo di rischio. Che cosa potrebbe succedere oggi al dollaro se perdesse molta della sua importanza come moneta di scambio mondiale, non lo sa nessuno. Sta di fatto che molta parte dell’economia mondiale sta funzionando con dollari che non esistono[56].
Al culmine della crisi asiatica, quando il FMI voleva imporre condizioni troppo dure alla Corea (poi imposte comunque), questo paese protestò per il palese favoritismo nei confronti degli Stati Uniti, verso i quali il flusso di denaro doveva ritornare. L’Economist diede ragione alla Corea, aggiungendo che anche il Giappone era favorito, in quanto creditore. In sostanza il FMI sosteneva che, di fronte alla globalizzazione, la Corea doveva liberalizzare il proprio mercato (già sentita, no?) e la Corea dimostrava, cifre alla mano, che con la crisi, la moneta nazionale ai minimi, le banche sull’orlo del fallimento e molte industrie con l’acqua alla gola, gli Stati Uniti, da veri sciacalli, si stavano comprando interi settori dell’economia e della finanza a prezzi ultrastracciati.
Lo stesso stava accadendo in altri paesi asiatici ed era accaduto prima in altre parti del mondo, Europa compresa. Solo che i meccanismi adesso erano diversi e la terapia del Fondo rischiava di ottenere effetti ancora più catastrofici della mallatìa, rischiava cioè non tanto di ammazzare i pazienti quanto di schiavizzarli. La terapia è la solita, quella utilizzata con «successo» nel resto del mondo da molto tempo, specie in America Latina: una drastica politica monetaria con alti tassi, freno dei consumi e tagli alla spesa pubblica, blocco dei salari.
Ma le Tigri non sono il Messico, dove vi era un eccesso di consumo e di importazioni, carenza di riserve valutarie per pagarle, mancanza di risparmio privato e una spesa pubblica eccessiva (e dove comunque il risanamento ha portato il potere d’acquisto dei salari al 50 % di quanto non fosse prima della cura). Nei paesi asiatici la finanza allegra non è quella dei governi dirigisti, che funzionano mediamente bene, nonostante le mafie, ma quella dei privati liberisti. I bilanci pubblici erano in pareggio o addirittura in surplus, l’inflazione era bassa, il risparmio privato era alto, la capacità di esportare ancora altissima. Le Tigri erano già nelle condizioni che il Fondo richiede sempre per avviare la cura delle economie in crisi. Il problema è un consumo interno troppo basso, una sovraccapacità produttiva di fronte a una diminuzione delle esportazioni e soprattutto profitti in calo. Quest'ultima condizione è essenziale per capire l’abbandono dei capitali: essi hanno bisogno di un alto saggio di profitto per bilanciare quello basso dei paesi d’origine; se anche le Tigri asiatiche diventano paesi a basso saggio, non ha più senso «investire» (le virgolette sono d’obbligo perché ormai si chiama investimento un po’ di tutto). Infatti la cura non ha finora dato esito positivo: il primo parametro da riequilibrare era il valore della moneta nazionale, ma da quando il Fondo ha imposto i suoi criteri, l’insieme delle monete asiatiche è crollato del 40 %.
Quindi la stretta monetaria voluta dal FMI provocherà nell’immediato recessione, ulteriore fuga di capitali, abbassamento dei salari, alti tassi per richiamare i capitali (fino a quattro volte il tasso d’inflazione programmato), quindi, quando questi capitali siano giunti, ulteriore flusso in uscita per pagare interessi (oltre a quelli dei prestiti immediati)… flusso in uscita verso dove? Verso gli Stati Uniti, naturalmente[57].
Come sembrano lontani i tempi in cui le industrie occidentali mandavano degli osservatori a Singapore, Taiwan o Hong Kong, per vedere se per caso ci fosse qualcosa da imparare dalla dinamica del mercato orientale. Niente più del successo spinge all’imitazione becera, e niente più dell’insuccesso fa emergere saccenti quanto oscuri maestri che pretendono di aver saputo tutto già da prima:
«Credo che le strutture asiatiche siano arcaiche, con imprese-conglomerati gestite come nel secolo scorso e con mercati troppo chiusi. In breve, un’economia che non stava al gioco dell’economia mondiale globalizzata. Ciò che chiedono oggi gli occidentali per poter continuare a concedere crediti e ad accordare fiducia a quei paesi, è che essi riformino le loro strutture […] Tre o quattro anni fa nessuno credeva alla crisi. Non credo sia stato detto che i paesi asiatici erano un modello. Erano un sistema ultra chiuso che non sta al gioco dell’economia occidentale e mondiale […] La crisi giapponese offre oggi un’enorme opportunità per le economie occidentali. Oggi, ci sono gli americani, i tedeschi e i francesi che comprano in Asia, in Indonesia, in Corea. Comprano perché la deflazione generalizzata ha fatto abbassare i prezzi a livelli tali che si può comprare di tutto […] Non credo che quel modello avesse mai generato invidia in Occidente»[58].
Strutture arcaiche? Mercati chiusi? Quelle economie non erano un modello? E chi, di grazia ci ha rotto le tasche per un decennio con il «metodo Toyota», con la «produzione snella», «con la qualità totale», con la produzione «just in time», che i giovani manager occidentali rampanti andavano a studiare a Tokyo? E chi, di grazia, se la faceva sotto quando i giapponesi compravano a man bassa le aziende e i grattacieli americani? Ed erano forse fantasmi inesistenti quei sindacalisti che venivano nelle fabbriche a sciorinare paroloni sulla competitività delle nostre merci, sulla codeterminazione nell’ambito delle responsabilità produttive condivise, cercando di convincerci che la svolta epocale ci doveva far calare le brache? Ma se avevate simpatia persino per il piccolo nazismo democratico di Singapore! Noi non provavamo nessuna invidia per lo sfruttamento asiatico, ma i rappresentanti della grande corporazione del lavoro, la trinità governo-industria-sindacato, certamente sì, checché ne dica il giornalista. Forse non sa o non ricorda che libri come La macchina che ha cambiato il mondo, in cui l’industria giapponese era il modello, non solo erano dei best seller, ma lo erano soprattutto perché le aziende lo compravano a casse per i loro capi[59].
Ma ciò che dava ancora più fastidio era che tutti questi appetibili paesi non stessero al gioco del mercato globale, che tendessero cioè a tenersi il plusvalore, negando la loro partecipazione alla ripartizione mondiale, come aveva fatto il Giappone per molto tempo, riuscendovi in parte. E se la politica del FMI avrà successo, ciò non succederà più per un pezzo, forse addirittura mai più.
Quando, due anni or sono, gli Stati Uniti e il FMI affrontarono e risolsero in prima persona la crisi del Messico, il presidente Clinton impiegò 10 minuti a «convincere» il Congresso, che gli è sempre stato ostile, a stanziare 30 miliardi di dollari. Il piano fu operativo subito e quello fu praticamente il prezzo d’acquisto di quel paese, che perdette del tutto la sua residua indipendenza (ovviamente non ci scappa neppure una lacrima: i proletari messicani avrebbero tutto da guadagnare anche di fronte a un’annessione yankee vera e propria: il saggio di sfruttamento si misura in plusvalore su salario, non in fatica fisica e sofferenza).
Una soluzione del genere fu proposta dal Giappone che, nonostante la sua propria crisi, ha ancora una potenza economica ragguardevole e intendeva risolvere in casa i problemi dell’Estremo Oriente. Ma la proposta unilaterale di intervento giapponese presso i vari paesi dell’area asiatica in crisi – non solo riserve di materie prime, ma anche clienti primari – fu respinta dal FMI alla fine del 1997. All’inizio dell’anno successivo la crisi del Giappone si acuiva e il paese, a differenza che nel passato, quando si era risollevato più forte di prima ad ogni colpo, risultava chiaramente sconfitto in una guerra finanziaria le cui conseguenze appaiono sempre più devastanti.
Di fronte alla crisi, che è ovviamente utilizzata in loco per lanciare una campagna al fine di «raccogliere le sfide della globalizzazione», gli Stati affineranno le loro tecniche di intervento macroeconomico e quindi diventeranno sempre più modernamente «fascisti»[60].
Perciò, come del resto successe fin dal principio dell’applicazione dei metodi keynesiani, cioè prima che lo stesso Keynes ne scrivesse registrandone l’avvento, l’ingerenza statale in economia continuerà a recare ben più che una semplice «aggiunta di consumo», ma piuttosto mirerà a elevare la capacità produttiva del sistema economico agendo sul modo di applicazione del lavoro, tenderà cioè ad allargare la forbice tra pluslavoro e lavoro necessario, con il finanziamento, diretto o indiretto, dell’innovazione tecnologica, di nuovi metodi organizzativi e di infrastrutture in grado di velocizzare i trasporti o eliminare tempi morti ecc.
Inoltre, la moderna connessione tra Stato e Capitale finanziario (ben esemplificata nella gestione pubblica dei tassi d’interesse), è finalizzata alla creazione di moneta in base all’aumento della produzione, in modo da fornire all’apparato industriale una disponibilità di capitali tenuta artificialmente sempre più alta di quanto non lo sarebbe spontaneamente, per spingerla ad effetti ancora più marcati nei tempi di crisi, quando gli Stati più forti prestano il denaro all’industria senza praticamente costi d’interesse per stimolarne la ripresa.
Il calo della redditività – inevitabilmente patito, in progresso di tempo, dal capitale destinato alla produzione a causa della legge della caduta tendenziale del saggio di profitto – obbliga ciascun borghese alla caccia affannosa, in ambito speculativo, di sovrapprofitti (assicurati proprio dal veloce spostamento di denaro, secondo convenienza, dall’una all’altra opportunità di investimento). Ciò provoca l’abbandono di «piazze» a favore di altre, per cui vi possono essere sconvolgimenti economici cui gli Stati rispondono intervenendo ulteriormente nell’economia. Ed è buffo che i sacerdoti mondiali del libero mercato siano in fin dei conti i massimi fautori dell’intervento statale in economia, avendo essi gli Stati come unici interlocutori cui consegnare i loro diktat economici e politici.
Ora, però, nessun capitalismo nazionale è in grado di moltiplicare all’infinito la propria macchina produttiva ovvero realizzare, per un periodo prolungato, massicci investimenti in impianti e attrezzature, eludendo la ferrea legge della decrescenza, per cui:
«Al di sopra di brusche variazioni del passo dovute a crisi generali e a guerre lontane e vicine, vinte e perdute, e ferma restando l’età storica dei vari capitalismi, il ritmo di incremento annuo decresce nettamente col tempo»[61].
E questo perché l’aumento lordo dev’essere diviso, come per ogni fenomeno di sviluppo in natura, per il volume o la massa precedente. Un esempio: in una fabbrica che produce dieci pezzi con dieci fresatrici e dieci operai, l’aumento della produzione derivato dall’uso di dieci fresatrici nuove con altrettanti nuovi assunti, sarà al massimo di altri 10 pezzi, cioè del 100 %, mentre ulteriori dieci fresatrici e operai faranno salire la produzione complessiva di altri 10 pezzi, che, in confronto ai 20 precedenti rappresentano solo il 50 % (altri 10 del 33 %, poi del 25 %, del 20 % e così via).
Siccome le economie tigresche sono mediamente recenti e perciò si sono sviluppate partendo da livelli di produttività già alti rispetto alla media mondiale, ecco che il loro ritmo di sviluppo qualitativo è più lento di quanto fosse quello occidentale negli anni che segnano la crescita post-bellica. A fronte di crescite quantitative eccellenti (anche a due cifre, come abbiamo visto), il miglioramento intrinseco dei fattori della produzione negli ultimi anni è inferiore a quello occidentale della fase analoga. Dal 1966 al 1991 Hong Kong ha avuto un incremento annuo di produttività del 2,3 %, Taiwan dell’1,9 %, la Corea del Sud dell’1,6 %, Singapore dello 0,3 %[62]. Dal 1950 al 1973, quindi in una fase di sviluppo corrispondente, la Germania ebbe un incremento annuo di produttività del 3,7 %, l’Italia del 3,4 %, la Francia del 3 % e il Giappone del 4,1 %[63].
Oltre all’effetto dovuto al punto di partenza situato più in alto (chiunque incominci un’attività industriale adotterà le tecniche disponibili più moderne), la bassa produttività è dovuta anche all’utilizzo massiccio di manodopera a basso costo nei settori a bassa composizione organica di capitale. Questo fatto, proprio perché costituisce una classica controtendenza all’abbassamento del saggio di profitto, non è indice di capitalismo arcaico ma modernissimo. Vale a dire che era arcaico nell’epoca in cui non era una controtendenza ma il modo normale di produrre le merci, ma non oggi quando il modo normale è quello della fabbrica automatica ad altissima composizione organica.
Sappiamo che però la fabbrica automatica può garantire altissimi profitti assoluti (e anche altissimi saggi di profitto in casi particolari), al capitalista singolo o in una produzione di nicchia, ma assolutamente mai all’economia nel complesso o anche ad un settore esteso[64]. Ora, le tre Tigri più aggressive, Taiwan, Hong Kong e Singapore, hanno da tempo fatto il salto verso l’automazione e il terziario sul loro territorio, spostando le lavorazioni a bassa composizione organica le prime due nella Cina Popolare e la terza in Malaysia. Questi modelli di microimperialismo spontaneo hanno quindi sofferto delle stesse contraddizioni di cui soffrono i più grandi, solo che, a differenza dei giganti, i tigrotti non hanno la potenza sufficiente per controllare il flusso di capitali: mentre i capitalisti singoli si sono trovati con altissimi profitti, richiamando addirittura capitali esteri per le loro performance, le basi sociali nel loro complesso si sono trovate in crisi a causa del diminuito ritmo di accumulazione, aggravato dall’apprezzamento del dollaro sullo Yen e su tutte le monete asiatiche[65]. Quando socialmente i nodi sono venuti al pettine (tra l’altro provocando anche violente lotte sindacali, che influiscono enormemente sulla percezione soggettiva degli investitori) gli operatori finanziari esteri, specialmente i fondi d’investimento, valutando la debolezza intrinseca della struttura finanziaria di cui abbiamo parlato prima e l’evidente debolezza produttiva che non avrebbe permesso un azzeramento rapido della crisi, se ne sono andati.
Dove? Soprattutto a Wall Street, confidando in due fattori: primo, sull’effetto al rialzo autoindotto nella Borsa americana dal loro stesso flusso; secondo, sulla capacità della potenza americana di controllare la crisi prima della sua esplosione (l’economia casinò ha dei limiti), di pilotare, tramite gli organismi mondiali, la ripresa in Asia dopo la selezione tra capitalisti e finanzieri e soprattutto dopo che i salari furono drasticamente ridotti.
| Piazza finanziaria | 30 giugno 1997 | 1 luglio 1998 | Variaz. % |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 20 905 | 16 363 | - 21,7 |
| Hong Kong | 15 056 | 8543 | - 43,2 |
| Giacarta | 724 | 456 | - 37,0 |
| Taipei | 9030 | 7549 | - 16,4 |
| Seoul | 745 | 315 | - 57,6 |
| Manila | 2809 | 1782 | - 36,5 |
| Singapore | 1987 | 1095 | - 45,0 |
| Kuala Lumpur | 1077 | 471 | - 56,2 |
| Bangkok | 527 | 267 | - 49,3 |
| Fonte: «Il Sole-24 Ore», 12 agosto 1998 | |||
In Giappone, nei primi mesi del 1998, le grandi catene di supermercati hanno ridotto le vendite del 50 %, soprattutto per effetto psicologico, ma in altri paesi, come l’Indonesia, il potere d’acquisto medio è sceso realmente anche del 60 % (con punte vertiginose: un chilo di riso che nell’agosto del 1997 costava 1200 Rupie, nel gennaio del 1998 ne costava 6000, mentre il dollaro passava da 2400 Rupie a 10 000) e gli sfavillanti centri del consumo non sono stati tanto disertati quanto assaltati e saccheggiati dalle folle inferocite.
Nelle crisi viene azzerato capitale fittizio in quantità variabili a seconda della profondità e della durata. Ogni capitale fittizio è rapportabile, nel lungo periodo, a capitale eccedente e, Marx ci insegna, non c’è capitale eccedente senza eccedenza di merci.
«Eccedenza» è un termine ambiguo, che ha significato solo in rapporto a qualcos’altro: se per esempio in un ciclo economico vengono distrutti capitali e vengono prodotte meno merci, in media non abbiamo eccedenza affatto. Così, le merci sono eccedenti solo in rapporto alla capacità di consumo, e lo stesso consumo ha limiti solo nel valore della forza-lavoro e nella possibilità di espansione capitalistica. Dipende dai tempi e dalla traumaticità delle soluzioni, ma il capitalismo possiede, oltre alle retroazioni positive che tendono a farlo crescere fino ad esplodere, anche delle retroazioni negative che lo frenano riportandolo ad un precario equilibrio. Per questo lo si può analizzare solo in una dinamica, in un processo storico, e mai fotografandolo nei suoi attimi particolari, cosa che rischia di far cadere nella teorizzazione di un aspetto transitorio e insignificante e di trarne conclusioni contrarie a ciò che sta succedendo realmente. Scriveva Lenin:
«Senza dubbio, se il capitalismo fosse in grado di sviluppare l’agricoltura, che attualmente è rimasta assai indietro rispetto all’industria, e potesse elevare il tenore di vita delle masse popolari che, nonostante i vertiginosi progressi tecnici, vivacchiano dappertutto nella miseria e quasi nella fame, non si potrebbe parlare di un’eccedenza di capitale»[66].
Agricoltura o altro, qui Lenin vuol dire che il capitalismo non è una società che sappia e possa risolvere i problemi degli uomini e che il Capitale non conosce eccedenza assoluta finché vi saranno uomini che muoiono di fame o vivono in condizioni miserabili. Il fatto è che anche l’eccedenza relativa non è una condizione che si possa affrontare in termini di pianificazione delle risorse da parte di governi volonterosi o supergoverni mondiali, perché tale eccedenza risulta dalla necessità del capitalismo di mantenere intere aree del mondo, anche all’interno dei paesi sviluppati, nel sottosviluppo e nell’indigenza (e perciò nell’eccedenza di uomini). È proprio tale natura del capitalismo che ci permette di affermare che tutta quella parte della Terra oggi tagliata fuori dall’espansione produttiva e sociale non lo è a causa di fattori soggettivi (malgoverno interno o mondiale), bensì a causa del consolidamento del capitalismo maturo e della sua necessità di differenziare le aree proprio mentre le conquista ai suoi meccanismi. Non è neppure moralismo, è semplicemente una sciocchezza fare l’equazione miseria = sottosviluppo; persino la Chiesa Cattolica ormai mette in guardia rispetto alla miseria che deriva dallo sviluppo.
La globalizzazione, che vuol dire, ricordiamolo, ripartizione mondiale del plusvalore estorto a saggi differenziati e storicamente decrescenti, imporrà sempre più lo sviluppo di certe aree a discapito magari di altre. Così le isole di sviluppo nei paesi sottosviluppati saranno sempre più funzionali all’utilizzo dello stesso sottosviluppo, non certo embrioni di decollo economico generale. Se ponessimo il caso di un deciso e generalizzato sviluppo capitalistico di paesi importanti come la Cina o l’India, dovremmo senz’altro mettere in conto una catastrofe economica dell’Occidente e del Giappone, che non potrebbero più avvalersi del benefico effetto della differenza dei saggi di profitto, ma dovrebbero accontentarsi dell’altissima produttività domestica a saggi decrescenti. Abbiamo già visto che molto prima del profilarsi di ipotesi del genere, entrano in gioco meccanismi di difesa, voluti o spontanei, per cui il confine tra guerra economica e guerra guerreggiata si fa sempre più sottile. Questo è il vero volto, tra l’altro, della guerra imperialistica attuale[67].
Se il capitalismo riuscisse a risolvere i problemi dell’indigenza di intere popolazioni del pianeta, esso, dice Lenin,
«non sarebbe più tale, perché tanto la disuguaglianza di sviluppo che lo stato di semiaffamamento delle masse sono essenziali e inevitabili condizioni e premesse di questo sistema di produzione. Finché il capitalismo resta tale, l’eccedenza di capitali non sarà impiegata a elevare il tenore di vita delle masse del rispettivo paese, perché ciò comporterebbe diminuzione dei profitti dei capitalisti, ma a elevare tali profitti mediante l’esportazione all’estero, nei paesi meno progrediti».
Lenin è naturalmente ancora legato alla funzione del vecchio imperialismo che mira a nuovi paesi perché, come abbiamo visto,
«In questi ultimi, il profitto ordinariamente è assai alto, poiché colà vi sono pochi capitali, il terreno è relativamente a buon mercato, i salari bassi e le materie prime a poco prezzo»[68].
Ciò che però ci interessa è l’esasperazione delle condizioni moderne per la valorizzazione di capitale, l’esistenza cioè di reti capitalistiche locali che diano garanzia di un’alta estorsione di plusvalore da un proletariato autoctono e non solo un’alta remunerazione in termini commerciali o di rendita. Sono condizioni che già Lenin intravedeva nella sua epoca:
«La possibilità dell’esportazione di capitali è assicurata dal fatto che una serie di paesi arretrati è già attratta nell’orbita del capitalismo mondiale, che in essi sono già state aperte le principali linee ferroviarie, o ne è almeno iniziata la costruzione, sono assicurate le condizioni elementari per lo sviluppo dell’industria ecc.»[69].
Per il capitale ultramaturo è dunque indispensabile ricorrere al plusvalore estorto al proletariato giovane dei paesi emergenti, ma è altresì necessario fare in modo di poterselo portare a casa, dato che le borghesie nazionali tendono a richiamare capitali ma per lo sviluppo del loro territorio, non per quello degli altri.
Questa, tra l’altro, è una delle ragioni per cui è conveniente, per i maggiori paesi imperialistici, fomentare divisioni nazionali, etniche, tribali, al fine di balcanizzare quanto più possibile il mondo: è più agevole avere a che fare con territori piccoli e divisi che con nazioni potenti e unitarie. Gorbačëv si impiccò con le sue proprie mani quando andò in pellegrinaggio a Washington offrendo collaborazione rispetto alla sfida globale dell’economia. Egli forse credeva sinceramente di ottenere appoggio sventolando lo spauracchio del disfacimento dell’URSS, ma l’equilibrio globale come lo intendeva Mosca non era lo stesso di quello inteso da Washington. Il «bipolarismo» nella politica internazionale degli Stati Uniti semplicemente non è mai esistito e la scomparsa di una potenza unitaria nel cuore dell’Asia era perfettamente consona alla loro vocazione di dominio incontrastato. Nella «politica del caminetto» era già scritta la vittoria dell’incredibile El’cin, e la Russia nei prossimi anni potrebbe, tutt’al più, passare da un mercato «mafioso» di materie prime, ad un mercato capitalistico «normale» di forza-lavoro a basso prezzo.
Se è vero che la forza-lavoro russa è tra le più disastrate e meno produttive del mondo, è anche vero che ormai il salario nella maggior parte delle fabbriche russe è un optional. Nel corso degli anni '80 e dei primi anni '90, in molti paesi in via di sviluppo l’incidenza del monte salari sul PIL era sensibilmente calata, ma ciò era anche dovuto all’aumento del valore complessivo prodotto. La Russia è un paese in via di sottosviluppo in quanto vede soltanto affermarsi il dato negativo. Mentre in Europa, Stati Uniti e Giappone i salari costituiscono approssimativamente, il 40 % del valore aggiunto, la quota corrispondente in America Latina e nel Sud Est asiatico non supera il 15 % e in Russia il calcolo è inesistente sia a causa dell’impossibilità di rilevazione (i lavoratori stanno mesi senza salario mentre il costo della vita cambia) sia, anche, a causa del pagamento in natura, curiosa forma di regressione sociale dovuta all’impatto col capitalismo supersviluppato.
Negli impianti di assemblaggio automobilistico in Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, il costo del lavoro è meno di 120 dollari al mese (70 centesimi l’ora), di molto inferiore a quello dell’Unione Europea. In Germania, dove il costo del lavoro è alto rispetto al resto del mondo, per esempio, il salario di un operaio metalmeccanico è di quasi 32 dollari lordi l’ora e, se non vi sarà una correzione fra produttività e salario, fra qualche anno non avrà più senso, per un capitalista tedesco, produrre in Germania invece che all’estero[70]. Infatti, dopo il crollo del Muro, nonostante le molte fabbriche ristrutturabili dell’ex Repubblica Democratica, si è preferito demolirle e seguitare a espandersi a Oriente, riguadagnando virtualmente, cioè senza truppe in loco, il Lebensraum prebellico. La linea dell’Oder-Neisse sta alla Polonia come il Rio Grande sta al Messico. Persino il prezzo pagato per comprarsi quel territorio è pressoché uguale a quello sborsato dagli Stati Uniti nel 1995: una sessantina di miliardi di marchi[71].
In un annuncio pubblicato sul «Corriere della Sera» del 24 novembre 1993 si leggeva:
«Buone ragioni per investire in Romania: basso costo della manodopera (70 000 lire mensili); lavoro qualificato (scuola dell’obbligo sino a 15 anni); mercato interno (all’Est uno dei più grandi, secondo per ampiezza solo alla Polonia); facilitazioni (esonero dal pagamento dei dazi di importazione su macchinari, impianti e attrezzature destinati allo svolgimento dell’attività, esonero dal pagamento delle imposte sui profitti per i primi 7 anni); profitti e capitali (pagati in valuta convertibile, si possono esportare liberamente in Italia)».
Solerti patrocinatori di un simile salasso sono, giusta quanto finora dimostrato, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca mondiale. Data la loro perspicuità, vale la pena rammentare qualche caratteristica della loro funzione.
Era inevitabile che con la mondializzazione del capitalismo si concretizzasse sia un organismo politico mondiale (ONU), sia, soprattutto, un organismo monetario (FMI). Era altrettanto inevitabile che questi due organismi soggiacessero alla legge del capitalismo più forte, cioè quello degli Stati Uniti. Come conseguenza, era del tutto ovvio che nascesse l’anti-imperialismo economico di stampo immediatista, che vede le «colpe del male» in tali istituzioni, soggiacenti, secondo la logica moralista, alla volontà dell’imperialismo con la I maiuscola, quello americano.
Dell’ONU non ci occuperemo, sia per ragioni di spazio che, soprattutto, per ragioni pratiche: è un organismo rappresentativo praticamente inutile. Il Fondo Monetario Internazionale – come l’altra istituzione scaturita da Bretton Woods, la Banca Mondiale – non è stato espressamente concepito in modo da assicurare agli Stati Uniti un controllo assoluto sui suoi interventi, ma è ovvio che la partecipazione ad esso, essendo statutariamente proporzionale al peso dell’economia dei singoli paesi, offre agli Stati Uniti tale controllo. L’opzione di una banca centrale mondiale indipendente, in grado di emettere moneta internazionale, soluzione propugnata da Keynes, non poteva che fallire. Le riforme successive, compresa quella guidata dall’ex direttore del FMI Triffin e tendente a valorizzare un titolo di scambio internazionale, il Diritto Speciale di Prelievo, andarono nel verso opposto a quello cercato, cioè aumentarono prima il potere di veto americano ed europeo (che sommato ammontava al 55 % per cento dei voti-depositi), poi consegnarono l’organismo al controllo totale degli Stati Uniti, nonostante nel frattempo fosse aumentata la coesione dei paesi europei tramite la CEE. A volte si legge che l’influenza degli Stati Uniti è dovuta ad una sorta di sopraffazione politica, ma si tratta di una deformazione soggettivistica della realtà. Gli Stati Uniti, indipendentemente dal valore del loro voto (oggi diminuito), non hanno rivali nella finanza mondiale e ciò che va bene per il capitalista gigante va bene anche per gli altri paesi, nel senso che, nonostante la subordinazione inevitabile, ne beneficiano. Tutti devono concorrere di buon grado alla soluzione americana di qualsiasi problema internazionale. Del resto, se anche così non fosse, tutti sanno benissimo che è sufficiente il movimento simultaneo di una infima percentuale del capitale influenzato dalla politica americana per mettere in ginocchio un paese anche potente.
Tutto ciò fa del FMI un organismo che, nato per armonizzare le bilance dei pagamenti e scongiurare gli scompensi monetari, si riduce ad essere il notaio degli interessi americani. I 50 economisti che ne dovrebbero formare il nucleo teorico in grado di elaborare raffinate politiche d’intervento, non possono far altro che disciplinare i soci alla politica mondiale di quello più potente. Il Fondo avrebbe per esempio il compito istituzionale di intervenire nello squilibrio della bilancia dei pagamenti americana, ma non può farlo. Grazie a questo sistema, gli Stati Uniti non solo non hanno preoccupazioni di sorta in ordine al loro deficit, ma svolgono la funzione di assorbire le eccedenze delle regioni sviluppate. Per il decennio 1980–89, il deficit americano si è elevato a 931 miliardi di dollari, contro le eccedenze di 533 miliardi per il Giappone, di 936 per la Germania e di 103 per le Tigri asiatiche. Nonostante ciò significhi drenaggio di plusvalore dagli altri paesi (soprattutto presso gli imperialismi minori più che presso i paesi poveri subordinati, come certo terzomondismo predica), per tutti i capitalisti del mondo è molto positivo.
La nostra corrente disse già nel secondo dopoguerra, quando tutti andavano in visibilio per il Piano Marshall e gli «aiuti» americani, che non era l’America ad aiutare l’Europa bensì il contrario. Ora sembra che la cosiddetta locomotiva americana muova ancora il convoglio capitalistico stando in testa alla produzione e tirando, ma non è più così. Essa è ancora mastodontica e si è rimodernata, ma è in coda e contribuisce a spingere un convoglio fatto non più di vagoni ma di tante locomotivine un po’ indisciplinate con inframmezzati diversi tender, i carri scorta con il carbone; le mette in riga costringendole a spingere nella stessa direzione, a rimanere collegate e quindi a non sparpagliarsi sui binari. Soprattutto stabilisce chi deve rimanere un semplice tender e chi non deve sincronizzare le proprie forze, mentre chi volesse far di testa sua viene semplicemente stritolato sui binari. La potenza complessiva di questo sistema è maggiore rispetto a quella di quando era meno maturo, ma certo che esso è fisicamente molto più instabile e richiederebbe un controllo maggiore. Che è tra l’altro ciò che chiedono a gran voce non solo i dirigisti, che si sono quasi estinti, ma pure schiere di liberisti veraci che non si sono bevuti il cervello.
Le locomotive tirano e poi spingono; il capitale originario produce l’industria e poi questa produce il Capitale propriamente detto; il mercato mondiale è fattore di industria, ne diventa il prodotto poi ancora fattore; il capitale finanziario è prodotto dal mercato, ingigantisce con l’industria, infine la controlla. Questi rovesciamenti storici sono frequenti nel maturare del capitalismo. Marx si dilunga per esempio sul commercio mondiale, che pre-esiste allo sviluppo industriale e quindi ne è un fattore, si tramuta in prodotto quando l’ingigantirsi dell’industria necessita di sbocchi esteri e poi, con l’autonomizzarsi del Capitale, ancora in fattore indispensabile allo sviluppo ulteriore (fenomeno che sta a fondamento della globalizzazione moderna)[72]. Non inutile, a questo proposito, apparirà il confronto con l’imperialismo della Gran Bretagna nel XIX secolo, la quale era una potenza egemonica ed eccedentaria e investiva il 50 % del proprio capitale lordo all’estero. Per quanto Lenin all’inizio di questo secolo la trattasse da imperialismo rentier, non vi erano paesi in grado di offrire le loro proprie eccedenze per le rendite inglesi. La «rendita» inglese era dovuta a ritorno di operazioni all’estero, ed era ancora da venire la formazione di un esteso proletariato da cui le borghesie locali potessero trarre direttamente plusvalore da devolvere al direttore mondiale del traffico di allora.
Si capisce bene, a questo punto, come l’obiettivo del FMI non sia mai stato quello di ridurre il debito dei vari paesi, ma quello di assicurare il servizio del debito. Considerando in blocco i paesi che ricorrono alle «cure» del Fondo, vediamo che essi si trovano nella curiosa situazione di ricevere in prestito il loro stesso denaro in cambio di un interesse e di una politica confacente al mantenimento dell’ordine economico mondiale.
Per questo, nei confronti dei paesi dell’Est Europa, il Fondo spinge per accelerare il ristabilimento della convertibilità delle monete locali. Questo obiettivo, realizzato dai paesi dell’Ovest in quindici anni dal 1945 in poi, permette infatti non solo l’integrazione di questi paesi nel sistema mondiale con la garanzia della compatibilità delle economie, ma soprattutto l’integrazione nel sistema mondiale del credito, l’unico in grado di smistare i capitali travolgendo le pulsioni individuali dei singoli capitalisti.
Ovviamente il sistema del credito è anche il sistema del debito e non c’è nulla di stupefacente o di sconveniente nell’accumulo di debito irrestituibile. Se trattiamo il Capitale non come mazzetta di denaro da sfogliare tra le mani, ma come rapporto sociale, vediamo che esso deve solo cambiarsi, in quanto D, in D’ tramite la produzione di M, cioè l’estorsione di plusvalore (Denaro – Merce – piùDenaro). Non ha nessuna importanza come ciò avvenga, purché vi sia garanzia che avvenga sul serio. Ora, nel mondo globalizzato, non contano più il tempo e lo spazio nelle transazioni. Un individuo o un paese può acquistare una merce e pagarla subito, può pagarla a rate e aggiungere un interesse per il tempo necessario a restituire il denaro, può non pagarla mai e pagare soltanto un congruo interesse per sempre. Tutte queste forme sono perfettamente equivalenti e non inficiano affatto il funzionamento del Capitale.
Le istituzioni nate da Bretton Woods servono a garantire che chi acquista merci o servizi tramite il sistema del credito (e non c’è più nessuno che faccia diversamente tranne il consumatore parcellare singolo) sia in grado di pagare gli interessi. E non c’è altro modo di farlo se non quello di garantire una costante estorsione di plusvalore dal proletariato locale, o un’ipoteca su risorse naturali, o facilitazioni per gli affari del creditore.
I meccanismi appena descritti hanno determinato, oltre alle istituzioni finanziarie e politiche internazionali, anche una specie di sostituto all’impotenza dell’ONU, una specie di superconsiglio politico mondiale, il cosiddetto G7, in cui sono riuniti i maggiori paesi imperialistici sotto l’egida degli Stati Uniti. Dal punto di vista formale, si tratta di pura e semplice rappresentanza, in quanto il Gruppo non ha potere esecutivo, ma dal punto di vista della sostanza è in quella sede che le istanze dell’imperialismo mondiale vengono recepite dal Fondo Monetario Internazionale. Insomma, si è formata una specie di imperialistica Assise Democratica Ristretta Per Il Bene Del Mondo, una Task Force globale per la permanente crisi del capitalismo moderno. Naturalmente, come in tutte le cose capitalistiche, il G7 si riunisce quando la crisi diventa acuta; non può scongiurarla, dato che non la vede, essendo essa il modo di essere attuale dell’intero capitalismo[73].
Nel 1980, per esempio, questa forza di pronto intervento si riunì per pilotare sul mercato finanziario la marea di petroldollari scaturita dalla precedente politica di aumento dei prezzi petroliferi (leggi drenaggio di plusvalore dai paesi industrializzati senza petrolio). Nello stesso tempo varò una politica di abbassamento del prezzo delle altre materie prime (leggi abbassamento del valore del capitale costante per i paesi industrializzati, ma anche peggioramento dei termini di scambio per i paesi con le miniere). Nei primi anni '80, allo scoppiare del debito internazionale dei paesi in via di sviluppo, operò per il suo scaglionamento e anche, nei casi più eclatanti, per l’estinzione d’ufficio (il debito del Perù, per esempio, era già scontato sul mercato, per insolvenza, al 6 % del suo valore iniziale), tutto senza intaccare i presupposti strutturali del debito stesso, come per garantirne l’eterna gestione.
I compiti della Banca Mondiale, nata con il FMI, dovrebbero essere definiti dal suo vero nome, che è Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo. In effetti il finanziamento dello sviluppo nel mondo è un eufemismo in quanto la banca investe in tutto, annualmente, una media di 20 miliardi di dollari, che è all’incirca il budget di spesa di una città come Hong Kong (l’ONU investe ancora meno: circa 6 miliardi di dollari). Complessivamente, dalla sua origine, la Banca Mondiale ha investito 400 miliardi di dollari odierni[74], soprattutto nel dopoguerra europeo, quindi non tanto per finanziare lo sviluppo del Terzo Mondo, come ora si crede che faccia, ma anche in questo caso soprattutto per integrare, attraverso la costituzione di poli nazionali moderni, l’economia locale a quella globale. Ovviamente gli interessi locali sono subordinati a quelli del capitale finanziario internazionale.
D’altronde, la stessa Banca non si è mai posta come istituzione pubblica concorrente con il capitale privato, bensì come agente della sua penetrazione nel Terzo Mondo attraverso nuclei di sviluppo sui quali innestarsi per crescere. Il suo statuto, infatti, prevede non tanto l’effettuazione di prestiti con risorse proprie quanto la gestione della raccolta di capitali privati, in genere presso catene di banche, e anche tramite l’emissione di obbligazioni sul mercato mondiale. La Banca Mondiale gestisce la meccanica del prestito, poniamo in dollari, ma il Fondo Monetario Internazionale, con il suo inevitabile diktat, garantisce che lo squilibrio creatosi nella bilancia dei pagamenti del paese che chiede il prestito sia solvibile. La garanzia consiste nel deposito di moneta locale contro dollari, con l’impegno di ritirarla entro un certo numero di anni. Il Fondo garantisce gli squilibri che deve creare per far fronte alle crisi, ma chiede garanzie a sua volta: vuole che gli si presenti un piano rigoroso e attendibile di controllo mirato dell’economia e sorveglia affinché venga applicato. Un piano di economia totalitaria, con buona pace dell’ubriacatura liberistica di mercato.
Risulta chiaro che le istituzioni internazionali scaturite dagli accordi di Bretton Woods e i loro programmi di aggiustamenti strutturali non sono volti alla trasformazione delle strutture economiche del Sud e dell’Est del mondo per consentire un loro benefico decollo produttivo, ma sono finalizzati unicamente all’applicazione di meccanismi in grado di garantire la redditività dei capitali occidentali eccedenti là investiti. Se così non fosse, una banca aggettivata con la roboante parola «Mondiale» e con compiti istituzionali tanto ambiziosi, non investirebbe direttamente soltanto un millesimo del PIL dei paesi industrializzati e avvierebbe l’indispensabile accumulazione locale. Ma non è «colpa» di una istituzione se ciò non si fa. Il fatto è che l’accumulazione originaria è già stata compiuta storicamente in altri paesi, e quelli giunti ultimi sulla scena dell’indipendenza e del mercato mondiale non possono più ripercorrere lo stesso tratto di storia. Devono per forza sottostare alle condizioni del Capitale mondiale, non importa dove esso abbia sede, se ancora si può parlare in questi termini nell’era della mondializzazione informatica.
In complesso, i Programmi di Aggiustamento Strutturale, insieme a uno sviluppo congeniale ai paesi prestatori ricchi, hanno distrutto l’economia di sussistenza producendo la distruzione delle radici sociali di enormi masse umane, ammassandole in agglomerati urbani miserabili o invivibili, imponendo i prodotti industriali e inserendole una volta per tutte nel ciclo capitalistico mondiale. Hanno prodotto, laddove sono stati imposti e attuati: 1) l’accrescimento della disoccupazione; 2) la riduzione dei salari; 3) l’aumento della dipendenza alimentare; 4) il deterioramento del sistema sanitario; 5) la contrazione delle spese per il sistema educativo; 6) il declino della capacità produttiva; 7) la crescita ulteriore del debito estero[75].
Tutto ciò non dipende da cattiva volontà, da prevaricazione imperialistica o da altri motivi che possano essere affrontati con banale moralismo. È ovvio che ogni capitalista vede in eventuali possibilità non sfruttate un’occasione per accrescere il proprio capitale, ma investirà soltanto quando il rischio sarà compatibile con le possibilità di alto guadagno. Ecco allora che l’investimento pubblico, mondiale o meno, è funzionale alla preparazione di un terreno fertile in grado di attirare capitali, aree con infrastrutture e popolazione pronta a farsi sfruttare in senso pienamente capitalistico. Possiamo in un certo senso essere d’accordo con l’«International Herald Tribune» (18 settembre 1998) quando scrive:
«Affermare che la globalizzazione ha causato la crisi attuale ha più o meno lo stesso senso che accusare la rivoluzione industriale per i deragliamenti che hanno avuto le ferrovie nei primi anni del loro funzionamento […]. Nessun altro sistema mai esistito assicura meglio l’allocazione delle risorse economiche di quanto non faccia il capitalismo del libero mercato».
Vero, solo che l’osservatore borghese non può aggiungere che l’allocazione capitalistica delle risorse è sì migliore di quella schiavistica o feudale, ma non ha più nessun senso già di fronte alle stesse potenzialità espresse da questo modo di produzione. Le potenzialità attuali, una volta che fossero liberate dalle catene capitalistiche, potrebbero sollevare l’intera umanità dai suoi problemi in pochissimo tempo. Il fatto è che proprio la libera allocazione delle risorse provoca gli scompensi fra le varie aree del mondo, anche localmente. Li si chiami distretti industriali nei paesi capitalistici maturi o poli di sviluppo nei paesi poveri, il meccanismo non cambia: è un fatto che, nell’epoca della centralizzazione del Capitale, l’attrazione di capitali in un punto li sottrae da un altro. E non è mai successo che vi sia la ricaduta generalizzata che tutti teorizzano in questi casi, anzi, il fenomeno moderno è quello di attrarre capitali e popolazioni in un’area a scapito di altre che diventano così cronicamente depresse. Questa è per esempio la storia antica della fascia appalachiana negli Stati Uniti, del Mezzogiorno in Italia o, più recente, dell’area intorno a Città del Messico[76].
La classe operaia della Turchia, del Venezuela, del Brasile, del Messico ecc. è chiamata a uno sforzo gigantesco per produrre, oltre al proprio sostentamento, il profitto per il capitalista locale, l’interesse per il sistema creditizio interno, la rendita per i proprietari interni, l’interesse per il capitale estero e, in caso di importazione di materie prime e manufatti, anche il profitto e la rendita per i capitalisti e i proprietari fondiari dei paesi sviluppati. La totalità delle esportazioni di un paese come la Turchia serve appena a coprire la gestione del debito estero. Eppure si tratta di un paese con 70 milioni di abitanti, con un’industria e una classe operaia piuttosto sviluppate, una borghesia intraprendente e poco incline all’asservimento.
Negli ultimi trent’anni, il carico debitorio dei paesi in via di sviluppo è costantemente aumentato. Di poco superiore ai 62 miliardi di dollari nel 1970, il debito a lungo termine non rimborsato raggiungeva, già nel 1980, i 481 miliardi di dollari. Nel 1996, il debito estero totale sfiorava i 1730 miliardi di dollari. Nel 1980 il credito del Fondo Monetario Internazionale nei confronti dei paesi in via di sviluppo ammontava a 12 miliardi di dollari: nel 1994, esso superava i 41 miliardi di dollari (dati della Banca Mondiale). Paradossalmente, i paesi poveri sono così divenuti, nel corso degli anni, esportatori netti di capitale a favore delle metropoli imperialistiche: oggi, il servizio del debito con l’estero supera ampiamente, di fatto, i nuovi afflussi di capitale (in forma di prestiti, investimenti e aiuti stranieri).
Si consideri un paese indebitato per 50 miliardi di dollari e obbligato a versare, in interessi, 5 miliardi di dollari l’anno ai Circoli finanziari di Londra e New York. Non in grado, pro tempore, di soddisfare all’impegno, il paese riceve, a puntello della propria bilancia dei pagamenti, altri 2 miliardi di dollari: i profitti derivanti dal rilancio dell’export potranno, in seguito, come d’augurio, indirizzarsi al servizio del debito. Il nuovo prestito non è allora, con tutta evidenza, che stretta al calappio usuraio: 1) perché il denaro anticipato da FMI e Banca Mondiale viene presto recuperato dai creditori istituzionali e commerciali; 2) perché, servendo i 2 miliardi a saldare esclusivamente parte degli interessi dovuti, il debito del paese aumenta del 4 %.
Il FMI ha, nelle sue politiche, piani di liberalizzazione dei mercati interni e propugna massicce privatizzazioni, ma molto spesso la privatizzazione è subordinata alla rinegoziazione del debito: depositato presso il Tesoro, il danaro ricavato dalla vendita delle aziende pubbliche più redditizie è in breve trasferito ai circoli finanziari di Londra o New York.
Vi sono paesi, come il Perù, che non riescono a sollevarsi a causa dei debiti esteri, nonostante un capitalismo abbastanza sviluppato e risorse naturali proprie (miniere, pesca). Dal 1990 750 000 lavoratori peruviani hanno perso il posto di lavoro. Secondo la Banca Mondiale, il 79,4 % della popolazione peruviana vive al di sotto della soglia di povertà, eppure, peggio che ai tempi di Marx che già lo faceva notare, non è la carenza di merci e capitali a produrre questa situazione, bensì la loro abbondanza. In Ecuador, la stessa povertà interessa il 40 % della popolazione complessiva e il 67 % dei contadini, mentre la Bolivia, ricca di risorse minerarie, non riesce ad utilizzarle per il decollo economico. L’Argentina è un paese ricco di risorse e di industrie, ma ha persino dovuto rinunciare alla sua indipendenza nazionale in campo monetario con l’adozione del dollaro come moneta di conto interno. Il Brasile, che è un gigante economico in confronto alle altre economie sudamericane, è stato messo in ginocchio dal repentino movimento di capitali seguito al ventilato pericolo di insolvenza russa:
«Il Brasile, che in un mese ha perso capitali per 25 miliardi di dollari, è vittima di un’ingiustizia particolarmente crudele […] esso e gli altri paesi latino-americani non meritano certo un discredito causato dalle difficoltà altrui […]. Quelle economie dispongono di buone basi, e non si può dubitare del loro radioso avvenire»[77].
Noi invece dubitiamo. Il radioso avvenire sarà frutto di una sempre più razionale «allocazione delle risorse» capitalistiche e il risultato non c’è bisogno di inventarlo, è sotto gli occhi di tutti. La programmazione da parte del FMI di un «miglioramento» delle condizioni di sfruttamento capitalistico, mentre crea, come abbiamo visto, isole di sviluppo utili soltanto alla valorizzazione del capitale internazionale e neppure allo sviluppo di quello interno[78], peggiora obiettivamente le condizioni della gran massa di diseredati che preme sulle nuove concentrazioni urbane, e non è strano che proprio nelle nuove metropoli vi siano state vere e proprie sommosse, con centinaia di morti, specificamente contro l’intervento del Fondo come per esempio in Tunisia nel 1984, in Venezuela nel 1989, in Marocco nel 1990, in Messico nel 1993, in Corea nel 1997, in Indonesia nel 1998, senza contare le innumerevoli rivolte che, se non provocate direttamente dall’intervento del FMI, sono esplose a causa della politica normale imposta ai governi dalla gestione perenne del debito.
In principio era il GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), ora defunto. Aveva 23 membri, tutti paesi ricchi. Questo organismo è stato sostituito dalla WTO (World Trade Organization) che ha 131 membri, quasi tutti paesi poveri. I suoi fondamenti erano l’apertura doganale e il libero scambio. I suoi sostenitori erano infatti persuasi che il libero scambio favorisse l’espansione del commercio e che questo, a sua volta, promuovesse la crescita produttiva. La proposizione rispecchia un dato di fatto ma è, come abbiamo visto con lo schema storico di Marx, falsa. Se è vero che il commercio estero è la fase positiva e crescente dell’accumulazione e se è altrettanto vero che il mercato mondiale forza e dilata lo scambio di merci influendo sulla produzione, non è vero che la promozione del commercio faccia crescere di per sé la produzione. Siamo alle solite: se quando piove gli uomini aprono l’ombrello, non è detto che aprendo l’ombrello si metta a piovere. Quando negli anni '60 in India si liberalizzò il mercato agricolo per decreto, il risultato fu l’espropriazione di decine di milioni di contadini e una diminuzione drastica della produzione alimentare. Essa aumentò nuovamente per mezzo di politiche dirigiste statali (indiane, russe e americane), non a causa del libero scambio.
Ciò è valso, su di un altro piano, anche per il GATT, tant'è che il tasso di crescita del commercio internazionale è passato dal 7 % degli anni '70 al 4 % degli anni '80, e ciò malgrado la riduzione delle tariffe e il ricorso alla liberalizzazione. D’altra parte i dati non dicono nulla di per sé. Chiunque può dimostrare che la crescita assoluta del commercio mondiale è un fatto eclatante, ma il dato di per sé non significa nulla. Infatti il dato significativo – anche per gli stessi borghesi – non è tanto la crescita assoluta della quantità di merci scambiate nel mondo, ma la stessa crescita in rapporto a quella della forza produttiva sociale. Occorre quindi mettere in rapporto l’incremento del commercio estero complessivo di merci con quello del Prodotto Interno Lordo dei maggiori paesi. Con questo criterio, e prendendo un periodo storico più lungo, vediamo che lo scambio mondiale non è poi cresciuto di molto: rappresentava il 10 % del PIL americano nel 1913 e il 20 % nel 1996; il 35 e il 40 % per quanto riguarda la Germania; il 35 e il 38 % per la Francia; il 45 e il 48 % per l’Inghilterra; il 30 e il 15 % per il Giappone. Come si vede, il commercio mondiale di merci, in relazione alla potenza produttiva, è praticamente quello del 1913, dato che è aumentato, nel caso più clamoroso dello 0,8 % annuo rispetto al PIL americano e addirittura diminuito nel caso del Giappone; nel caso di Germania, Francia e Inghilterra è andato quasi di pari passo. Il commercio mondiale di merci e servizi si è incrementato infinitamente meno di quello interno ai paesi industrializzati. Non così si può dire del mercato mondiale complessivo. Prendendo un periodo più vicino e più corto, quello dell’esplosione liberista reaganiana e tatcheriana, vediamo che dal 1980 al 1996 lo scambio mondiale in titoli e in valute è cresciuto in termini reali alla media del 25 % annuo, l’intermediazione bancaria dell’8 %, gli investimenti diretti all’estero del 7 %; ma lo scambio di merci è cresciuto solo del 4 % e il PIL del 2 %. Verifichiamo dunque che, mentre il commercio mondiale è cresciuto complessivamente meno dello 0,2 % annuo dal 1913, il mercato mondiale è cresciuto nello stesso periodo ad un ritmo decine di volte superiore (fonte dei dati: «The Economist»). Vulcano della produzione o palude del mercato? si chiedeva un nostro vecchio testo per rispondere: il capitalismo pretende che non ci sia l’uno senza l’altra.
La concezione borghese, che pone la distribuzione al primo posto, escludendo per motivi di classe i caratteri della produzione basata sull’estorsione di plusvalore, impedisce di scorgere la vera essenza dei cosiddetti mercati e fa credere a tutti che da essi, qualunque cosa siano, e non dalla produzione e dal commercio di merci possa sorgere la ricchezza. In altri termini, se questo è sempre stato l’atteggiamento della borghesia, oggi nei calcoli di sopravvivenza borghesi il salario non appare neppure più come presupposto, ma come risultato, accanto al profitto e alla rendita; esso è nient’altro che una «variabile dipendente» rispetto alla divinità dei mercati, alla quale si inchinano non solo i borghesi veri e propri, ma anche coloro che ancora dicono di fare gli interessi proletari.
Se è vero, com'è vero che ormai la produzione, con le sue merci, è un’appendice di questa incontrollabile giostra di capitali, è anche vero che la borghesia riesce a rendersi sempre meno conto della realtà in cui vive se s’immagina di poterla controllare persino meglio di un tempo. Se fosse così controllabile l’economia globale, e dato che l’obiettivo conclamato dei capitalisti è la crescita industriale, ci si spieghi come mai il PIL, cioè il valore prodotto ex novo in un ciclo annuale è fermo ad un asfittico 2 % mentre lo scambio sia di titoli che di valute esplode ad un ritmo del 25 % all’anno worldwide, globalmente, da almeno 15 anni. Non si può scientificamente sostenere che tutto ciò continuerà per altri 15 anni quando si sa che l’incremento del valore prodotto non potrà aumentare di granché in termini reali[79].
Se questa velleità di regolamentazione del libero scambio (ossimoro perfetto) avesse possibilità di realizzazione, ci si spieghi come mai il GATT rappresentava soltanto il 7 % del commercio mondiale. L’organismo non era affatto libero-scambista, né potrebbe esserlo in relazione a quanto detto riguardo agli istituti e agli scambi finanziari.
Siccome gli economisti non riescono a dare valore scientifico alle loro affermazioni e spiegano tutto con la concorrenza, ecco che essi devono risolvere il problema della formazione del valore attribuendola all’ambito in cui invece avviene la sua realizzazione, cioè alla circolazione. I paesi ricchi non intendevano allargare il GATT a quelli poveri per paura della concorrenza, dato che questi potevano vendere ma non acquistare; i paesi poveri vedevano nell’organismo un nemico che li danneggiava, in quanto i ricchi si mettevano d’accordo tra di loro escludendo tutti gli altri, che avevano bisogno delle loro merci ma le avrebbero volute a basso prezzo.
A conferma di ciò ricordiamo che nel 1975 il gruppo dei non allineati propose un programma di liberismo letterale su scala mondiale così articolato: 1) apertura dei mercati del Nord alle esportazioni del Sud; 2) miglioramento dei termini dello scambio per i prodotti agricoli tropicali e i prodotti minerari; 3) accesso facilitato al finanziamento internazionale; 4) provvedimenti antimonopolistici, atti ad agevolare il trasferimento di tecnologie. In modo reciso e unanime, il Nord del mondo rigettò questo progetto.
Il GATT era identificabile, quindi, come una organizzazione integralmente dedicata agli interessi dei paesi industriali e perciò delle imprese transnazionali che ben li rappresentavano: la lotta per l’abolizione delle tariffe e dei dazi (combattuta su posizioni proprie del pensiero economico neoclassico) non mirava, in realtà, che alla creazione di un ambiente adeguato allo sfruttamento della forza-lavoro e delle materie prime da parte delle multinazionali e alla rapida remunerazione dei capitali investiti.
La WTO, nata sulle ceneri del GATT il 1 gennaio 1995, ha realizzato le istanze sopra elencate, ma si è dotata di un arsenale di regole vincolanti, di meccanismi obbligatori di arbitrato e di un relativo sistema sanzionatorio. Paradossalmente, oggi gli stessi paesi che chiedevano una liberalizzazione degli scambi con il Nord, sono i più restii a liberalizzare le loro economie:
«Il mondo è cresciuto in tal modo che oggi si pongono, a livello globale, tutta una serie di problemi che necessitano risposte a livello globale. Il sistema è diventato molto sofisticato, la globalizzazione è andata più avanti di quel che si crede ma ciò non vuole dire che l’obiettivo sia il liberismo esasperato, anche perché l’80 % dei Paesi membri della WTO sono Paesi in via di sviluppo o economie in transizione che non accetterebbero mai un liberismo selvaggio»[80].
In effetti l’hanno già accettato assoggettandosi alle regole di questo liberismo (sempre appare la contraddizione in termini) dettate dagli organismi internazionali, e così adatte agli scopi della centralizzazione capitalistica per mano delle cosiddette multinazionali, per esempio eliminando ogni privilegio delle imprese locali nell’attribuzione di appalti pubblici, oppure stabilendo dei dispositivi di protezione per il ritorno alla casa madre degli investimenti, oppure ancora decretando che la soluzione dei contenziosi venga demandata alla stessa WTO, controllata non certo dalla parte più debole nel contenzioso stesso. In teoria, aderendo alla WTO, ci si priva di ogni controllo sugli investimenti e sui traffici realizzati da altri sul proprio territorio, ma in pratica il discorso vale ovviamente a senso unico: sarà molto difficile ad esempio per la Cambogia o il Mozambico aprire un contenzioso per impedimenti ai loro traffici sul territorio degli Stati Uniti, mentre il contrario sarebbe normale.
In tale contesto si perde anche la formale adesione al concetto di diritto borghese, in quanto lo Stato socio rinuncia alla propria giurisdizione storica per assoggettarsi ad una specie di lex mercatoria depositata fuori dai suoi confini e soprattutto a negoziazioni che avvengono sotto la pressione di paesi potentissimi, le cui industrie hanno un enorme potere di ricatto col solo fatto di negare o dirottare investimenti programmati. Ciò è di importanza estrema, dato che lo Stato, il comitato che dovrebbe gestire gli affari di tutta la borghesia nazionale, diviene «irresponsabile» di fronte al Capitale globale, il quale agisce tramite i nuovi organi sovrastatali che si è dato e per conto di borghesie più potenti.
La contraddizione con il persistere degli Stati nazionali è solo apparente. In realtà, la borghesia, che continua ad esistere nella veste differenziata delle borghesie nazionali, è completamente assoggettata al Capitale globale e rimane un fattore necessario per svolgere un servizio locale essenziale a quest'ultimo: il controllo della classe operaia nei singoli paesi.
La borghesia, espressa dalla primitiva accumulazione e diventata con il suo modo di produzione macchina motrice della storia recente (come dall’apologia materiale che ne fa il «Manifesto»), espropriata dal Capitale stesso, perdute le sue prerogative, resa inutile e sostituita da funzionari stipendiati, è ridotta al rango di miserabile sbirro:
«La maggior parte di coloro che pensano che la globalizzazione sia complessivamente una buona cosa non sono degli ideologi ma dei pragmatici. Credono che, per la maggior parte delle attività economiche, il mercato porti a risultati più efficaci e ad una maggiore prosperità di quanto non faccia il controllo governativo. Ma anche i più ardenti partigiani del libero mercato auspicano un ruolo per lo Stato: quello di fissare un quadro di regole che permettano ai mercati di svilupparsi»[81].
Così si confessa che il libero mercato, lasciato a sé stesso, si sopprimerebbe molto presto. Il Capitale totale, che specializza il ruolo dello Stato come strumento del dominio di classe, come razionalizzatore dell’anarchia sociale, mantiene le borghesie nazionali, ormai inutili e impotenti in quanto classe, come mantiene i poliziotti: per far rispettare le regole che detta in quanto anonima potenza. Quando tra gli stessi borghesi incominceranno ad apparire elementi non più in grado di sopportare questa loro insulsa condizione, appariranno anche i primi transfughi di classe. Come dice Marx nel «Manifesto», essi daranno, insieme con la ricomparsa dello scontro di classe frontale, il segnale sicuro che la rivoluzione sociale si è messa nuovamente, e forse definitivamente, in moto.
27 Ottobre 1999
Notes:
[prev.] [content] [end]
Per esempio il Sabatini Coletti:
«Fenomeno di integrazione e di interdipendenza delle economie e dei mercati internazionali, causato dalle più sofisticate tecniche informatiche e di telecomunicazione». [⤒]Soros è uno che può permettersi di citare Marx dicendo che il capitalismo è la peggiore minaccia per il Capitale («The capitalist Threat», in «The Atlantic Monthly», febbraio 1997, volume 279, n. 2, pagg. 45–58). [⤒]
«Le Monde Diplomatique», ottobre 1998. [⤒]
Hilary Clinton presentò un programma di riforma sociale particolarmente mirato alla sanità, che negli Stati Uniti è una mostruosa macchina capitalistica privata. Il programma fu sconfitto dalle lobby assicuratrici e farmaceutiche prima ancora di essere votato. [⤒]
Per una disamina approfondita del concetto, applicabile anche al succedersi dei modi di produzione, vedere la parte introduttiva del testo «Dottrina dei modi di produzione» (ed. Quad. Int.) dove, sulla base del principio di ricorrenza di Peano e Poincaré, si spiega perché la Sinistra traduca la dottrina dell’invarianza di Marx nello schema n + 1. [⤒]
Sulla dinamica storica del capitalismo verso il dominio totale, cfr. K. Marx, «Il Capitale», Libro I, Capitolo VI inedito, ed. La Nuova Italia. [⤒]
Ricordiamo che il termine rivoluzione può essere usato in senso stretto per indicare l’azione rivoluzionaria, l’insurrezione, il movimento sociale che distrugge l’apparato di potere della classe dominante; ma non va mai dimenticato che la catastrofe rivoluzionaria, l’Ottobre Rosso, tanto per intenderci, è preparata in lunghi periodi di rivoluzione in senso lato, durante i quali si accumulano in modo continuo le contraddizioni che vengono sciolte in modo discontinuo solo in certi momenti. Con una estrema sintesi diciamo diremo che un Lenin (nome proprio che usiamo come formula) fu il prodotto della rivoluzione in senso lato e che proprio per questo poté essere il fattore della rivoluzione in senso stretto. [⤒]
V. I. Lenin, «L’imperialismo», «Opere Complete», Editori riuniti, pag. 301. [⤒]
«Sussunzione reale del lavoro al Capitale» si può leggere anche come «dominazione reale del Capitale sul lavoro» oppure come «dominazione reale del Capitale sulla società». [⤒]
V. I. Lenin, «L’imperialismo» cit. pag. 301. [⤒]
V. I. Lenin, «L’imperialismo» cit. pag. 302. [⤒]
A. Bordiga, «Scienza economica marxista come programma rivoluzionario», Ediz. Quaderni Internazionalisti, pagg. 80–81. [⤒]
K. Marx, «Il Manifesto del Partito Comunista», «Opere Complete», Editori Riuniti, vol. VI pag. 491. [⤒]
La Corea dipende dalle importazioni per il 90 % dei generi alimentari. [⤒]
K. Marx, «Grundrisse», Einaudi, vol. II, pag. 1106. [⤒]
Cfr. K. Marx, «Il Capitale», Libro I, Capitolo VI inedito, ed. La Nuova Italia, pagg. 107–110. [⤒]
K. Marx, «Il Capitale», vol. III Editori Riuniti pag.520. [⤒]
K. Marx, «Il Capitale», vol. III Editori Riuniti pag.520. [⤒]
Cfr. il nostro «Quaderno» n. 1, «Crisi del capitalismo senile», cap. 8. [⤒]
Cfr. il nostro «Quaderno» n. 9, «Dinamica dei processi storici – Teoria dell’accumulazione». [⤒]
Tra il 1993 e il 1995 le prime 100 imprese del mondo hanno aumentato il loro giro d’affari all’estero del 26 % aumentando il numero degli occupati, sempre all’estero, solo del 4 %; inoltre hanno ridotto il numero complessivo degli occupati del 4 % a fronte di un aumento generalizzato della produzione (cfr. «Il Manifesto» del 7 gennaio 1999). [⤒]
Ovviamente, se tale processo fosse meccanico e continuo, il capitalismo non ci sarebbe già più. Marx infatti invita ad un certo punto il lettore del Capitale a chiedersi come mai il capitalismo riesca invece a sopravvivere nonostante le sue tremende contraddizioni. [⤒]
Nel paragrafo precedente abbiamo parlato di calo del tasso e della massa in relazione al diagramma, che indica solo la produzione di plusvalore in certe condizioni e non nel tempo. Diciamo che nel tempo sale la massa e la chiamiamo «assoluta» in quanto l’aumento della forza produttiva sociale produce un aumento del plusvalore misurato nell’anno contabile presentato dalle statistiche. Siccome però il ciclo di valorizzazione si accorcia notevolmente, diciamo che, a parità di massa ottenuta nel ciclo annuo, è chiaro che in un ciclo accorciato a tre mesi la massa è quattro volte meno. [⤒]
Parlare di finanza tedesca (oppure olandese, veneziana, fiorentina o lombarda) è un eufemismo in quanto il sistema di traffici dei secoli XIV-XVI obbligava ad essere già allora «globali». La via delle banche antiche nella city di Londra si chiama ancora Lombard Street. La Lega Anseatica aveva filiali in tutta Europa, dalla Norvegia a Napoli, da Londra a Novgorod, mentre i grandi mercanti-banchieri tedeschi riuscivano persino ad influenzare la politica imperiale e papale, intrecciando i loro interessi con l’allora potentissima Venezia. Questa rete d’interessi si basava quasi esclusivamente su di un efficiente sistema di lettere credito e di cambio. Si parlava persino una specie di lingua franca internazionale. [⤒]
Cfr. J. Browring – S. Reiss, «Vocabolario della globalizzazione», Atlantide Editoriale 1998. [⤒]
S. Baio – G. Ferramonti, «Oltre la Banca: la finanza virtuale globale», ed. Spirali 1995. [⤒]
Nell’ultima pagina. Il testo della Sinistra Comunista è interamente dedicato alla teoria della rendita e a tutti i suoi aspetti modernissimi (ed. Quaderni Internazionalisti). [⤒]
«Vulcano della produzione o palude del mercato?» Ed. Quaderni Internazionalisti, cap. 35, «Sovrapprofitto e rendite». Un’obiezione potrebbe essere: e come mai succede che il monopolio, per esempio dell’energia elettrica, produce invece dei prezzi più bassi? Non è una contraddizione della legge? Quando lo Stato facilita l’accesso all’energia, significa semplicemente che sarà l’industria a beneficiare di prezzi correnti al di sotto del valore sociale; in questo caso lo Stato monopolista trasferisce plusvalore da un settore all’altro della società, per esempio tramite un’alta tassazione della benzina o dei tabacchi ecc. [⤒]
Siccome la produttività è altissima e siccome bastano pochi operai a produrre tutto il plusvalore necessario alla società, questa deve provvedere in qualche modo alla sua sovrappopolazione relativa, con lavori fasulli o con ammortizzatori sociali, in modo che non scoppino rivolte. Marx: guai a quella società che, come Roma Antica, invece di sfruttare i suoi schiavi dovesse giungere a mantenerli soltanto. [⤒]
Ovviamente la differenza è invece grande in rapporto al Prodotto Interno Lordo a causa della sproporzione fra le due economie: la spesa sociale negli Stati Uniti è il 10 % circa del PIL (1997), mentre in Italia rappresenta il 25,7 % (1998). In Inghilterra, nonostante il tanto sbandierato tatcherismo, la spesa sociale è al 28 % (1998). La protezione sociale pesa su ogni americano per 5700 dollari all’anno, mentre su ogni italiano e inglese pesa per circa 4300 (tutti i dati sono dei Ministeri del Tesoro americano e italiano, meno la percentuale inglese, che è un dato del sindacato CISL). [⤒]
Guido Rossi, economista e teorico dell’economia di mercato (è stato alla guida di Montedison, Consob, Telecom) disse in un’intervista: «D’Alema e Ciampi devono rendersi conto che il libero mercato non esiste in natura, è una creazione del diritto, quindi della politica legislativa. La crisi russa l’ha ampiamente dimostrato. Tocca alla politica dare un mercato moderno a questo paese» («La Repubblica» del 13 gennaio 1999, pag. 7). [⤒]
Non stupisca questo rapporto: dal XVII secolo in poi il mondo capitalistico ebbe un’esplosione demografica tale che risulta persino difficile disegnarne il grafico su coordinate a scala normale, mentre nel resto del mondo la popolazione cresceva ancora a ritmi pre-mercantili. Al tempo di Marx (1850) il mondo «sviluppato» aveva 350 milioni di abitanti e il resto 900 milioni. La nostra abitudine a pensare in termini di masse sterminate del cosiddetto Terzo Mondo risale solo all’ultimo dopoguerra, quando il mondo sviluppato aveva raggiunto 850 milioni di abitanti (diventati oggi solo un miliardo) contro un miliardo e mezzo di tutti gli altri paesi (diventati oggi ben cinque miliardi). [⤒]
In N. Bucharin ed E. Preobraženskij, «L’ABC del comunismo», ed. Quaderni Internazionalisti. [⤒]
Ovunque – Marx spiega nel trattare il crudo argomento dell’accumulazione originaria – proprio lo Stato, come violenza concentrata e organizzata della società, ha favorito il trapasso dal feudalesimo al modo capitalistico di produzione. L’intervento statale in economia non è, perciò, fatto d’oggi, né del recente passato, ma rimonta a secoli e secoli addietro, segnando finanche tutta l’epoca «felice» del laissez-faire, laissez-passer (celebre formula di autore non loffio: quel Jean Claude Marie Vincent de Gournay da cui tanto apprese l’allievo Turgot). [⤒]
K. Marx op. cit. pagg. 518–520. Detto altrimenti:
«In generale, il capitalismo ha la proprietà di staccare il possesso del capitale dal suo impiego nella produzione, di staccare il capitale liquido dal capitale industriale e produttivo, di separare il rentier, che vive soltanto del profitto tratto dal capitale liquido, dall’imprenditore e da tutti coloro che partecipano direttamente all’impiego del capitale. L’imperialismo, vale a dire l’egemonia del capitale finanziario, è quello stadio supremo del capitalismo, in cui tale separazione raggiunge dimensioni enormi»
(V. I. Lenin, «L’imperialismo, fase suprema del capitalismo», Newton Compton, pag. 84.) Ovvero:
«L’oligarchia finanziaria, che in poche mani concentra immensi capitali e li esporta e investe da un paese all’altro, fa parte integrante della stessa classe imprenditrice, il centro della cui attività si sposta sempre più dalla tecnica produttiva alla manovra affaristica. La produzione di ultra profitti ingigantisce man mano che ci si allontana dalla figura del capo d’industria, che per competenza tecnica arrecava innovazioni socialmente utili. Il capitalismo diviene sempre più parassitario, ossia invece di guadagnare e accumulare poco producendo molto e molto facendo consumare, guadagna e accumula enormemente, producendo poco e soddisfacendo male il consumo sociale»
(A. Bordiga, «Proprietà e capitale», Ed. Quaderni Internazionalisti, pag. 123). [⤒]Cfr. «Punti democratici e programmi imperiali, ora in America», ed. Quaderni Internazionalisti. [⤒]
Cfr. nostri lavori: «La crisi storica del capitalismo senile», «Guerre stellari e fantaccini terrestri», «La guerra del Golfo e le sue conseguenze», «I comunisti e la guerra balcanica». [⤒]
La lebbra borghese rimane quella, solo più estesa e maligna di quanto Marx, Engels, e Lenin persino, ebbero a conoscere: «Nel paese più ‹commerciale› del mondo [l’Inghilterra] i profitti dei rentiers superano di cinque volte quelli del commercio estero! In ciò sta l’essenza dell’imperialismo parassita» (V. I. Lenin, op. cit. pagg. 127–128). [⤒]
La metafora sugli «Stati albergatori» è dell’Istituto di economia di Kiel, in Germania. [⤒]
K. Marx, «Il Capitale» II, Editori Riuniti, pag.108. [⤒]
K. Marx, «Il Capitale» II, Editori Riuniti, pagg. 108–109. [⤒]
K. Marx, «Il Capitale» II, Editori Riuniti, pagg. 108–109. [⤒]
Come abbiamo già visto a proposito dell’estensione del monopolio anche ai rami non legati alla proprietà del suolo, ciò può valere non solo per le società ma anche per gli Stati. [⤒]
Per fare un esempio: consolidata la propria posizione sul mercato di origine (a scala continentale), le corporation nordamericane assunsero subito, a cavallo fra il XIX e il XX secolo, carattere mondiale: alla data 1914, negli Stati Uniti gli investimenti esteri diretti, buon indice di tendenza imperialistica, equivalevano al 7,3 % del PNL, quota addirittura superiore a quella 1992 (cfr. E. Kapstein, «We are US: the myth of the multinational», «The National Interest», n. 26, 1991–92, pagg. 55–62. [⤒]
UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo) 1996. [⤒]
Tutti questi dati sono di fonte UNCTAD, 1994. [⤒]
Questo sistema, fra l’altro, permette complessi giochi di sovra e sotto-fatturazione, di scambio fittizio di materie prime e manufatti, di finte esportazioni, di spostamenti di attività ecc. con i quali, all’interno delle holding, è possibile speculare sulle valute, sulle differenze dei sistemi fiscali, sull’accesso a finanziamenti agevolati nei diversi paesi, permette insomma tutta una serie di manovre estremamente lucrative e assolutamente incontrollabili dalle autorità statali. Un esempio soltanto: gli swaps sono accordi fra aziende di paesi diversi che si scambiano titoli o finanziamenti a tasso fisso o variabile a seconda dei vantaggi che maturano nel tempo a causa delle variate condizioni di credito nei diversi paesi: è evidente che una holding internazionale, può erigere a sistema permanente, programmato dal centro, questo tipo di scambio fra le sue filiali o consociate. [⤒]
Cfr. «Fortune», 5 agosto 1996. [⤒]
UNCTAD, «Programme on transnational corporations», 1993. [⤒]
K. Marx, «Il Capitale» III, Editori Riuniti pag.110. [⤒]
La traduzione comunemente usata: «diminuzione del salario al di sotto del suo valore» non ha senso compiuto, in quanto se il salario diminuisce, quello è il suo valore. [⤒]
Vi sono degli osservatori, tra gli stessi borghesi, che attribuiscono agli Stati Uniti molta più volontà machiavellica e planetaria di quanto questo pur strapotente paese non riesca effettivamente a mettere in pratica. La politica americana a volte è goffa e contraddittoria, a volte è di un’ingenuità poco credibile, a volte è sfacciatamente pianificata dalla Segreteria di Stato con le lobby economiche, ma la sua forza non sta tanto nella presunta volontà di ottenere sempre e comunque un certo risultato quanto il raggiungimento di esso attraverso il normale decorso delle spinte economiche e politiche molecolari dovute all’esuberanza di quel particolare paese. Nel nostro «Quaderno» sul capitalismo senile, in quello sulla crisi dell’Est, in quello sulla Guerra del Golfo, nella nostra Lettera n. 30 (intitolata 10 anni) ecc. ci siamo occupati di questo aspetto. [⤒]
«Ce monde qui nous attend», Grasset, Paris, 1997. [⤒]
Almeno sino al 1991. Dal 1973 al 1992, il prodotto interno lordo giapponese è aumentato del 3.7 %, contro l’8.9 % del decennio 1960–69: il rallentamento statunitense, a partire dal 1973, non è stato tanto drastico. Per molti analisti borghesi, il tasso di crescita potenziale del Giappone non supera, attualmente, il 2 % (incremento possibile, peraltro, solo con un’elevatissima quota di investimenti, quasi doppia rispetto a quella degli Stati Uniti). [⤒]
Il Giappone è il paese più esposto di tutti; il Ministero delle Finanze era convinto che il sistema bancario avesse crediti inesigibili per 210 miliardi di dollari, mentre in effetti, e lo si seppe dopo un controllo a crisi scoppiata, l’esposizione era di 600 miliardi (quasi l’ammontare del PIL italiano). [⤒]
Va detto che non è necessario stampare biglietti di banca per creare moneta. Nel sistema del credito, attraverso vari titoli, vi è spontanea creazione monetaria quando il mercato lo richieda, e così è successo al dollaro. Solo che in un sistema chiuso la creazione monetaria è controllabile dallo Stato, mentre in un sistema aperto nessuno può controllare. [⤒]
Che il fenomeno dei flussi finanziari verso l’America sia dovuto al fatto che «piove sul bagnato» o che sia voluto dal governo americano, non ha importanza e non lo sapremo mai. Un flusso del genere era stato possibile con la crisi petrolifera, quando la decuplicazione del prezzo del greggio aveva provocato un gigantesco drenaggio di plusvalore dai paesi industrializzati verso i paesi arabi, i quali non potendo ovviamente utilizzare quella massa enorme di capitali, li dirottavano verso le banche americane e inglesi, tramite le quali venivano finanziati investimenti a basso costo. Per di più le riserve americane vedevano decuplicato il loro valore e le Sette Sorelle di allora, di cui sei erano americane, commercializzavano la quasi totalità dei prodotti petroliferi, i cui profitti erano ovviamente da calcolare in percentuale sui prezzi decuplicati. [⤒]
Jean Marc Sylvestre, «Retrospettiva del 1998», Catena TV Histoire, 4 settembre 1998. [⤒]
Autori D. Roos, J. P. Womack, D. T. Jones, editore Rizzoli. La prefazione era di Giovanni Agnelli e la Fiat l’aveva distribuito ai suoi dirigenti. [⤒]
Nel corso della crisi, il Sindacato dei Petrolchimici di Singapore (e laggiù dire «sindacato» significa dire Stato più che da noi), in un documento dedicato alle sfide della globalizzazione, affermava:
«Forti relazioni trilaterali fra governo, impiegati e sindacati sono fattore essenziale per il sistema di relazioni industriali. Questo fattore ha aiutato a forgiare il consenso introducendo nel paese un completo ventaglio di politiche economiche per la ristrutturazione. Dal rapido passo del cambiamento ci si aspetta però un più grande stress nelle relazioni e nell’intero sistema. D’altronde, il mutevole profilo professionale richiesto alla forza-lavoro [a causa delle ristrutturazioni] coinvolge la direzione dei sindacati e, a lungo termine, la forza del movimento sindacale; per cui un buon rapporto trilaterale fra le parti necessita di forti ed effettivi partners»
(«Report by Chemical Industries Employees Union of Singapore», Shell Employees Union, presented to the First ICEM-A/P Regional Conference, 11–12 novembre 1997). [⤒]A. Bordiga, «Il corso del capitalismo mondiale nella esperienza storica e nella dottrina di Marx», Edizioni Il Partito Comunista 1991, pag. 42. [⤒]
Fonte: UNCTAD, 1993 (nostra elaborazione). [⤒]
Fonte: FMI, 1975 (nostra elaborazione). [⤒]
Il sovrapprofitto in controtendenza è spiegato in K. Marx, «Il Capitale», libro III cap. X (ogni merce non viene venduta al suo peculiare costo di produzione ma con riferimento al prezzo di produzione globale). [⤒]
Al Dollaro sono rimaste ancorate tutte le valute dell’Asia Sud-orientale fino alla crisi, alla quale ha resistito soltanto la Cina, che è riuscita a non svalutare lo Yuan. [⤒]
V. I. Lenin, «L’imperialismo», Newton Compton, pag. 88. [⤒]
È significativo che, nella riunione di Casale del novembre 1960 («Introduzione generale», Il programma comunista n. 15) Bordiga sottolinei la mancanza di un lavoro sulla «teoria delle guerre in tempo capitalista e imperialista» in relazione alle masse colonizzate. Evidentemente si riteneva importante affrontare non tanto una generica teoria della guerra, già presente nel corpo marxista, quanto una integrazione specifica per l’epoca imperialistica. Oggi sarebbe necessario un lavoro in relazione all’assetto capitalistico mondiale. [⤒]
V. I. Lenin, «L’imperialismo», Newton Compton, pag. 88. [⤒]
V. I. Lenin, «L’imperialismo», Newton Compton, pag. 88. [⤒]
La produttività dell’industria tedesca di punta è tra le più altre del mondo, ma la struttura sociale rigida rende l’intero sistema poco produttivo: in Germania lavora la metà della popolazione a salari altissimi, mentre per esempio in Italia lavora poco più di un terzo, a salari bassi e a prodotto lordo pro capite paragonabile. Il governo tedesco lo sa benissimo e infatti sta cercando di porre riparo; il ministro del tesoro Eichel, per esempio, ha già annunciato un piano di rientro «finanziario» in otto anni per riconquistare la competitività tedesca intaccata. Anche questa è globalizzazione. [⤒]
Le cifre sul costo dell’ostpolitik tedesca dopo il crollo dell’URSS variano moltissimo da fonte a fonte e oscillano tra i 150 e i 200 miliardi di dollari, pari al 40 % dell’export annuale tedesco. L’Economist valuta in 70 miliardi l’investimento (prestiti, agevolazioni, importazioni a prezzo politico) verso la sola Russia fino al 1996. [⤒]
Infatti, in Marx, la questione si pone storicamente, come sempre. Egli dice: 1) il commercio estero è la base per l’infanzia del capitalismo e il capitale d’interesse preesiste a quello industriale; la scoperta dell’America fa esplodere positivamente mercati e capitali; 2) ora, a capitalismo sviluppato, il commercio estero è un prodotto dell’industria stessa
«non è il commercio a rivoluzionare l’industria ma questa a rivoluzionare continuamente quello»
(«Il Capitale» cit., vol. III cap. XX pag. 422); 3) in Marx la sequenza del sistema è: Stato, commercio estero, mercato mondiale; nell’epoca in cui masse enormi di capitali si agitano freneticamente sul mercato mondiale in cerca di valorizzazione, e in cui interesse e profitto si confondono,
«il saggio di profitto è consolidato dall’influenza molto maggiore che il mercato mondiale, indipendentemente dalle condizioni di produzione in un paese, esercita sulla fissazione del saggio d’interesse»
(ibid. cap. XXII pag. 464), quindi il capitale mondiale vagante ridiventa fattore dell’industria là dove riesce a fissarsi, altrimenti l’industria chiude. [⤒]Alcuni ritengono che non si possa parlare di crisi permanente. Dipende da cosa si intende. Engels ne parla e Trotzky riprende l’argomento. Il fascismo e poi il keynesismo sono determinati dalla necessità di dare una risposta permanente alla crisi, occorre perciò chiedersi quale sia la determinazione permanente di questa necessità. È un fatto che da mezzo secolo viviamo in un capitalismo perennemente in camera di rianimazione; se fossero staccate le flebo del totalitarismo economico, esso creperebbe subito. [⤒]
Nel 1997 essa ha investito direttamente solo 7 miliardi di dollari. Fonte: Banca Mondiale. [⤒]
Elenco stilato dal Tribunale Internazionale dei Popoli, verdetto di Tokio del 1993. [⤒]
Nella nostra «Lettera ai compagni» intitolata «Padania e dintorni» vi è un’analisi dettagliata sui distretti industriali italiani e sulle ripercussioni politiche nell’epoca della centralizzazione del Capitale (ora nel volume Il 18 brumaio del partito che non c’è, raccolta di tutte le Lettere di analisi della situazione italiana). [⤒]
Joseph Stigliz sull’«International Herald Tribune», 19 settembre 1998. [⤒]
Anche in questo caso non si può parlare di ingiustizia particolare, perché il capitale interno non si distingue più da quello internazionale. Ogni capitalista è parte di un ingranaggio globale e non può più dedicarsi all’accumulazione «nazionale» di capitale. [⤒]
Una curiosità per il lettore: un simile andamento porterebbe ad uno scambio di capitali giornaliero per una cifra pari a cinque o sei volte il prodotto attuale annuo degli Stati Uniti. [⤒]
Da un’intervista al direttore del WTO Ruggiero, su «Il Sole-24 ore» del 16 maggio 1998. [⤒]
Reginald Dale, sull’«International Herald Tribune» del 28 ottobre 1998. [⤒]
